
Articoli filtrati per data: Settembre 2016
Lui è LILLO.
 Lillo è un cane da caccia di un paio di anni. E’ comparso un giorno, dal nulla, nella piazza di un paesino della Sardegna e dopo pochi giorni è finito in canile dove però ha iniziato a dare segni di insofferenza. Cerca urgentemente una casa, preferibilmente con giardino e qualcuno disposto a far con lui lunghe passeggiate.
Lillo è un cane da caccia di un paio di anni. E’ comparso un giorno, dal nulla, nella piazza di un paesino della Sardegna e dopo pochi giorni è finito in canile dove però ha iniziato a dare segni di insofferenza. Cerca urgentemente una casa, preferibilmente con giardino e qualcuno disposto a far con lui lunghe passeggiate.
Va d’accordo con i cani femmine, mentre con i maschi va a simpatia.
E’ adottabile in tutto il nord Italia previo controllo preaffido e compilazione di un modulo di adozione.
Per informazioni potete contattare Bianca al numero 380.3130298
Lei è GIOIA.

 Gioia è una cagnetta di piccola taglia di circa un anno.
Gioia è una cagnetta di piccola taglia di circa un anno.
Va d’accordo con cani maschi e femmine e adora le coccole e il contatto umano.
E’ stata salvata da un canile lager e ora aspetta la sua famiglia in una pensione in Lombardia, regione in cui verrà affidata. Per informazioni potete contattare l’associazione Una luce fuori dal lager scrivendo una e-mail all’indirizzo: canilisaronno@gmail.com o telefonando al numero 333.9521373 oppure 338.1658329
Ecco MILLY.
 La povera Milly a soli cinque mesi ha già cambiato tre stalli: tutti gli altri mici hanno trovato casa mentre lei ancora aspetta la sua famiglia. E’ energica, tenera ed abituata a convivere con i cani. E’ sana e vaccinata; si trova a Torino ed è adottabile in città e provincia previo controllo preaffido e firma del modulo di adozione.
La povera Milly a soli cinque mesi ha già cambiato tre stalli: tutti gli altri mici hanno trovato casa mentre lei ancora aspetta la sua famiglia. E’ energica, tenera ed abituata a convivere con i cani. E’ sana e vaccinata; si trova a Torino ed è adottabile in città e provincia previo controllo preaffido e firma del modulo di adozione.
Per proporsi, potete contattare Associazione Micio Villaggio inviando una e-mail all’indirizzo: miciovillaggio@gmail.com oppure telefonando ad Antonella al numero 339.8108751
Loro sono NINA e PINA e hanno circa un anno.
 Fino a qualche settimana fa vivevano in un terreno in cui dovevano far la guardia e il loro papà, come è evidente, era un bellissimo dobermann. Ora si trovano al canile della Muratella (RM) e cercano famiglia, preferibilmente in coppia e non alla prima esperienza con i cani. La loro matricola è 1656/16 e 1657/16. Per informazioni potete contattare Francesca Bucci al numero: 340.1706776 oppure il numero “adozioni”: 349.3686973
Fino a qualche settimana fa vivevano in un terreno in cui dovevano far la guardia e il loro papà, come è evidente, era un bellissimo dobermann. Ora si trovano al canile della Muratella (RM) e cercano famiglia, preferibilmente in coppia e non alla prima esperienza con i cani. La loro matricola è 1656/16 e 1657/16. Per informazioni potete contattare Francesca Bucci al numero: 340.1706776 oppure il numero “adozioni”: 349.3686973
Lui è ZAZZA.


Zazza è stato letteralmente buttato in canile insieme alla sorella a solo un mese di età. Ora di mesi ne ha tre ed è rimasto solo in gabbia. Si stima per lui una taglia media da adulto. Si trova in Sicilia, ma si affida in Piemonte, Lombardia e regioni limitrofe previa compilazione di un questionario reperibile sul sito dell’associazione Cani Sciolti e successivamente si chiede alla famiglia di andare a conoscerlo presso la sede dell’associazione in provincia di Torino.
Per ulteriori informazioni potete chiamare Antonella al numero 340.8368295 oppure Ester al 347.8059303
Lui è nonno PIPPO.
 Pippo vive ad Amatrice e si è trovato a vagare da solo tra le macerie dopo il terremoto. Al momento gli è stata donata una cuccia, ma si spera trovi una famiglia prima che arrivi la neve. E’ adottabile in tutto il centro nord previo colloquio preaffido. Per informazioni potete contattare il numero: 392.7015986
Pippo vive ad Amatrice e si è trovato a vagare da solo tra le macerie dopo il terremoto. Al momento gli è stata donata una cuccia, ma si spera trovi una famiglia prima che arrivi la neve. E’ adottabile in tutto il centro nord previo colloquio preaffido. Per informazioni potete contattare il numero: 392.7015986
Glauco faceva l’impiegato di magazzino. Ci può essere un lavoro più tedioso e riluttante dell’impiegato di magazzino?
Sveglia alle sei e trenta, colazione, bacio alla fidanzata che se la dorme soave. Puntata al bagno, acqua in faccia, vestiti indosso, colazione, salto sul terrazzo a respirare l’aria mattutina. Anche d’inverno, quando la brezza tagliente di dicembre o gennaio penetrava nelle ossa. Aveva bisogno di guardare il panorama, Glauco.
La loro casa si affacciava su un grande campo di grano. La strada che lo costeggiava era stretta, poco trafficata, una porzione d’asfalto che cercava di emergere nella vastità di quel giallo misto a verde sul quale, in estate, regnava un tramonto mozzafiato all’ora di cena.
Lavorava da otto anni alla Grar, piattaforma di stoccaggio per le merci in procinto di essere trasportate su gomma verso tutti i porti d’Italia, e da lì verso i mercati americani e asiatici. Distava circa una quindicina di chilometri da casa e la strada per arrivarci non era delle migliori. Dissestata in parte, con grandi voragini di asfalto sgretolato che in autunno, con le prime piogge, divenivano piscine.
Condivideva l’ufficio con altri tre colleghi, in quello confinante c’erano invece Diana, Sara e Lorenza. Tre arpie.
-Cioè tu hai dato conferma per lo stoccaggio dei tubi da 5 quando avevo chiesto espressamente di aspettare lo spostamento di quelli da 2?-
Incalzavano, sconquassavano, sentenziavano.
-Veramente ieri Sara mi ha detto il contrario.-
-Una volta su questi documenti oltre alla firma mettevamo anche una data… sono quindici anni che facciamo così!-
Glauco stavolta apponeva la data, perché mettersi a discutere era inutile.
Le giornate trascorrevano così. Tanto lavoro, trambusto ancor di più.
Le voci dei trasportatori che in pettorina fosforescente scendevano dai camion e facevano il loro ingresso nel magazzino schiamazzando e dando direttive per il carico, rimbombavano all’interno del grande capannone.
Poi verso le dieci arrivava l’agognata pausa caffè. Sovente Glauco non si prendeva quei quindici minuti perché aveva necessità di caffeina, ma per togliere testa e fisico da quella sorta di pressa dentro cui, anno dopo anno, era finito.
Quella pausa corrispondeva all’alzarsi della sua fidanzata.
-Il solito inferno… ti sei appena alzata?- interrogava Glauco in una interlocutoria telefonata che sembrava fatta più per contratto che per voglia.
Il titolare non c’era quasi mai. Arrivava, buttava lì anche lui un paio di leggi non scritte - tanto per gradire -, e girava i tacchi. Ma, per alimentare lo stress, le te arpie andavano benissimo.
Sembrava non andasse mai bene nulla all’interno di quel magazzino, qualsiasi cosa si facesse. Il pizzetto iniziava a macchiarsi di qualche pelo bianco, il sonno era disturbato, al sorgere del sole lo pervadeva un’ansia sempre più marcata, gli occhi erano veramente lo specchio dell’anima.
Glauco era l’eletto anche per le mansioni esterne. Ritirare documenti, consegnare liste.
Di frequente anche per cose che non c’entravano nulla col suo lavoro.
Un giorno aveva dovuto accompagnare il titolare dal medico. Forse aveva disimparato a guidare?
Glauco prese possesso della macchina aziendale e gli fece da autista. Attese due ore prima che lui entrasse. E nessuno dei colleghi mandava avanti ciò che lui aveva dovuto improvvisamente abbandonare.
Una mattina, durante l’ennesima pausa caffè, lo raggiunse Simona. Lavorava al piano di sopra, nell’ufficio del personale.
-Io inizio a essere stanco. C’è un sistema di lavoro che fa acqua da tutte le parti. Ormai ho perso il sonno-.
Alcuni documenti dovevano essere controllati da un ufficio esterno. Gli impiegati ne avevano poca voglia, tempo o predisposizione. Così Glauco aspettava invano il ritorno di quelle carte. Poi arrivavano tutte insieme: una pila di carta da stampare. E il mese successivo si ricominciava da capo. Documenti, controllo, errori, restituzione. E attesa del rientro delle copie corrette. Sempre così.
-Te l’ho sempre detto che qui non è tutto ora ciò che luccica. Anche all’inizio, quando eri entusiasta di essere arrivato qui-
In effetti all’inizio, otto anni prima, Glauco aveva legato con tutti. I colleghi non gli sembravano così malvagi, nel lavoro si era buttato con entusiasmo, era sbocciata una incoraggiante empatia. Aveva molto da imparare.
-Li vedo i tuoi occhi spenti. Lo vedo che sei cambiato- affermava sicura Simona.
Era cambiato sì. Sarà stata l’età, saranno stati gli stimoli, sarà stata la routine.
Glauco pensava che quello fosse il lavoro della sua vita, ma probabilmente si sbagliava. Si era legato alla Grar come ci si può legare a una famiglia, ma evidentemente aveva preso un abbaglio. Aveva un’altra età, un’altra visione delle cose.
Era più ingenuo, più distaccato. Oggi sembrava chiuso in un vicolo cieco.
-Mi sembra di essere all’interno di quattro mura, come quelle di una cella. La via di fuga è in alto, vedo una luce. Ma non riesco ad arrivarci-.
La quotidianità di Glauco aveva assunto le sembianze di una lavatrice incagliata. Usciva schiuma da sotto che sbuffava, sbroccava, sbrodolava. Continuamente. La schiuma dei giorni che trascorrevano su una linea retta, su di una rotta tracciata e senza soluzione di continuità.
Una mattina, che doveva essere uguale a tutte quelle degli ultimi otto anni, arrivò una telefonata.
-Scusate-. Glauco si assentò in tutta fretta, speranzoso che quelle copie del suo curriculum che aveva provveduto ad aggiornare, limare e rifinire, finite sulle scrivanie di molte altre aziende, portassero a un risultato.
Aveva deciso di concretizzare ciò che gli frullava nella testa da anni. Fiorenza lo aveva lasciato fare. Era determinato a cambiare lavoro, nonostante un contratto a tempo indeterminato, a patto di trovare pari condizioni, per porre finalmente fine a quell’agonia.
-Glauco?-
-Sì sono io-
-Sono Monica, della Airmax- Non gli era nuovo questo nome. Due settimane prima aveva letto un’offerta sul web: “Cercasi impiegato per il monitoraggio della merce in entrata e in uscita…” e altre amenità. Lo aveva letto sommariamente, e quello scopo assunzione lo aveva indotto a fare un tentativo. Sembrava il solito buco nell’acqua. Non fu così.
Alle 18.30 di un giorno di aprile, Glauco si presentò negli uffici della Airmax.
-Crediamo che lei abbia i requisiti adatti. Ha lavorato in modo capillare e totale in un ruolo analogo, ma, mi dica, come mai questa necessità di fuggire da un contratto così vantaggioso?-
Glauco riversò su di loro gli ultimi mesi colmi di vuoto, la mancanza di appagamento, il desiderio di cimentarsi in un ambiente diverso, con facce diverse, persino con colori diversi. A un certo punto si chiese se era giusto aver preso un colloquio di lavoro come uno sfogo adolescenziale con un amico.
-E adesso che penseranno? Che sono uno che cambia lavoro ogni otto anni? Che mi annoio di ciò che faccio dopo poco che lo faccio? Che…?-
Non ce ne fu il tempo. Il pomeriggio seguente, un’altra telefonata, dallo stesso numero.
Fabrizio, uno dei colleghi con cui divideva l’ufficio alla Grar, alzò gli occhi di scatto, sottraendoli alle carte che stava controllando. Forse aveva intuito qualcosa. Forse gli era arrivata qualche voce.
-Abbiamo deciso di prenderla. Abbiamo notato la sua determinazione, la sua personalità. Ci faccia sapere per il preavviso. Contiamo di farla iniziare tra il 28 e il 30 del mese-.
Glauco era fuori, nel grande cortile del magazzino, quando riagganciò il telefono. Era una giornata assolata, primaverile, calda. Mezzogiorno era vicino. Tutto intorno a lui appariva come una metafora. Il sole che torna a splendere, la luce, il tepore. Era come se una grande ruspa avesse rimosso il terreno spianando la strada davanti a lui. Tutti gli sforzi erano stati ripagati. La lavatrice era riparata. La schiuma si era come dissolta.
Glauco rincasò. L’animo scosso, il cuore in subbuglio; poteva mai provocare tanta gioia lasciare un lavoro per un altro? Infilò la chiave nella buchetta, aprì lo sportellino, estrasse il groviglio di buste. Pubblicità, pubblicità, pubblicità. Bollette. Bollette. Bollette. Prese l’ascensore, chissà perché aveva sempre la paura di restarvi bloccato dentro. Aprì la porta di casa. Fiorenza era lì, seduta sul divano, gambe nude, canotta rossa, testa china sulla mano sinistra in preda ai folli e irregolari movimenti di una lima per le unghie. Alzò di scatto lo sguardo.
-Ciao-
Glauco era ancora lì. Si arrestò sulla soglia tenendo in una mano il groviglio di buste, nell’altra la maniglia della porta, Fiorenza abbassò la testa ma la rialzò di scatto.
-Che hai?- Un meraviglioso sorriso era disegnato sul volto del suo fidanzato.
-Non so ancora se sarà il 28 o il 30… ma… vado alla Airmax-.
Era uscito da quelle quattro mura, che aveva raggiunto quella luce apparentemente inafferrabile là in alto. Fiorenza lo guardò stralunata.
Lì sulla soglia, ora si cingevano in un abbraccio.
La carne abbrustoliva lentamente. Lo sfrigolio della cipolla in padella si mescolava al possente rumore dell’aspiratore. La cena era quasi pronta. Fiorenza muoveva tra stoviglie, forchette, canovacci.
-Tra l’altro Ferrari lo conosco… era con me alle medie, non che avessimo un gran rapporto, ma la sua presenza mi ha messo a mio agio-. Ferrari era uno dei consiglieri del gruppo dirigente.
Avevano scherzato ricordando quei tempi, ma non era con lui che doveva misurarsi. Bensì con un altro Glauco, responsabile del personale della Airmax. Non vi furono toni intimidatori, la chiacchierata corse via. Lo capisci quando le cose stanno per andare per il verso giusto.
-Quando lo dici a loro?- interrogò Fiorenza.
-Domani. Appena arrivo chiamerò da parte Simona-.
Fiorenza andò a letto presto quella sera. Glauco uscì sul balcone, si accese una sigaretta, guardò lontano.
L’indomani Glauco si alzò presto. Non dormiva già più ben prima della sveglia. Lo assalivano i tormenti, come prima di un matrimonio. Sarà la cosa giusta da fare? Si sciacqua la faccia, armeggia con la caffettiera. Incrocia Fiorenza - nel frattempo si è alzata anche lei - stiracchiato sorriso da rimbambiti delle sette di mattina.
-Hai dieci minuti?- freddezza, distacco, finta serenità.
-Ho ricevuto un’offerta. Che ho intenzione di accettare. Ma per correttezza volevo prima informare voi e chiedere di essere ritenuto libero-
Simona aveva lo sguardo perso. Rimase colpita. Glauco non sopportava quel silenzio.
Avrebbe preferito una risposta pronta del tipo ah va bene, ok, be’, è un passo importante nella tua carriera, ci dispiace ma lo accettiamo. Alzò le sopracciglia Simona. Si fece cupa. Ma dovette accettare.
Quella puntina di pentimento, insicurezza, timore di aver fatto una cazzata, spingeva nel petto di Glauco. Era lì, pulsante, fastidiosa. Avrebbe, invece, voluto solo gioire. Ma erano giorni di passaggio. Erano normale quelle reazioni e ci sarebbe voluto tempo per quietare il vento forte del cambiamento.
Lavorò con il cuore più leggero. Non guardava più tutto con gli occhi di prima: se ne stava per andare. Tutti fecero come si fa ogni giorno. Controlli, bollette, carichi, scarichi, fatturazione.
Il giorno seguente qualcosa si mosse. Glauco venne convocato in ufficio. C’era Simona, c’era Sergio, il direttore dell’ufficio centrale di cui faceva parte. Un uomo con bretelle rosse su camicia bianca (ancora qualcuno che indossa le bretelle?!), stempiato, con un pancione da donna incinta.
-Allora, abbiamo saputo la notizia. Ora devo riorganizzare l’ufficio- disse con aria rammaricata.
-Eh già-
(Quindi? Che ci devo fare io? Non ho diritto a cambiare lavoro?) E altre amenità sull’occasione della vita, su un cambio di ambiente, sul se questa è la tua scelta fai pure, ci dispiace, ma fai pure.
Un calcio in culo insomma, vai pure se non vuoi stare tra noi.
Ottobre. L’estate è un lontano ricordo. Glauco guarda sconsolato fuori dalla finestra adiacente la sua scrivania. In agosto è dovuto rientrare dalle ferie in anticipo, c’era un sacco di lavoro da fare alla Airmax. Gli hanno dato anche un cellulare aziendale che squilla di continuo: quando Fiorenza gli è avvinghiata addosso sul divano a guardare la tv, quando sono alle Terme immersi negli accappatoi, persino quando scopano. I colleghi sono insopportabili. Essere lì o nell’aula di una scuola media piena di teppistelli è la stessa cosa. E anche qui, nessuno gli sistema gli arretrati. Glauco consulta lo smartphone quasi sempre in pausa pranzo: “Cercasi impiegato…”.
Aldo Zolla era il migliore amico di mio padre. Figlio del migliore amico di mio nonno si era trasferito a Torino per lavoro. Suo figlio, Bigio, aveva la mia età e, per tradizione, sarebbe dovuto diventare il mio migliore amico.
Bigio aveva le guance paffute e i denti sporgenti come uno scoiattolo, e il mio migliore amico non lo era affatto. Non lo vedevo per tutto l’anno, tranne quando la sua famiglia veniva a trovarci durante le feste di Natale e Pasqua, e alcuni giorni d’estate. Per l’occasione, in ricordo del tempo passato insieme, era solito chiedere a mia madre un mio giocattolo, che lei gli elargiva con larghi sorrisi.
L’ascia degli indiani d’America ad esempio, un po’ di costruzioni, a volte anche pezzi di puzzle. Avrebbe anche potuto prenderseli tutti, tanto, quando finivo di comporre quello che mi lasciava, l’immagine era quella di un bambino sdentato.
Io Bigio lo chiamavo “il Piantagrane” perché era solito fare dispetti.
Quando era nostro ospite usava le mie cose, specie la bicicletta: una Graziella rossa con cui scorrazzava per tutto il quartiere, importunando bambine e teppistelli di nota fama.
Io mi facevo i fatti miei e, malgrado ciò, delle sue scorribande rimaneva il mio nome, col quale si identificava giudiziosamente.
Più di una volta, quindi, fui omaggiato di ceffoni postumi da selvaggi avventori di quartiere, per fatti a me del tutto ignoti.
La Graziella rossa, infine, mi fu rubata mentre Bigio stava comprando caramelle gommose al negozio di Tina. Fu Diego Arpagone, il temibile abitante del rione, che per i sette anni successivi vidi impennare su quella bici sempre più piccola e veterana. Lui sempre più grosso e torvo.
Nonostante Bigio il Piantagrane, Diego Arpagone, i puzzle sdentati, i ceffoni e l’immagine della Graziella rossa, crebbi bene.
Ora posso dire di essermela cavata, ho un buon lavoro considerando i tempi, una discreta reputazione e sono ancora innamorato della figlia della lattaia. In realtà la signora lattaia non è propriamente una lattaia, ma un’energica donna che manda avanti un’azienda a gestione familiare.
Produce formaggi a pasta filata: i nodini, la spianata, le mozzarelle. Anche burrate, ricotta, provoloni. Milva, la figlia, è felice da sempre.
E io no. Lei di me non ne vuole proprio sapere, da sempre. La scorsa estate in occasione della festa del Santo Patrono l’ho chiamata in disparte.
«Milva» - le ho detto - «tu sei la mia vocazione».
«Ok Dino. Questa cosa me l’hai detta anche lo scorso anno, dietro la bancarella delle noccioline… io no. Non ho la tua vocazione, lo sai».
«Quale vocazione?».
Lei alzando gli occhi al cielo: «La tua, Dino».
«Ma se è la mia, è chiaro che non può essere la tua».
«Si, insomma, hai capito cosa intendo».
«No, io mi riferisco alla passione per l’arte» ho precisato.
«Arte? Ascolta, mi aspetta mia cugina…vado. Ciao!» ha detto allontanandosi.
«Quale cugina? Aspetta! Milva, torna indietro!».
«Cosa vuoi ancora? Mi stai stufando».
«Milva, io voglio dipingerti!» le ho detto prontamente.
«Eh?».
«Cioè… no. Non te. Voglio dipingere la tua immagine» mi sono affrettato a rispondere. «Da qualche mese mi dedico alla pittura e tu sei la mia ispirazione!».
Lei, scuotendo la testa, è andata via.
Ho dipinto venti volte la mia amata. La cosa mi è riuscita talmente bene che Bigio, che non ha mai perso la abominata tradizione di venire a casa mia, è rimasto incantato dalla mia opera.
Quando è andato a comperare le mozzarelle ha visto Milva alla cassa.
Bigio non si era mai recato a comperare latticini in tutti questi anni. Quest’anno sì. Così a Torino ha portato con sé due souvenir: le burrate e la figlia della lattaia. Io non dipingo più e ho la nausea dei formaggi.
Il latte, quello lo bevo. Lo riscaldo nel catino e quando arriva a bollore mi ricorda Milva, per via della schiuma. Quella che lei vedeva tutti i giorni passati a lavorare nel caseificio.
La schiuma dei giorni. E’ così che chiamo la mia rabbia, che viene a galla se penso alle volte passate a regalare a Bigio i miei giocattoli. Per fortuna non ha voluto il dipinto, altrimenti mia madre glielo avrebbe anche regalato, in ricordo del tempo passato insieme. Il tempo invece, adesso lo passa con Milva. A me i dipinti, a lui l’originale.
Comunque, la mia vita non è dipesa totalmente da quei due. Si, è vero, ci sono voluti alcuni mesi per riprendermi dalla delusione, ma poi è arrivato l’inverno.
Mi sono iscritto a un corso di balli latino americani e mi sono fatto crescere i capelli, per tirarli all’indietro e sentirmi più figo. Infatti al corso ho conquistato il cuore di Rachele: una donnona alta un metro e ottanta, dalla risata genuina.
Stretto nella sua presa vigorosa e morbida, mi perdevo dentro i suoi passi decisi.
Mi accarezzava la chioma affermando che i capelli folti l’accendevano, poi ha conosciuto Amilcare, un nuovo iscritto al corso.
Amilcare vendeva gatti persiani per lavoro ed era completamente calvo, mi chiedo ancora come sia successo e perché.
E’ rimasta la schiuma per capelli però. La schiuma dei giorni: è così che la chiamo, anche quella, se penso ai giorni passati ad acconciarmi la zazzera all’indietro, sognando Rachele.
Nel frattempo è arrivata l’estate. Faceva caldo e mi sono tagliato i capelli.
Benedita è la ragazza portoghese che ho conosciuto in occasione del mio viaggio in Croazia. Si, perché dopo l’ultima delusione amorosa, me ne sono andato in vacanza per una decina di giorni.
Volevo contemplare la natura e starmene in pace. Così ho preso la mia Clio, direzione Pola e addio per un po’.
Per intenderci, la Clio ha un ottimo motore e in ogni caso, dalla Graziella alla Clio è un bel passo avanti. Inoltre in Croazia ci sono arrivato dopo aver fatto tappa a Trieste, dove ho incontrato Benedita, che lavorava lì dando ripetizioni di portoghese.
Per farla breve: ero andato ad acquistare un po’ di cibarie per continuare il mio viaggio e l’ho incontrata, per caso, in un supermercato.
L’approccio non è andato nel migliore dei modi. Benedita stava prendendo una bottiglia di birra dallo scaffale mentre un’altra me l’ha fatta cadere sul piede. Io mi trovavo di fianco con lo scopo di intortarla.
Dolore a parte, lei proprio era convincente quando diceva di voler passare la vacanza con me. Infatti dopo una sosta di due giorni a casa sua, abbiamo fatto tappa a Rovigno.
Più che contemplare la natura dei luoghi, ho ammirato quella portoghese e sorseggiato birra. Poi siamo andati dall’affittacamere. Stavamo cambiando sistemazione perché l’alloggio che avevamo trovato era disponibile solo per qualche giorno. Benedita, però, il posto dove continuare la vacanza l’ha trovato senza di me, grazie all’affittacamere, che le ha proposto un’occasione unica: casa sua a costo zero. Io non potevo andare a casa dell’affittacamere, proprio non mi voleva.
Così siamo rimasti io e le bottiglie di Benedita.
Me ne sono tornato in Italia per meditare nel mio paese e starmene in pace, bevendo birra. La verso senza inclinare il bicchiere perché mi piace che faccia la schiuma.
La schiuma dei giorni: è così che chiamo quelli passati a sorseggiare e contemplare Benedita. Affondo le labbra nel bicchiere e ho già il suo aroma in bocca.
E comunque, sono ancora innamorato della figlia della lattaia.
Loro sono i ratti ospiti del nuovo centro di recupero di Torino de La collina dei conigli Onlus. Vengono da situazioni difficili, per lo più sequestri e stabulari in cui attendevano di essere utilizzati come cavie o dove, per esperimenti, sono stati utilizzati realmente. Ora sono al sicuro e coccolati, ma cercano delle famiglie che li sappiano gestire e amare come meritano. Si affidano minimo in coppia perchè sono animali abituati a vivere in colonia e adorano dormire vicini. Per informazioni o adozioni potete contattare Federico al numero: 331.3747132
Vengono da situazioni difficili, per lo più sequestri e stabulari in cui attendevano di essere utilizzati come cavie o dove, per esperimenti, sono stati utilizzati realmente. Ora sono al sicuro e coccolati, ma cercano delle famiglie che li sappiano gestire e amare come meritano. Si affidano minimo in coppia perchè sono animali abituati a vivere in colonia e adorano dormire vicini. Per informazioni o adozioni potete contattare Federico al numero: 331.3747132
Lui è un bellissimo mix levriero ed è stato trovato che vagava di notte, su una strada di Roma.
E' ancora ospite delle persone che l'hanno soccorso che però non possono tenerlo.
Ha un buon carattere ed ha circa sette mesi.
Si affida preferibilmente nel Lazio, ma per una buona adozione può raggiungervi ovunque.
Per informazioni o adozione potete contattare Serena al numero 0824 851635, o scrivere un messaggio alla Casetta Scenù.
Lui è Lilo.
Lilo è stato trovato debole e malconcio quando ormai si stava lasciando morire.
Ora è in stallo e si sta rimettendo in forze, pronto per essere adottato ed amato.
Ha sette anni ed è fiv/felv negativo. Si affida preferibilmente a Torino e provincia previo colloquio preaffido e firma modulo di adozione.
Per informazioni ed adozione potete contattare Manuela al numero 349.6161038
Lei è Viola.
Viola èstata comprata per i bambini della famiglia che poi però si sono stufati ed ora lei vive fuori in questa minuscola gabbia. Ha sette mesi e si trovaa Torino e va da sè checerchi urgentemente casa.
Per informazioni o per adottarla potete contattare Barbara al numaero 346.2628645
Ecco Alessandro. Alessandro è entrato in canile nel 2011 quando ancora era cucciolo. Il tempo poi è passato, nessuno l'ha adottato e ora lui ha quasi sei anni ed è diventato molto timido. Per lui si cerca una persona mite e paziente, che rispetti i suoi tempi. Si trova in un canile vicino a Frosinone, ma cerca adozione preferibilmente al nord Italia previo colloquio preaffido. Qui potete vedere un suo video.
Alessandro è entrato in canile nel 2011 quando ancora era cucciolo. Il tempo poi è passato, nessuno l'ha adottato e ora lui ha quasi sei anni ed è diventato molto timido. Per lui si cerca una persona mite e paziente, che rispetti i suoi tempi. Si trova in un canile vicino a Frosinone, ma cerca adozione preferibilmente al nord Italia previo colloquio preaffido. Qui potete vedere un suo video.
Verrà affidato vaccinato, castrato e microchippato.
Per informazioni potete chiamare Manuela, 393.4080484 oppure Giada, 347.2887902
Questi cuccioli sono stati avvistati qualche giorno fa in un casolare in provincia di Salerno.  Tre di loro hanno già trovato casa, ma ce ne sono altri sette che attendono di essere adottati.
Tre di loro hanno già trovato casa, ma ce ne sono altri sette che attendono di essere adottati.
Non hanno ancora due mesi per cui verranno dati in adozione verso metà ottobre preferibilmente al centro e nord Italia previa compilazione di un questionario e di un colloquio preaffido. Sono una futura taglia media. Per loro vi è l'obbligo di sterilizzazione entro gli otto mesi.
Per informazioni ed adozione potete telefonare a Claudia (333.1341422), Delia (339.8022906) o Cristina (329.7448149).
Questo magnifico setter si chiama Zenebù.

Zenebù è nato a settembre del 2015 ed è una taglia media.
E' un cane molto dinamico e dal carattere dolce, microchippato e sano.
Verrà affidato in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta previo colloquio preaffido e firma del modulo di adozione. Per informazioni potete contattare Bianca dalle 17 alle 20 al numero: 380.3130298
Pedro (in foto) e Rudy sono due gattini di due mesi che sono stati recuperati da una colonia nella speranza di trovar loro una famiglia, perchè in strada richiavano la vita.
 La ragazza che li tiene in stallo però, non ha molto tempo da dedicare loro per cui si cerca qualcuno che abbia la pazienza di educarli e abituarli al contatto umano. Per informazioni potete contattare Antonella al numero: 339.8108751
La ragazza che li tiene in stallo però, non ha molto tempo da dedicare loro per cui si cerca qualcuno che abbia la pazienza di educarli e abituarli al contatto umano. Per informazioni potete contattare Antonella al numero: 339.8108751
- Dal 17 settembre è iniziato il tour italiano della professoressa Lisa Kemmerer, autrice del saggio “Mangiare la terra. Etica ambientale e scelte alimentari” (Safarà Editore, 2016).
“Mangiare la terra” è un libro scritto tanto per gli ambientalisti e gli animalisti, quanto per chiunque sia interessato a vivere una vita etica e sostenibile, esplorando il terreno comune delle scelte alimentari e l’impatto che quest’ultime hanno sul pianeta.
Il tour è partito da Pordenone, per arrivare il 23 settembre a Trieste, passando prima da Torino (18/9), Milano (19/9), Bologna (20/9), Ancona (21/9) e Treviso (22/9).
Qui potrete trovare tutte le date e le informazioni per parteciparvi.
- Mercoledì 21 settembre alle ore 20, a Loreto, presso l’associazione culturale “Reasonanz”, in via Leonessa snc, c/o “ex tiro al volo”, ci sarà un aperitivo di beneficenza per gli animali salvati dagli allevamenti intensivi che ora vivono presso il “Rifugio Arcadia” di Corinaldo (AN). Il costo dell’aperitivo sarà di 15 euro di cui 5 andranno per il mantenimento degli ospiti del rifugio.
Per informazioni e prenotazioni potete chiamare Nuria al numero 393.1864916
- Giovedì 22 settembre a partire dalle 19,30, la LAV di Varese, organizza presso il ristorante vegan “GustoArsizio” in via Palestro 1/b, Busto Arsizio, una cena benefica per gli animali terremotati.
Il costo della cena, che prevede un piatto di spaghetti all’amatriciana vegan più una bevanda a scelta, sarà di 14 euro di cui la età, sarà devoluto alla LAV per l’assistenza degli animali delle zone terremotate. E’ gradita la prenotazione al numero 0331.623803 oppure via e-mail all’indirizzo: gustoarsizio@yahoo.it
- Sempre giovedì 22 settembre, questa volta però a Torino, presso il ristorante vegano “Ratatouille”, sito in corso Tortona 2/g, ricominciano le cene di beneficenza a favore dell’associazione AgireOra. Il costo della cena sarà di 16 euro (bevande escluse) e prevede un tris di antipasti, primo, secondo, contorno e dolce, il tutto servito al tavolo.
E’ gradita la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo: piemonte@agireora.org
- Venerdì 23 settembre, dalle ore 19,30, presso “Eat & Drink House” (via Taglio 12, Modena), ci sarà il secondo aperitivo a favore dei Mici di Gemma.
La serata prevede una grigliata vegan, una lotteria e un mercatino.
Il prezzo della serata è di 5 euro e la prenotazione non è necessaria.
- Sabato 24 settembre dalle 10,30 alle ore 12,30, a Rho, davanti alla sede del salumificio “Citterio”, saranno presenti gli animalisti che aderiscono alla campagna Nomattatoio. A questo presidio, informativo e non violento, sono invitati tutti coloro che desiderano dare voce agli animali chiusi negli allevamenti e uccisi nei macelli.
- Sabato 24 settembre dalle ore 15,45 alle 19, l’associazione Vivi gli Animali Onlus, vi invita a far loro visita a Collegno(TO), per una merenda di beneficenza a favore degli ospiti del rifugio. Durante il pomeriggio i volontari dell’associazione vi presenteranno gli animali che lì abitano e vi faranno conoscere la storia di ciascuno di loro. Sono previsti anche giochi di intrattenimento per i più piccoli.
Il costo della merenda è di 5 euro e tutto il ricavato sarà destinato alla cura e al mantenimento degli ospiti del rifugio e per la costruzione di nuove strutture per l’accoglienza di altri animali bisognosi.
E’ necessario prenotarsi telefonando al numero 335.8187862 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo: info@viviglianimali.it entro martedì 20 settembre.
- Sabato 24 settembre, dalle ore 21, a Torino, presso il circolo ARCI di via Castelnuovo 10/a, sarà presente la scrittrice vegana Aida Vittoria Eltanin per raccontare la vita di 13 DONNE VEG che hanno fatto la storia e salvato persone e animali a cavallo dei secoli ‘800 e ‘900.
L’ingresso è gratuito per i soci con tessera ARCI (tessera che si può fare al momento a 10 euro).
L’evento è organizzato dall’associazione “La tela di Aracne” con la collaborazione di “Voce in capitolo”.
E’ necessaria la prenotazione al numero 347.5969228 oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo: info@lateladiaracne.it
- Sabato 24 e domenica 25 settembre, dalle ore 10 alle 20, a San Pietro in Cerro (PC), si terrà NaturOlistica l’undicesima fiera del naturale e del viver sano.
Lo scopo del festival è quello di promuovere e diffondere stili di vita naturali e consapevoli, nel rispetto della salute dell’uomo e del pianeta. Per questo motivo, i temi trattati andranno dalla medicina olistica all’alimentazione naturale, dall’ecologia allo sviluppo sostenibile, dall’educazione consapevole alla cooperazione.
Nel parco ci saranno oltre 80 stand del naturale, un’area wellness, punti ristorazione vegan e bio e durante i due giorni di fiera si alterneranno conferenze, workshop, laboratori per grandi e bambini e una mostra d’arte. L’ingresso è gratuito e per ulteriori informazioni e per il programma completo, potete consultare il sito dell’evento.
- Sempre il 24 e il 25 settembre, al Parco Fellini di Gambettola(FC), si terrà la settima edizione del VEGfest. Il festival ha come obiettivo di promuovere lo stile di vita vegan attraverso conferenze, laboratori, musica, stand di associazioni animaliste e un mercatino con prodotti cruelty free.
Per il programma completo delle varie attività, potete consultare il sito.
- Domenica 25 settembre, alle ore 15, in Via Giuseppe Luigi Lagrange 9, a Torino, gli animalisti dell’associazione Animal Renegades testimonieranno con una rappresentazione scenografica, la sofferenza e lo sfruttamento degli animali “da macello”.
L’intento della manifestazione è quello di informare i passanti sulle conseguenze di una dieta “onnivora” e favorire una riflessione attraverso l’ausilio di foto, cartelloni e la distribuzione di volantini.
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Il materiale informativo da distribuire sarà fornito dall’associazione.
- Sempre domenica 25 settembre e sempre a Torino, il circolo “Naturalmente Veg” di corso Casale 204/L, ospiterà una cena di beneficenza a favore di ANPAV (Associazione nazionale protezione animali per la vita).
L’offerta minima è di 15 euro e la prenotazione è obbligatoria entro il 24 settembre chiamando il numero 011.7631763
Potrete trovare il menù e altre informazioni, sulla pagina dell’evento facebook.
- Domenica 25 settembre a Roma, in Piazza del Popolo, si terrà la seconda edizione di Animal Aid Live, un grande concerto dedicato agli animali. Dalle ore 15 alle 24, si susseguiranno nove ore di musica, spettacolo e testimonianze per veicolare un unico grande messaggio: la tutela dei diritti animali.
L’ingresso è gratuito e il programma dell’evento è consultabile sul sito.
- Sabato 1 e domenica 2 ottobre, l’Alpeggio delle Coccole, a San Fedele Intelvi di Sopra, in Lombardia, vi aspetta per passare insieme un Gran Weekend Vegan.
Saranno due giorni di festa per celebrare insieme agli animali del rifugio la fine dell’estate e la stagione del pascolo montano. Le attività proposte saranno numerosissime: passeggiate nel bosco, visita e coccole agli animali, corsi di cucina, proiezioni di documentari a tema, massaggi ayurvedici e laboratori per ragazzi e bimbi. L’intero programma è consultabile qui. Il contributo richiesto (50 euro al giorno, che comprende vitto e alloggio) servirà a coprire i costi dell’associazione e ad acquistare fieno per la stagione invernale.
Per partecipare bisogna inviare una e-mail a: eventi.ingaia@gmail.com e, ricevuta conferma della disponibilità del posto, effettuare il bonifico del contributo richiesto.
La mattina in cui l’avevano trovata nella cunetta era un grumo di disperazione e di paura, ripiegata su se stessa, nuda, tremante. Il suo corpo, il cui colore si confondeva con quello della terra su cui posava, era scosso da un fremito incessante, sembrava quello di un animale ferito che aspetta la morte sperando che arrivi. La sua anima era stata presa a morsi e ridotta in brandelli, così come la sua carne.
Dopo il ricovero in ospedale era rimasta in uno stato di semi-incoscienza per qualche giorno: con gli occhi chiusi, muta, scollegata da tutto quello che le accadeva attorno. Quando aveva ripreso contatto col mondo, e la donna che le aveva detto di essere un’ispettrice di polizia le aveva chiesto chi fosse, lei aveva risposto che si chiamava Saraya e aveva diciotto anni. Ma ne aveva sedici, appena compiuti. Le avevano proibito di dire la sua vera età a chiunque, con le solite minacce che ormai incombevano sulla sua vita come un harmattan fitto e soffocante. Lo aveva fatto nel suo inglese sconnesso, il suo italiano non le consentiva ancora di avere una conversazione normale: le avevano insegnato le parole necessarie per lavorare, e ne aveva imparata qualcuna dai clienti. Avevano dovuto fidarsi, poiché non aveva documenti; non avevano trovato neanche i suoi vestiti, nelle cui tasche avrebbe potuti riporli, né una borsa. I documenti non li aveva più avuti da quando, un anno prima, era salita sul camion che l’avrebbe portata in Marocco: il suo passaporto, da quando era arrivata in Italia, era finito nelle mani della maman. Non aveva mai saputo come si chiamasse quella donna in realtà, le era stato intimato di chiamarla sempre e soltanto così. Ne aveva avuto paura sin dal primo momento, forse ancora più degli uomini che l’accompagnavano la sera e, a volte anche la mattina, nello slargo lungo la tangenziale dove aspettava l’arrivo dei clienti. Quegli stessi uomini, dopo il suo primo incontro con la maman, le avevano fatto una specie di corso intensivo e accelerato, prima di avviarla alla strada.
Nella stanza tutta bianca, con una finestra da cui si intravedevano degli alberi alti, dalle foglie grandi, di un verde intenso, quasi come quelli attorno al suo villaggio, si sentiva al sicuro. Ma se avvertiva dei passi che si avvicinavano alla sua porta tratteneva il respiro, incapace di dominare la paura che partiva a piccole onde, quasi increspature sul cuore, fino a diventare uno tsunami ingovernabile. L’infermiera, quando aveva saputo della sua storia, le aveva assicurato che lei e i suoi colleghi non avrebbero permesso a nessuno di entrare, però l’idea di ritrovarsi la maman, o uno dei suoi scagnozzi, la atterriva. Nella camera c’era solo lei, non voleva sapere perché, sebbene potesse immaginarlo, ma le andava bene così. Gli sguardi sospettosi, curiosi, sicuramente sdegnati, di altre donne, avrebbero accresciuto l’angoscia che già la tormentava, un macigno che le premeva sul petto, mozzandole il respiro, ogni istante, di giorno e di notte.
In quel letto, da cui cominciava a staccarsi da poco, dopo gli interventi che aveva subito, le tornavano alla mente le ultime immagini del suo villaggio dopo l’attacco dei Boko Haram. Lei, suo padre e sua sorella più piccola, erano andati in città per il mercato dove vendevano i prodotti del loro piccolo pezzo di terra e, nei momenti del massacro, erano sul loro pickup, in viaggio verso casa. Il fratello maggiore lavorava a Maiduguri, non tornava quasi mai. Il resto della famiglia però era finito nel groviglio di corpi smembrati e carbonizzati, confusi tra i frammenti delle case che il fuoco, nella sua ingordigia rabbiosa, non era riuscito a divorare. Quando giunsero al villaggio, davanti ai loro occhi si presentò l’inferno: Saraya ne aveva sentito parlare dall’imam in moschea. A quel punto sapeva com’era, non doveva più immaginarlo.
Era passato un mese dall’assalto al villaggio quando quella donna, col costume locale, ma piena di gioielli, si era fermata davanti alla loro merce al mercato. Riferì loro che era appena tornata dall’Italia per far visita alla sua famiglia. Non le ci volle molto a sapere dal padre di Saraya che loro erano tra i pochi superstiti della razzia dei miliziani: lui non parlava d’altro, forse per esorcizzare il suo mondo da altre incursioni degli spiriti del male. Lo sguardo della donna si posò sulla ragazza, scrutandola con un’insistenza fastidiosa, insolita, e poi suggerì: «Sono sicura che in Italia un lavoro per lei si trova, in poco tempo può guadagnare tanto e aiutare anche voi che restate.».
Saraya ricordava ancora la luce che vide brillare negli occhi del padre a quelle parole e che, dopo tanto tempo, per lei era l’altra faccia delle tenebre profonde in cui sarebbe stata risucchiata da quel momento in poi, in un vortice che avrebbe travolto tutto.
Poi il rito col baba-loa, il suo corpo ceduto per quarantamila naira necessari per il viaggio e la prima sistemazione. E il giuramento di non rompere il patto per non attirarsi le ire degli spiriti che dovevano proteggerla. Avrebbe restituito il denaro alla donna che la stava guidando verso una nuova vita col proprio lavoro. Solo dopo aver saldato il debito sarebbe tornata a essere di nuovo padrona del suo corpo. Era stata l’idea di riprendersi quanto aveva da sempre considerato suo, a spingerla a guadagnare sempre di più, sempre più in fretta, con turni massacranti che riusciva a reggere perché era giovane, il suo fisico irrobustito dal lavoro nei campi. Uno strumento, in quei giorni, a disposizione dei suoi carcerieri e di chiunque pagasse: un passaggio obbligato, il pedaggio per la libertà.
Una sera, quella, come tante. Un cliente come gli altri: guardingo, negli occhi un misto di desiderio e di ribrezzo, come tutti. Sembrava africano anche lui, ma del nord, a giudicare dalla pelle ambrata e dai tratti del viso. Come le persone che aveva incontrato in Marocco, nella prima tappa del lungo viaggio, prima di salire, insieme a una settantina di sconosciuti, su un barcone che, da lì, l’avrebbe consegnata alle coste della Sicilia. L’uomo l’aveva caricata in macchina per portarla in un posto tranquillo che raggiunsero dopo aver percorso un sentiero di campagna: un casolare che sembrava abbandonato, ma la cui porta era socchiusa. Lui la invitò a seguirlo, spingendo la porta. Era buio, ma una volta assuefatta all’oscurità, Saraya riuscì a distinguere un gruppo di sei, forse sette uomini, che si alzavano lentamente dal pavimento su cui erano seduti. Con un guizzo fece per guadagnare l’uscita, ma braccia robuste la bloccarono e qualcuno le sferrò un pugno in pieno viso. Nello stordimento che seguì avvertì che la stendevano per terra e, mentre lei si divincolava con le poche forze che le erano rimaste dopo il colpo, sentì mani che la spogliavano con urgenza febbrile. E ricevette un calcio su un fianco, poi un altro su una spalla, ancora un pugno in pieno petto. Parlavano una lingua incomprensibile, qualcuno urlava sempre la stessa parola. Lei non capiva. Uno di loro si sdraiò su di lei, poi un altro. Poi il buio. Quando si risvegliò era quasi l’alba e lei era in una culla di terra umida, sotto un cielo che iniziava ad aprirsi, ma che riusciva a vedere appena, gli occhi lividi e tumefatti ridotti a due fessure. L’aveva notata un ciclista che si allenava di prima mattina.
Cinque giorni dopo il suo arrivo in ospedale, l’ispettrice di polizia, che l’aveva interrogata dopo il suo ricovero, era tornata in compagnia di un uomo giovane: le aveva detto che era un prete, lei lo aveva capito subito dalla piccola croce di metallo appuntata sul colletto della camicia. Anche i preti che venivano qualche volta al villaggio, dalla missione vicina, ne avevano una. L’uomo le aveva detto che c’era una casa, in campagna, dove poteva andare quando l’avessero dimessa dall’ospedale, se voleva. Vi avrebbe trovato altre donne, sfregiate dalla brutalità della vita, come lei, «e quando starai meglio, cercheremo un lavoro per te.», aveva concluso. Al suo sguardo smarrito, aveva aggiunto: «un lavoro in un albergo, come donna delle pulizie. Ci sono tanti alberghi in questa zona. Oppure come aiuto per qualche anziano. Lavori che ti garantiranno un posto dove dormire, e pasti regolari, più la paga.». A Saraya, mentre l’uomo parlava, era venuto in mente il suo debito, e si limitò a fissare i due in piedi davanti a lei senza dire una parola. La donna, come se le avesse letto nel pensiero, intervenne: «Non preoccuparti di nulla, non devi niente a nessuno». Quindi sorridendo, con espressione risoluta, aveva aggiunto: «col tuo aiuto contiamo anche di arrivare alle persone che ti tenevano in ostaggio.». Dopo che se ne furono andati si era rannicchiata sotto le coperte e aveva pianto come non faceva da mesi.
Quando un medico e la solita infermiera erano passati a dirle che, se gli ultimi esami fossero risultati buoni, sarebbe stata dimessa due giorni dopo, Saraya era stata investita da una valanga di emozioni contrastanti: paura, curiosità, attesa, desiderio, diffidenza, fiducia. Tutte insieme, in un unico grande miscuglio in cui i giorni che aveva vissuto in Africa, nel suo villaggio, con tutta la famiglia, e quelli che comprendevano il lungo viaggio verso l’Italia e la cattività inattesa, si fondevano. E da quella fusione lei, forse, a quel punto, poteva sperare che affiorasse la parte migliore: la schiuma candida e lieve di giorni che contenessero la promessa di una vita piena zeppa di voglia di vivere. Che non le facesse vedere nella morte l’unica via di scampo, ma fosse fatta di giorni scanditi da azioni ordinarie, un’esistenza al riparo dalla ferocia, a cui ancora temeva di doversi piegare. Lei avrebbe separato quella schiuma sana dal resto, dagli scarti di una vita creata da incubi e inganni. Disorientata e in preda a mille paure, ma anche impaziente di inventarsi i suoi primi giorni nuovi.
harmattan - vento secco e polveroso che soffia in Africa a nordest e ovest, dal Sahara al Golfo di Guinea, tra novembre e marzo
baba-loa – santone africano che pratica riti voodoo
naira – valuta nigeriana
Respira piano, penso.
Respira molto piano, continuo a pensare, mentre due piccole gocce di sudore si fermano all’altezza della tempia sinistra. Il cuore può esplodere quando è messo nelle condizioni di farlo.
Immagino che la ragazza al di là del bancone stia immaginando le stesse cose mentre la mia pistola le punta la fronte. Ha meno di trent’anni, e, a giudicare da come non riesce a tenere fermo il labbro superiore, questa deve essere la sua prima rapina.
Le persone mi guardano terrorizzate, uno si è buttato a terra, altri non riescono a tenere ferme le gambe. Un vecchio forse si è pisciato addosso.
Non deve finire come l’ultima volta.
Dieci anni fa è finita in un mare di merda e di sangue.
Eravamo in tre. Io e Granchio dentro la banca, Smilzo fuori a fare da palo e a recuperarci con la macchina accesa. Smilzo lo avevamo conosciuto appena una settimana prima, al bar di Tony. Non sapevamo il suo vero nome, si era presentato così e a noi era bastato quel nomignolo, non c’era bisogno di altro.
Avevamo fatto grandi bevute, quella sera. Ci aveva chiesto di fare un colpo insieme, che ne aveva già fatti tanti e non l’avevano mai beccato. Per tutta quella settimana ci incontrammo a casa di Granchio e progettammo nei minimi particolari la rapina nella banca dove tenevo gli ultimi quattro spicci che mi erano rimasti.
Quando suonò l’allarme Smilzo si cagò sotto dalla paura e scappò senza neanche sgommare più di tanto.
Arraffammo dalla cassiera una manciata di banconote di grosso taglio, ci riempimmo nemmeno un decimo del borsone che avevamo portato. Sbattemmo qualche sedia per terra e facemmo un po’ di casino, mentre dal passamontagna all’uscita mandai un bacio con la mano verso il direttore. Lui mi guardò con un ghigno appena abbozzato, con l’espressione di chi ha in testa un solo pensiero. Lo capii giorni dopo, sul letto senza doghe della mia cella, che il suo pensiero quella mattina era stato: “sei un povero coglione”.
Granchio non ebbe il tempo di pensare a nulla. Gli spararono alla gamba ancor prima di capire che fuori era tutto un azzurro polizia. Cadde a terra e il sangue iniziò a uscire a fiumi. Il proiettile aveva attraversato il femore all’altezza dell’arteria. Capimmo subito entrambi.
Io alzai le mani al cielo, lanciando la borsa lontano e mettendo bene in vista il mio corpo, sperando che una pallottola non beccasse anche me. Granchio iniziò a singhiozzare. Due poliziotti mi raggiunsero con le pistole puntate. Mi buttarono a terra e, coi calci alle costole, mi portarono le braccia dietro la schiena. Mi ammanettarono.
Conoscevo Granchio da vent’anni, ero l’unico a sapere il vero motivo per cui per tutti, giù alle case, era semplicemente Granchio. I più giovani non ne conoscevano neanche il vero nome. Non ce n’era bisogno, bastava il suono e il richiamo della mente al piccolo animale e a tutta la sua forza nelle chele. Granchio era esattamente così, piccolo e tozzo, con due braccia enormi, e due mani forti e violente.
Una domenica di derby stritolò il collo della moglie.
La sua squadra perse in malo modo, lui tornò a casa ubriaco e con vari grammi di coca in corpo, lei iniziò a urlargli contro di smetterla con quella vita e minacciandolo che se ne sarebbe andata. Strappò l’unica foto di Granchio con suo padre. Una foto in cui sono al mare e lui è a cavalcioni sulle sue spalle, e si guardano uno dall’alto e l’altro dal basso.
Avrà avuto cinque anni. Una delle ultime volte in cui era stato felice.
Gliela aveva tirata contro. La cornice era andata in frantumi e alcuni pezzi del vetro avevano tagliato la foto. Lo aveva fatto apposta, sapeva quanto Granchio ci tenesse a quella foto. Lui la raccolse da terra, capì che il danno era irreparabile. Le andò incontro e, senza aver detto una sola parola da quando era entrato in casa, piantò le mani al collo di sua moglie. Iniziò a stringere e lei non ebbe neanche il tempo di iniziare ad urlare. La uccise in silenzio.
La sera stessa, poi, era venuto sotto casa mia.
«L’ho ammazzata, Paolo», mi disse, senza che la cosa lo coinvolgesse più di tanto.
«Come mai?», gli avevo chiesto, come se il motivo avesse qualche importanza.
«Cosa devo fare adesso?».
Finalmente la paura lo aveva portato, insieme a qualche residuo di coca ancora danzante nel suo corpo, a preoccuparsi delle conseguenze di quella stronzata.
«Prendi la borsa più grande che hai, io vado dal benzinaio con un bidone», gli avevo detto, chiudendo per sempre la questione. A tutti disse che la moglie era tornata al paese della madre.
Da quel giorno avevo iniziato a chiamarlo Granchio. Gli piaceva da matti.
In vent’anni non l’avevo mai visto piangere. Mai, neanche una volta. Neanche quando trovammo il corpo di suo padre perforato di proiettili, steso all’ingresso di casa. Questione di carichi di coca finiti chissà dove. Regolamento di conti, ancora una volta. Conti sempre troppo alti da pagare, da una vita.
Ora era lì davanti a me, con una gamba inzuppata di sangue e la vista che iniziava ad annebbiarsi. Piangeva, Granchio. Piangeva e mi guardava, mentre si teneva la gamba e io ero steso con la testa schiacciata sull’asfalto.
«Mi sono cagato addosso, Paolo», urlò. I due agenti sopra di me si misero a ridere. Uno mi mollò e gli andò incontro: «Siete due merde», disse. «Adesso muori come un cane», aggiunse. Poi prese il telefono e chiamò l’ambulanza. Disse di fare presto, che c’era un uomo a terra.
Granchio mi guardò ancora una volta, poi si accasciò.
Non dissi niente.
Il mio migliore amico era appena morto sotto i miei occhi, nel peggiore dei modi, e io non avevo niente da dire.
Mi feci otto anni di carcere. Grazie al mio avvocato e alla buona condotta, mi scontarono quasi metà della pena. In carcere, ebbi modo di ripensare alla mia vita. Era chiaro che era stata un fallimento su diversi fronti. Non sapevo, ad esempio, cosa volesse dire la parola serenità. Non l’avevo mai incontrata.
Avevo incontrato l’amore, quello sì. Ma anche lì fu tutto un casino. E non finì bene. Lei se ne andò, e si portò con sé la sola cosa che mi aveva fatto sperare in una vita normale. Aveva tre anni, Federico, l’ultima volta che lo vidi, sulla porta di casa. Ubriaco da far schifo, cercavo di prenderlo dalle braccia di sua madre. Almeno per un abbraccio.
In otto anni di carcere non mi venne a trovare nessuno. Neanche Tony, a cui ho mantenuto la famiglia a forza di vodka tonic, giù al bar. Eppure quello che più mi è mancato negli anni dentro non è stato il contatto con le persone. I miei compagni di cella erano diventati buoni amici, e quasi con tutti condividevo lo stesso destino di povero cristo. Le piccole cose del quotidiano, quelle sì, mi mancavano. La colazione al porto. La barchetta con cui andavo a pescare la domenica. Il poker. La barba fatta tutti i giorni.
All’inizio avevo provato a chiedere alle guardie schiuma e rasoio. Ma non c’era stato verso. Il rasoio era troppo pericolo sia per me che per gli altri.
Quindi barbiere. Due volte al mese, ma senza schiuma, solo con la macchinetta.
Fu proprio la barba incolta, che da sempre odio sul mio viso, a darmi la misura dell’assenza di libertà a cui ero costretto.
L’idea di entrare nuovamente in carcere mi spaventava principalmente per questo.
Uscii un martedì pomeriggio di novembre. Fuori iniziava a soffiare il vento gelido dell’inverno. Respirai forte per qualche minuto.
Non sapendo dove andare, con le mie quattro robe addosso, andai da Tony.
Quando mi vide, fece un sorriso che mi sembrò vero.
«Finalmente sei uscito», mi disse mentre asciugava un bicchiere.
«Fammi il vodka tonic più forte che riesci», gli dissi.
Lui riempì il bicchiere di ghiaccio e vodka. Aggiunse solo alla fine una goccia di acqua tonica e una fettina di limone.
Me lo scolai prima che il ghiaccio raffreddasse il bicchiere.
«Devi farmi un favore», dissi quando finii. «Devi dirmi dove posso trovare Smilzo».
«Lascia perdere, Paolo», mi disse posando lo straccio sul bancone.
«Quella è storia passata, non ci pensare. Ora te ne vai a casa, ti fai una doccia e domani te ne vai tutto il giorno a pescare. Ti rimetti a posto le idee e torni in pista».
«No, Tony. Lo devo a Granchio».
«Fai come vuoi. Comunque non ho idea di dove sia questo tizio. È venuto ancora qualche volta da allora, ma sono almeno sei mesi che non si fa vedere da queste parti».
«Il vodka tonic te lo pago appena riesco», dissi sulla porta.
«E tagliati la barba, che non ti si riconosce nemmeno», urlò.
E fu la prima cosa che feci tornato a casa, la barba. Mi spogliai tutto, accorciai i peli prima con le forbici. Immersi la faccia sotto l’acqua calda, un lusso che avevo dimenticato. Poi presi la schiuma e iniziai a passarla su tutto il viso. Mi lasciai accarezzare dalle mie mani per diversi minuti. Solo quando il fresco iniziò ad arrivare alla pelle, presi il rasoio e iniziai a tagliare via quei lunghi otto anni.
Sono davanti alla impiegata della banca. Non riesce a guardarmi negli occhi, mentre la mia pistola le punta ancora la testa e le urlo di riempire la sacca che le ho passato.
Di Smilzo si sono perse le tracce. Forse sapeva che sarei uscito e si è trovato una buonuscita migliore di quella che gli avrei riservato io.
Quest’ultimo colpo e cambio aria anche io. Da piccolo ero stato a Marsiglia un paio di giorni con un mio prozio. Mi era piaciuta la gente e magari potrei tornarci.
Scatta l’allarme della banca. La ragazza adesso sembra più sicura di sé. Io invece continuo ad avere il cuore a mille e ora anche le mani iniziano a sudare.
Vedo le stesse facce di dieci anni fa.
Forse ho fatto una cazzata.
Sento le sirene arrivare.
Altri anni di carcere, chissà quanti stavolta. Altra vita buttata all’aria.
Mi guardo intorno, sono ancora tutti a terra ma forse hanno capito che si salveranno.
Butto la borsa a terra. Senza accorgermene, sto girando la pistola verso di me.
I ricordi sono al tempo stesso una fortuna e una rovina, senza saremmo scatole vuote e solo la mutazione darebbe senso alla vita. Un accadimento resterebbe importante se, pur non avendone memoria, influisse in qualche modo sul nostro cammino. Se non potessimo ricordare il profumo, o il colore di un fiore, non avrebbe senso fermarsi ad ammirarlo, perché un istante dopo sarebbe come se quel fiore per noi non fosse mai esistito, ma se il profumo o il colore di quel fiore, al di là del ricordo mancante, condizionassero le nostre scelte e, per esempio, ci facessero interessare a un uomo perché ha quello stesso profumo o perché ha una camicia di quel colore, allora ci sarebbe ancora un senso nelle cose.
D’altra parte i ricordi possono essere una rovina. Quando resti ancorato alla tua vita passata, quando il ricordo di ciò che non sei più, dei tempi felici, della mancanza di pensieri, ti impedisce di guardare con mente sgombra al futuro, allora sono un peso che opprime, sono una soffocante coltre di fumo.
Da quando l’incidente di Trieste ha obbligato Stefano a vivere in carrozzella e con la misurazione continua della glicemia abbiamo smesso di esistere, offuscati dal ricordo di ciò che eravamo, incapaci di edificare un nuovo futuro. Ha perso la voglia di combattere e io non sono in grado di aiutarlo. I giorni si ammucchiano uno sull’altro. Mescolati alla noia e alla rassegnazione producono una schiuma appiccicosa dentro la quale restiamo sempre più impantanati. Quello spirito agonistico che lo spingeva nella gare di enduro, che gli faceva aggredire la vita, si è spezzato insieme al pancreas e alla colonna vertebrale, e da allora boccheggia, attaccato al respiratore dell’adrenalina.
Tra casa nostra e il mare c’è uno snodo ferroviario dove per la maggior parte del tempo manovrano treni merci e sferragliano vecchi interregionali, ma una volta al giorno, prima che sorga il sole, ci si incrociano anche due intercity.
Un anno fa, quando siamo passati di qui al culmine di una notte insonne, Stefano ha avuto un guizzo. Le luci dei convogli che puntavano l’uno contro l’altro sembravano gli occhi di due pistoleri, e lì è nata la folle idea: tornare la mattina seguente per attraversare i binari prima che i due intercity si incrociassero, mentre correvano l’uno verso l’altro. Non so cosa mi fosse passato per la testa, ero annullata dalla sua rassegnazione, e, trascorsa un’insolita notte serena, l’avevo accompagnato a quello snodo. Una rete metallica scurita dal sole, e venti metri di terra incolta, separavano la strada dal piazzale di cemento solcato da due coppie di rotaie. Erano le cinque di mattina, la strada era buia. Coperti dal furgone lasciato lungo il ciglio avevamo creato un varco nella rete utilizzando le pinze multiuso di cui Stefano un tempo andava fiero. Era stato facile, la rete era lasca e sfibrata. Non c’erano sentieri, ma il terreno era abbastanza regolare e senza grande fatica, nonostante le ruote ogni tanto impuntassero o scartassero di lato, avevamo raggiunto i binari e lì era partita la nostra attesa. Non ci era voluto molto, i treni erano regolari. Cinque minuti, i nostri occhi sembravano sanguinare insieme, poi, Stefano rivolto indietro e io piegata verso di lui, avevamo attraversato le rotaie mentre i due intercity si affacciavano ai lati opposti dell’orizzonte. Era stata una follia, anche se i convogli erano lontani sarebbe potuto succedere qualunque cosa, ma aveva sortito il proprio effetto: la vita era scorsa nelle vene e gli occhi avevano smesso di sanguinare. Per qualche mese l’adrenalina ci aveva reso di nuovo umani. Ma, come ogni cosa artificiale, quella scarica si era affievolita e qualche tempo dopo eravamo dovuti tornare ad affrontare di nuovo la sorte. Varco. Attesa. Paura. Noradrenalina. Anche la seconda volta aveva funzionato, ma l’effetto durava sempre meno, si consumava più rapido di un cerino al vento, e da allora, drogati in cerca della dose, siamo tornati a quello snodo, a questo snodo, a cadenze sempre più ravvicinate come più vicini sono i treni, ogni volta, nel momento in cui attraversiamo.
E siamo qui, l'ultimo velo della notte che avvolge la collina, il forte sentore che la sfida potrebbe giungere a una fine. Come al solito, abbiamo lasciato il furgone fuori dalla rete, chiavi sul cruscotto e portiere solo accostate: quel mezzo è l’unica cosa che Stefano riesca ancora ad amare. “Se non riusciamo ad attraversare”, ha detto una delle prime volte, “vorrei che qualcuno lo potesse prendere senza rompere nulla”. Stefano, invece, è la cosa più importante della mia vita.
La smania ci ha fatto arrivare presto. Siamo a filo della rotaia da più di mezz’ora. I treni merci, dall’altra parte del piazzale, continuano a lavorare senza curarsi di noi. Credo che non ci possano vedere perché siamo offuscati da un grosso faro che punta nella loro direzione. A un tratto, Stefano dice qualcosa sul fatto che quei treni merci sembrano dei piccoli vermi colorati. Lo prendo per un accenno di dialogo, invece lui ne approfitta per trasformare la mia risposta in una provocazione sull’inutilità della nostra vita e sul senso di quello che stiamo per fare. Attraversare i binari mentre due intercity corrono l’uno verso l’altro è solo una follia, che cosa gli dovrei dire? È normale che due persone trovino la forza di andare avanti solo sfidando la morte, in cerca di una scarica di adrenalina? È quanto meno surreale. Ci vorrebbe uno psicoterapeuta, per tutti e due, ma Stefano si rifiuta di affrontare le cose. Ce l’ha sempre fatta da solo, dice, e crede di poterlo fare ancora. Non è così, quello che stiamo facendo ne è la palese dimostrazione. Da parte mia, ho paura a contraddirlo. L’incidente ha condizionato anche la mia vita, non è facile vivergli affianco, ma è solo lui che non potrà mai tornare indietro. Io non lo abbandonerò, ma se volessi potrei farlo. Per lui, invece, non c’è nessuna via d’uscita. Allora accetto le sue scelte, cerco di farle mie, e sono qui, ancora una volta, a mettere in gioco la mia vita.
Oggi è particolarmente freddo. Lo dico anche a Stefano e, mentre lo faccio, esce uno sbuffo di vapore che si dissolve prima di arrivare alla sua testa. Ha sempre avuto dei bei capelli, mossi e folti. Da qualche tempo son diventati sale e pepe e gli danno un tocco di vissuto che, se non fosse per lo sguardo inerme, lo renderebbero più affascinante di prima. Lo riprendo, perché si sarebbe dovuto coprire meglio, e mi accorgo subito della sciocchezza che ho detto. Lui pare che non aspettasse altro e ironizza sul nostro futuro e sul fatto che, se non riusciamo ad attraversare i binari, non saranno il raffreddore o la tosse il problema. È crudele, ma ha ragione, e io sono la solita svampita: continuo a ragionare come se tutto fosse normale. Il fatto è che io penso che potrebbe ancora esserlo, che non sono la carrozzella o l’insulina a distruggere la vita, ma è la sua apatia. Solo che non riesco a dirglielo, ho paura di perdere quel sottile equilibrio sul quale ogni giorno sopravviviamo. E se costringerlo ad affrontare i nostri problemi lo facesse cadere in una vera depressione? Non me lo posso permettere, così cerco di fare mio il suo punto di vista, per comprendere che non ha più tempo o spazio per l’amore, per non rischiare di rimanere sola, per convincermi che sto facendo la cosa giusta, l’unica che mi è concessa di fare: mettere di nuovo la mia vita nelle sue mani, e nella forza delle mie.
Da quando siamo arrivati è come se avessi la testa altrove. Ho risposto a Stefano col suo stesso modo di fare: monosillabi e interruzioni. Ho uno strano presentimento, ma non è questo il punto, se andasse male sarebbe semplicemente la fine del nostro patire. No, quello che mi rende distante da questa scena non è la paura di non attraversare in tempo, ma qualcosa che dipende dalla giornata, dal cielo che ci mette più del solito a schiarire, dai residui tossici che si sono ammucchiati negli ultimi mesi. E quando Stefano mi chiama, e grida, e la mia testa e il mio corpo tornano a essere una cosa sola, la sua voce mi arriva accompagnata dalle note frenetiche degli intercity, già vicini. All’improvviso sento le punture del freddo per il quale lo avevo stupidamente ripreso. Poi mi accorgo che non è quello a farmi tremare, ma le vibrazioni del suolo e, ancora di più, le scariche che il mio cervello produce senza che io me ne renda conto, quel meccanismo che fiuta il pericolo e mette in allerta ogni parte del mio corpo e sembra dire: è ora degli straordinari, signori! I due intercity sono davvero vicini. Quel poco di raziocinio che non è ancora stato surclassato dalla noradrenalina mi fa pensare, per un istante, che è troppo tardi e troppo rischioso. Solo una breve e inutile riflessione, solo quella, prima che arrivi di nuovo il grido di Stefano. Urla, e guarda davanti a sé. Esistono solo i binari la carrozzella e i treni. Dice che è ora di andare. Impreca. CAZZO VIRGINA ANDIAMO! E allora, anche se so che questa volta abbiamo esagerato, smetto di pensare, getto anche io lo sguardo oltre i binari e mi lancio insieme a lui, mi lancio a sfidare la sorte in cerca della vita. Cemento, ferro e acciaio trasmettono vibrazioni che si disperdono tra le ruote della carrozzella e le mie braccia irrigidite. Le luci dei due treni abbagliano, sono talmente vicine da farmi sentire avvolta da lampi. Immagino che, per la prima volta, ci vedano anche i macchinisti perché sento il fischio delle loro sirene, mai udite prima. Avvisi inutili: non possono fermare i treni e neppure farci attraversare in maniera più veloce. Solo la nostra volontà, la mia volontà, la mia energia, il mio attaccamento a questa dannata vita, può tirarci in salvo prima che si incrocino i due treni. E io spingo e scalpito, mentre tempo e spazio sembrano diluiti. Dieci metri da bruciare in pochi secondi, eppure ritorno a pensare e mentre scavalco la terza rotaia mi viene il dubbio che non servirà a nulla: il vuoto creato dal secondo intercity ci risucchierà indietro, siamo spacciati. E se non sarà il vortice a farci morire, saremo noi stessi, sarà l’assuefazione alla noradrenalina, sarà la voglia di Stefano di stare male, la sua paura di fidarsi di nuovo della vita, la mia, di non riuscire a stargli affianco. E allora, anche se siamo a un passo dalla salvezza, smetto di spingere. Mi lascio andare. Che la sorte compia il nostro destino.
Ma la sorte, lo avrei dovuto immaginare, è più avanti del mio pensiero. Nella frazione di secondo in cui mi illudo di sconfiggere la vita, l’inerzia mi porta oltre la terza e la quarta rotaia. C’è il risucchio dell’intercity, ma è poco più forte di una folata di vento. Il cuore mi scoppia dentro il cervello. I polmoni si comprimono e cercano di dilatarsi senza tregua. Lo sferragliare dei convogli, a pochi metri da me, sovrasta ogni rumore come un mare in burrasca. Appena riesco a riprendere fiato mi volto per guardarli correre via, due luci che si perdono in direzioni opposte in questa lacrima di notte mista al mattino. Solo quando mi giro di nuovo, il sudore che si ghiaccia intorno alle tempie e lungo la schiena, mi accorgo che davanti a me c’è Stefano sulla carrozzella.
Non dice nulla. Non lo faccio neanche io. Non vado neppure in cerca del suo sguardo. Quando i treni sono svaniti e il cuore rientra nell’angusto spazio in mezzo al mio petto, torno a stringere i manici di plastica. Inermi. Isolanti. Manovro la carrozzella, cambio direzione e insieme a lui ritorno indietro. Non so cosa passi per la sua testa, ma nella mia sento che è ora di cambiare. Da qui in avanti voglio ritrovare almeno un briciolo di gusto per la vita.
Estate
Cammino ciondolante sul fare della notte, attendo la scomparsa dell’ultimo brandello di luce che, come è d’uso in questa stagione, se la prende con comodo.
Evapora il sudore dal vestito della rue Zola e il tempo si sospende nel suo circolo mostruoso che ributta in faccia il fumo di una sigaretta. Ancora Parigi, ancora estate, ancora girovagare.
Non è rimasto niente dello scorso maggio, non una goccia di sangue sul selciato, non la carta dei giornali, tutto è scomparso con le barricate e io solo alla fine dei giochi seppi che era successo qualcosa, ma non mi interessava neanche sapere cosa, so solo che improvvisamente tutti i “cani da guardia” abbaiano ai propri padroni.
Entro nel bar e ordino un pernot, bevo e ne chiedo un altro, li butto giù con la maestria di un violinista gitano.
Il fumo entra nei polmoni, gli occhi si fanno sottili. Penso a Margherita e mi aspetto di vederla entrare da quella porta da un momento all’altro.
—Oh, ma chi abbiamo qui?! Il nostro caro poeta Paul Zelano —
Vacilla lo sguardo per trovare un panciuto borghese.
—Che vuole monsieur? —
—Oh niente, solo presentarle la dolce Yvonne Talloi, sa, anche lei s’intende d’arte.—
L’occhio rotola sull’orlo del bicchiere e ci cade dentro. Butto alcool in gola e mi vedo annegare mentre il garçon me ne riempie un altro.
—Non m’intendo di nulla, io.—
Con le punte degli occhi trafiggo il petto del disturbatore. Sporco e banale imitatore di Heidegger; è lui, la puttana dell’università, il ruffiano degli artisti, il compagno da salotto, Jean-Paul Partre.
—Ah cara Yvonne, lo sa come sono questi poeti: sempre un po’ maledetti.—
Scorgo una giovane donna, gentilmente vestita di chiaro, sublime nello sguardo fermo, da donna vissuta. Non ha succhiato neanche la metà dei miei anni, i miei anni di sangue e merda nei campi della Bassa e nel confino lucano, ma ciò nonostante pare sicura e invincibile, molto più di me, o forse è solo giovane. Ingollo il bicchiere, lei aspira il fumo da una sigaretta con aria pensosa e profonda.
—Così lei è Paul Zelanò, il poeta.—
—Sono solo un mediocre lettore di italiano presso la Sorbonne, nulla a che vedere con il magnifico qui presente Jean-Paul Partre, uomo di mondo, filosofo complesso e persona profonda. Alle sue lezioni c’è più folla che a quelle di Foucault. Lui le farà conoscere tutta Parigi.—
—Ah, troppo buono.— finge di non cogliere sarcasmo e disprezzo, o forse sa che è solo invidia, la mia, e non vuole darmi soddisfazione.
—Mi piacciono i suoi versi.— la ragazza esprime il più banale giudizio sulla poesia che si possa avere. — E mi piacerebbe poterla fotografare e chiederle cosa pensa dei miei lavori.—
—Fotografa? Non ce ne sono abbastanza di copiatori della realtà?—
—Oh, ma io non copio la realtà, io la limito, io la creo.— e la sua voce è vibrante come il serpente schiantato da Dio nella casa dell’uomo dopo la creazione.
—Io ho avuto modo di vederle e sono rimasto estasiato.— dice l’accomodante ruffiano.
—Sono felice per lei.—
—Vorrei organizzare la prima personale di questa ragazza, così giovane e così talentuosa.— il ribrezzo per quell’uomo mi scava lo stomaco come un’ulcera.
—Vorrei finire di sbronzarmi e poi cercarmi una puttana abbordabile.— l’anticonformista filosofo borghese fa uno sguardo stupito, poi gli sovviene che è antimoralista e sorride accomodante.
—Beh, chi siamo noi per interrompere una così nobile occupazione?!—. Poi, rivolto alla ragazza:— Andiamo Yvonne, l’accompagno.—
Yvonne, statua di ghiaccio immobile, sguardo che affonda la carne.
Si avvicina licenziosa e sinuosa come lingua di fuoco, spegne la sigaretta tra le altre nel posacenere accanto a me e la sua bocca è vicina al mio orecchio, cerco di mantenermi calmo mentre il suo odore mi confonde le viscere. Sussurra, facendo uscire il fumo, e le sue parole vellutate mi sfiorano delicate: —È stato davvero un piacere, spero di rivederla.— Rossetto rosso, labbra vibranti, bianchi denti, occhi verdi, biondo cenere i capelli; il collo è sottile ed elegante, le dita affusolate e smaltate di amaranto… Il mio corpo è un vibrante cazzo eretto nella sua pulsazione finale.
La ragazza è entrata in me con tale violenza da sentirmi stuprato. Improvvisamente ogni altro pensiero è caduto giù per il bancone del bar in un solo impeto biochimico e Margherita sembra non esserci mai stata nella mia vita.
Escono. C’è ancora luce, lui le apre lo sportello per farla entrare nella decappottabile. Lei indossa il cappello e gira lo sguardo verso di me. I nostri occhi si toccano scambiandosi una promessa. Ora non so più se è giorno o se è notte.
Autunno
Yvonne, Madonna vestita di candido, puttana abbarbicata, lì, sulla sedia. Il caschetto incornicia il viso di perla, la bocca sottile piegata in una leggera smorfia; nere e voluttuose le labbra succhiano il bocchino di una sigaretta. Sottile veste di lino e seta, intravedo il piccolo seno, l’ombelico come una coppa e, tra le gambe accavallate, il nero del suo intimo. Vorrei gettarmi su di lei e poi supplice ai suoi bei piedi nudi implorarle di farmi assaporare il suo odore sulla punta della lingua; e poi baciarle le ginocchia e le cosce e strapparle tutto, arrivare al sesso per bere il suo nettare dandole piacere in tutti i modi in cui un uomo può dare piacere a una donna.
—Allora Paul, che ci fai qui?—
—Ero venuto a trovarti…—
—Eri venuto a trovarmi o a provarci di nuovo?—
—Forse tutt’e due…—
—Paul, ascolta, te l’ho già spiegato, non può continuare. Ti faresti solo del male.—
—Tu mi ami ancora.—
—Non lo so se ti amo, non so neanche cosa sia l’amore francamente, so solo che… che sei geloso, morboso, possessivo. So che mi vorresti tutta per te, sempre, ma io non voglio esser tutta per te, né per nessuno, voglio essere libera di costruire la mia vita sessuale ed emotiva con la stessa libertà con cui costruisco le mie foto.—
—Ma io ho bisogno di te Yvonne. Ho bisogno di te e tu lo sai—
—No, non è vero. Nessuno ha davvero bisogno di qualcuno e tu non fai eccezione. Tu, come tutti, hai bisogno di una scusa per vivere, per dare senso alla tua vita. Io sono la tua scusa per scrivere e scrivere dà senso alla tua vita. Quando non ci sono mi vuoi vicina, quando ci sono puoi dedicarti alla poesia, la tua vita non può dipendere da me, né da nessuna donna.—
—Ti prego—
—No.— sigaretta finita, si alza —Conosci l’uscita.—
—Io… io posso accettarlo… posso provarci perché… perché lo capisco
—Lo so che lo capisci.— percorro la sua schiena con le dita degli occhi e l’immagino nuda. Si volta leggermente e mi avventato sul suo collo a baciarlo. No, lo sto immaginando, sono fermo, davanti la sedia dell’ingresso con il cappotto ancora addosso, la porta alle mie spalle e il cappello in mano come un questuante. Imploro con gli occhi l’epica di un amplesso, ma lei taglia il mio delirio col coltello: — C’è una persona nell’altra stanza—gelo— sto per andare a letto con lei, di nuovo, come ho fatto tutta la mattina. Lo accetti?—
—Io… io… devo andare.— imbocco l’uscita.
Non mi scandalizza che ci sia un altro, o un’altra, nella sua stanza, non m’importa chi si scopa o chi ama, tutto ciò che mi disturba è che non sia io.
Scivolo per strada, il sole è una palla rovente in un gelido autunno. Il vento gioca con le foglie, le uccide, le porta ai piedi di anonimi passanti in uno stupefacente spettacolo di morte senza resurrezione. Vorrei andar a giocar la mia vita a dadi col mio amico Topo, ma ho la testa piena di lei… Ah Yvonne, Yvonne, ricordi che pochi giorni dal primo incontro convincesti Partre a invitarmi alla sua villa per una festa estiva?, e ricordi che facemmo l’amore nelle sue stanze mentre brontoloni universitari e sedicenti artisti vagavano per il giardino? E le mie poesie ti piacevano, mi convincesti a presentare il nuovo libro e alla conferenza io ti aspettavo tremante e disarmato.
I nostri giorni insieme sono passati intensi e maestosi come le onde del mare che mi risospingono ancora alla riva delle tue cosce, le tue cosce che mi raccontano la vita, la carne, l’amore come se dal mio mezzo secolo non avessi appreso nulla. Prima di te mi preparavo all’oltretomba, ma con scarsi risultati, adesso voglio la vita.
Inverno
Io, Paolo Zelano, malinconico poeta senza fama, senza gloria, orfano, superstite di una grande guerra, migrante, italiano, parigino, amante… Immobile davanti la porta del tuo appartamento spio i tuoi passi. Vedo gente entrare e uscire dal tuo palazzo e mi chiedo se verranno da te confessandoti le loro fragilità. E tu? Sarai fragile anche con loro come lo eri con me?
L’alba e il tramonto mi scivolano addosso, cerco di pedinarti arrancando ubriaco per strade ghiacciate. Mi hai dato un amore che non pensavo di poter provare, che non credevo di esserne ancora in grado. Yvonne, ora sei lì, chiusa nella tua casa a guardare le fotografie, a sistemarle per la mostra. Sei in una camera oscura o in un parco pubblico a litigare con la luce. Ti spio nella sera dei miei giorni e non so da quanto non mi presento in facoltà. So che mi sveglio tardi, so che non dormo, so che mi masturbo pensandoti; so che giro rabbioso per le strade in cerca di qualcuno da sbranare come fanno certi cani abbandonati.
Perdio Yvonne!, cosa fanno le tue labbra quando non mi baciano? Cosa stringono le tue braccia quando non ci sono?
Possessivo, fragile, geloso… hai ragione, sono un vecchio… sono tutto ciò che pensavo di odiare, un uomo che si attacca alla materialità della vita con le unghie e con i denti, non disposto a condividere nulla con nessuno.
Ti guardo uscire di casa vestita calda per serate mondane e quando mi scorgi mi celo nell’ombra e ansimo al pensiero di stringerti il collo tra le mani per vederti spirare mentre l’ultima fotografia la scattano i tuoi occhi guardando imploranti i miei. Mi perdonerai e mi stringerai e mi amerai ancora e per sempre… Ti desidero, ti strapperò i vestiti, ti salterò addosso e ti violenterò per strada, in un vicolo o in pubblica piazza, e tu godrai come una santa puttana in estasi davanti al suo Cristo, sì.
Calma!, respira, sono lucido… sono un semplice vagabondo di strada durante un gelido inverno; sono uno stereotipo, un penoso vecchio poeta che aspetta una donna che non arriverà mai e che fuma sigarette mentre il vento lo percuote, la pioggia lo bagna, la salute lo abbandona. Non è romantico, è patetico!
Ti smaltirò come si smaltisce la sbronza. Ti dimenticherò e amerò ancora o forse non amerò mai accettando di buon grado l’impotenza della vita.
Tossisco e dolorante mi porto verso casa, come ogni notte.
Parigi è grande, ma finisco sempre al tuo portone, Yvonne, desideroso, sognante, illuso. Quando realizzo cosa sono davvero ritorno a casa, sconfitto. Con secchiate di gelida lucidità mi convinco che alla fin fine tutto scompare nel nulla e che tutti gli amori scompaiono prima o poi dalla mente, come gli affetti e i ricordi più intensi. Tutto si fa opaco e allora mi chiedo, quando metto la chiave nella toppa, ho mai amato davvero prima di te oppure semplicemente continuo a trovare oggetti per riversare il mio amore?… magari ogni “ti amo” è una bugia o, e forse hai ragione, è una scusa.
Primavera
Giunge sottile la notte da sotto le porte e l’inverno alle spalle ha piegato il mio corpo. Una donna che amavo ha fatto la sua prima personale di fotografia. È stata un successo, ho letto di lei sui giornali, non l’ho vista perché malato… ma oggi sto meglio, mi sento di camminare, anche se non so dove. Forse mi basta sbirciare la primavera che profuma una Parigi notturna, così romantica, così viva, come la luna che si specchia nella Senna.
Passeggio lungo il fiume e cerco Topo, un clochard, un mio amico, gli darò i miei ultimi scritti e se ne farà un giaciglio. Una volta mi disse che aveva deciso di fare il barbone quando, da piccolo, salì sulla Tour Eiffel per prendere una stella, quando vide che quelle restavano comunque troppo lontane capì una verità e si disse: — e a me chi me lo fa fare di salire in cima quando si vedono uguali da giù? —
La lezione di Topo non l’ho mai imparata, dalle delusioni, io, non imparo mai.
Sapete?! ho mentito, io so dove sto andando, sto andando in rovina, sto andando a cercare la luce nel fiume, sto andando a impedire l’orrore con cui un nuovo amore ti sveglia al mattino per cancellare tutti quelli passati.
Percorro la Senna cercando sotto quale ponte si è messo il mio amico così da dargli in poesia quel che resta dei miei giorni andati come schiuma di mare, quando, dopo l’onda, non resta più niente. Che scherzo crudele, che triste esistenza quella di un uomo e di una donna fragili e inconsistenti. La schiuma che decora le onde decora anche i giorni, ma alla fine, di essa, in entrambi i casi, non resta che qualche confuso ricordo… ecco che me ne sovviene uno non troppo opacizzato, chissà perché proprio questo.
Camminavo con Yvonne lungo il fiume.
—La fotografia non deve trasmettere la realtà, almeno la mia fotografia. La mia fotografia esprime il mio occhio sulla realtà, io quella gran cosa che è la realtà la taglio, perché per me non esiste, esiste solo quello che posso strappargli con il mio obiettivo, perché quel mondo che c’è in foto è un mondo completo pieno di me… anche se non vi compaio mai… mi segui?—
—Sì.—
—Grazie… ci sei anche tu nel mio mondo.—
—E anche bello in posa…—
—No, quelle sono foto… ricordo, diciamo… no, tu sei nel mio mondo perché ti ho fotografato mentre dormivi, quando non mi vedevi, così ho catturato il tuo corpo e l’ho riempito col mio… cioè… il mio “spirito”… no, così suona di merda.—
—Tranquilla ho capito. Tu “addomestichi” il mondo.—
—Sì… come direbbe quel tale algerino io voglio firmare il mio passaggio, ma per farlo devo ritagliarmi un pezzo di vita, insensata ed effimera, e fare in modo che duri e che dica “Yvonne Talloi è esistita”. E non m’importa se non sapranno chi ha fatto quelle foto o che fine faranno, l’importante è che ci siano perché dove sono loro ci sono anch’io, che la gente lo sappia o meno, che capisca le mie foto o meno. Non me ne frega niente se mi dicono sono belle, sono brutte… sono mie, sono io, anche in quelle così brutte che ho strappato… Capisci?—
—Capisco.—
Lui è BILLY ed è calabrese.

 Recuperato che girava da solo per le strade, ora si trova in stallo, ma presto finirà in un orribile canile.
Recuperato che girava da solo per le strade, ora si trova in stallo, ma presto finirà in un orribile canile.
Ha quattro anni ed è positivo alla leishmania seppur con titoli bassi, il che gli permette di vivere serenamente prendendo qualche pastiglia.
E’ un cane buono e molto coccolone e si affida previo colloqui pre e post-affido in tutto il nord Italia.
Per informazioni potete contattare Francesca al numero 338.2023947 oppure Stefania al numero 320.6664123
Vi presento VIOLETTA.

 Violetta ha solo un anno ed è stata abbandonata all’inizio di questa estate.
Violetta ha solo un anno ed è stata abbandonata all’inizio di questa estate.
E’ una taglia medio piccola dal carattere mite: va d’accordo con cani e bambini.
Ha un problemino all’occhio destro, ma presto verrà operata, e anche sterilizzata, così da essere pronta per l’adozione.
Si trova in un canile nelle Marche, ma per una buona adozione può spostarsi.
Per maggiori informazioni su di lei potete contattare Giovanna al numero 339.1197433 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo: katia.dog@tiscali.it
Al canile di Ginosa, Taranto, ci sono questi cuccioli che attendono di essere adottati. Hanno fra i due e tre mesi e sono stati recuperati nelle campagne pugliesi: non facciamoli crescere in una gabbia.
Hanno fra i due e tre mesi e sono stati recuperati nelle campagne pugliesi: non facciamoli crescere in una gabbia.
Ce ne sono di varie taglie, incroci ed età.
Per una buona adozione possono raggiungervi in tutta Italia.
Per informazioni potete chiamare il numero: 339.6390998
Ecco a voi STAR. Questo povero stellino è stato recuperato a soli quaranta giorni in un fienile insieme ai suoi due fratelli dopo che la mamma, per difenderli, è stata sbranata da un cane.
Questo povero stellino è stato recuperato a soli quaranta giorni in un fienile insieme ai suoi due fratelli dopo che la mamma, per difenderli, è stata sbranata da un cane.
Ora i suoi fratellini sono stati adottati mentre lui, a tre mesi e mezzo, cerca ancora una famiglia.
E’ diventato un micino tutto fusa e coccole che adora il contatto umano.
Si trova a Torino e verrà dato in adozione solo nei dintorni previo colloquio pre e post-affido.
Per altre informazioni e adozione, potete contattare l’associazione Micio Villaggio all’indirizzo e-mail: miciovillaggio@gmail.com oppure scrivendo un messaggio al numero 339.8108751 (sarete ricontattati).
Questi micini sono stati recuperati da diverse situazioni difficili e ora convivono tutti in una stanza nell’attesa di trovare una famiglia.




 Sono sia maschi che femmine e hanno fra i tre e i cinque mesi. Verranno affidati vaccinati e spulciati previo controllo pre affido in tutto il nord Italia.
Sono sia maschi che femmine e hanno fra i tre e i cinque mesi. Verranno affidati vaccinati e spulciati previo controllo pre affido in tutto il nord Italia.
Pr informazioni su di loro potete contattare il numero 349.3153523
Ecco WENDY.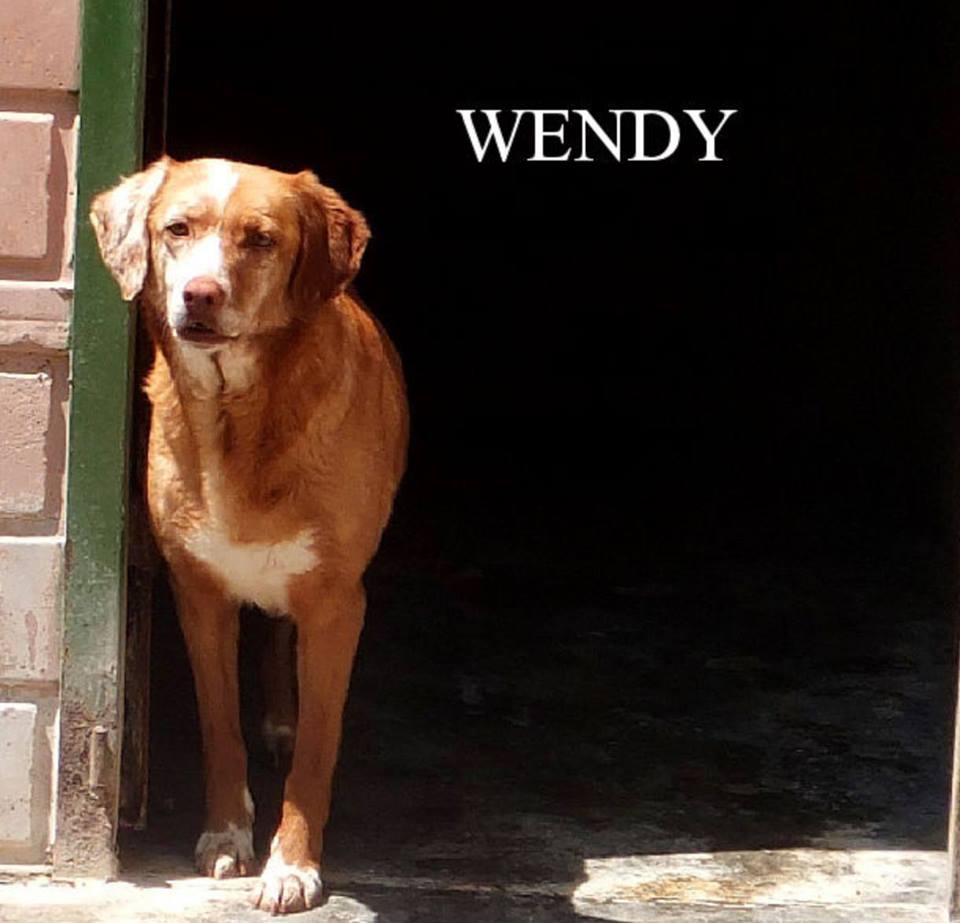 Wendy è entrata in canile nel 2009 quando aveva solo due mesi, insieme alla sua mamma e altre due sorelle che sono state adottate. Lei invece non è stata fortunata e, mentre cresceva, il tempo è passato rendendola paurosa e molto timida.
Wendy è entrata in canile nel 2009 quando aveva solo due mesi, insieme alla sua mamma e altre due sorelle che sono state adottate. Lei invece non è stata fortunata e, mentre cresceva, il tempo è passato rendendola paurosa e molto timida.
Si trova in un canile vicino a Roma, ma per una buona adozione può arrivare anche al nord Italia previo colloquio pre affido.
Qui potete vedere un suo video.
Per informazioni potete contattare le volontarie del canile:
Manuela al numero 393.4080484 o all’indirizzo e-mail manuelacip.aclonlus@gmail.com
oppure Giada al numero 347.2887902 o scrivere una e-mail all’indirizzo giadadg.aclonlus@gmail.com
Lei si chiama GIULIA, come me.
 Giulia lei, però, è una segugetta di taglia media, di circa un anno che vive in gabbia.
Giulia lei, però, è una segugetta di taglia media, di circa un anno che vive in gabbia.
Ora si trova in una pensione a spese dell’associazione Una luce fuori dal lager che l’ha salvata da un canile lager in cui probabilmente sarebbe morta.
E’ un cane estremamente buono e va d’accordo sia con le persone che con i suoi simili.
Cerca casa in Lombardia previo colloquio pre affido.
Per informazioni o adozione, potete contattare i numeri: 338.1658329 oppure 333.9521373
Loro sono MARGOT e MORGAN e cercano preferibilmente una famiglia che li adotti insieme. Sono arrivati nel gattile di Cuneo ancora piccoli e ormai sono lì in gabbia da tre mesi.
Sono arrivati nel gattile di Cuneo ancora piccoli e ormai sono lì in gabbia da tre mesi.
Sono affettuosi con le persone, socievoli con gli altri gatti e molto delicati con i bambini.
Sono sani e verranno affidati vaccinati e microchippati.
Per informazioni o adozione, potete contattare il numero 349.1445712








