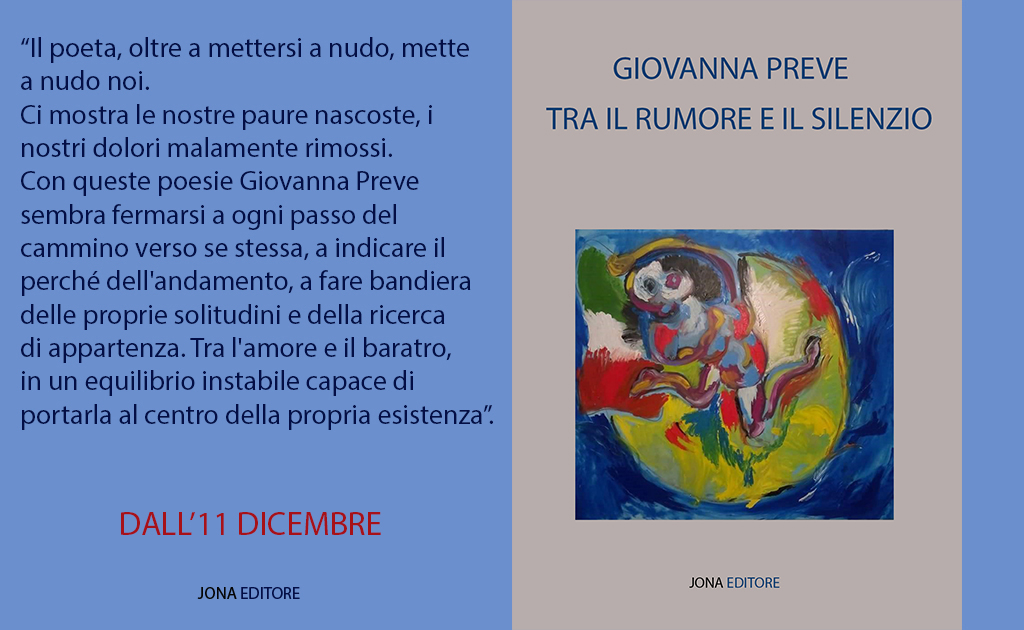ovvero: Il colore della cenere
«La neve, mamma!».
Era agosto, un caldo agosto. Uno dei più caldi che riuscissi a ricordare.
Non avevo mai visto la neve. Neanche lei, perché nella nostra città non era mai caduta, e lei, mi aveva detto, non si era mai allontanata da lì. Forse non lo avrebbe mai fatto se non fosse stata costretta.
La sua manina indicava il vortice che dall’alto si posava con leggerezza sulla terra. Si distendeva in un tappeto d’argento dalla consistenza fugace. Se si fosse chinata a raccoglierla le fessure tra le sue dita avrebbero fatto cadere tutto. Non avrebbero lasciato che una tenue sfumatura: la sua pelle, allora, sarebbe sembrata grigia, di un grigio chiaro. Lo stesso colore della cenere. Del riflesso della luna sulla cenere.
La sua mano era davvero piccola. E anche lei era piccola. Così piccola per affrontare quel viaggio.
«È solo polvere, tesoro», le risposi con un filo di voce, alzando gli occhi al cielo.
La cenere scendeva fitta accompagnata dal vento. Un vento sordo, silenzioso. Innaturale. Come la città dopo le bombe. Le belle strade, ora coperte di macerie, erano diventate vuote. Tristi.
«Sono le stelle, vero? È la polvere delle stelle?».
Mentre tutto si copriva di grigio e di bianco, risplendendo per contrasto nella notte sempre scura, la città sembrava ancora più morta. Era la cenere ad accendere le tenebre. E i sogni della bambina che camminava vicino a me.
Osservando i detriti che brillavano come statue immortali sorrisi, perché in mezzo alla morte, alla morte delle persone e delle cose, quella bambina alta poco più di un metro era ancora in grado di sognare. E sognava forte, con orgoglio.
«Esprimi un desiderio», le dissi.
Mi prese la mano e se la portò sul cuore. La punta del naso iniziò a disegnare cerchi leggeri nell’aria, verso l’alto. Scorsi i suoi occhi chiusi e la parte centrale della bocca scossa da leggere vibrazioni. Piccoli movimenti. Inconfondibili. Era una preghiera, una preghiera silenziosa. Le parole si erano fermate sulle sue labbra ed erano morte prima di toccare l’aria. Nessuno le avrebbe ascoltate. Nessuno avrebbe potuto. La bambina, però, non lo sapeva. Per lei un desiderio era solo un desiderio: avrebbe tanto voluto che diventasse realtà.
Così a lei restava la speranza, mentre io vedevo soltanto le briciole dei palazzi, dei rifugi e dei sogni. Erano ridotti in polvere. E nonostante la loro lucentezza restavano cenere. Cenere e macerie. Spettri di cadaveri in decomposizione.
Non c’era più niente. Niente che mi tenesse davvero lì, in quella che per dieci anni era stata la mia casa.
«Ti mancherà questo posto?».
Lo chiese senza lasciare la mia mano, continuando a stringermi. E pensai che stesse sorreggendo tutto il mio dolore, il peso che mio malgrado portavo sulle spalle.
Mi voltai a guardarla e incrociai i suoi occhi. Mi parvero meno brillanti, più velati. Forse erano stanchi. O forse tristi.
Così piccola. Così infelice.
«Ho con me tutto quello che mi serve...».
Provai a sorridere per rassicurarla, ma ne uscì fuori una smorfia, perché mi sentivo anche io piccola e infelice. Perché anche io avevo paura: di non essere in grado di badare a lei, quella bambina che la madre mi aveva affidato prima di morire. Ci separavano solo quattro anni, e i ruoli che la guerra ci aveva affidato senza chiederci il permesso, ma l’avrei cresciuta. Le avrei fatto da madre. E lei mi avrebbe fatto sentire un po’ meno malferma, un po’ meno mortale. Un po’ meno sola.
Finii per non chiederle che desiderio avesse espresso, anche se i suoi occhi sembravano aspettare quella domanda. Non avevo voglia di parlare. Ero anche io stanca. Avevamo camminato tutta la notte e dovevamo trovare un nascondiglio per il giorno. Contrariamente a quanto si potesse pensare, non era la notte il momento più pericoloso: chi guardava dall’alto, di notte trovava il mondo celato dal buio.
La bambina infilò le mani nelle tasche, ma avevo notato che erano sempre più grigie: la cenere si era infilata sotto le unghie e nelle venature del palmo. Anche il piccolo anello che portava all’indice aveva mutato colore. Era stato il regalo di sua madre. Se l’era sfilato appena in tempo. Aveva trovato la forza di sorridere mentre lo faceva. Sorridere per l’ultima volta.
Ogni giorno mi sembrava più spenta e iniziai a capire che dentro stava bruciando. Che stava morendo. Di una di quelle morti atroci, che sembrano lontane quando non si è provato sulla pelle che cosa sia la guerra.
Neanche noi la conoscevamo prima di allora. Non così bene, almeno. A scuola i libri ne parlavano, ma pensavamo fosse una cosa stupida, una cosa superata. Chi avrebbe voluto la guerra? E perché?
No, non avrei creduto che potesse esistere ancora. Che al mondo ci fosse qualcuno così incosciente da riportare la morte in vita.
Era l’ultimo giorno di scuola il giorno in cui il mondo è finito, per i morti, ma anche per i sopravvissuti. C’era una festa, una grande festa, ed erano presenti molti genitori. Eravamo appena entrati in classe e avevamo appoggiato i nostri libri sopra il banco. Leggere, per noi, era un lusso.
Un libro, un libro di carta e cartone, con la fodera a colori, era un dono che ricevevamo una volta all’anno dai nostri insegnanti e dalle nostre famiglie. Dovevamo resistere alla tentazione di leggerlo tutto d’un fiato. Era necessario diluire l’attesa per mesi, e quando purtroppo le pagine erano esaurite, o le ultime erano strappate, cosa assai frequente nella nostra zona, ricominciavamo da principio la lettura, sottolineando appena con il lapis le parole che alla prima lettura avevamo pronunciato senza comprenderle fino in fondo. Un libro doveva durare un anno intero. Poi sarebbe stato requisito, ripulito e ridistribuito. E non c’era modo di sottrarsi alla confisca della carta: la carta avrebbe composto lettere, biglietti in codice. Sarebbe stata lo sfondo di mappe e di conti complicati. O sarebbe rimasta ancora la base di un libro, la sua casa, il suo letto, pur cambiando forma. Il suo contenuto sarebbe mutato, come gli occhi di chi lo avrebbe scorto.
Il libro che mi era stato consegnato, e che avevo appena appoggiato sul banco, aveva la copertina azzurra. Era il mio colore preferito e speravo fosse di buon auspicio. Avrei tanto desiderato leggere di terre lontane, diverse dalla mia. Vivevo in una città senza cuore, priva d’anima.
Per fortuna c’erano molte pagine di carta: annusai il loro odore, in cerca di quel ricordo che io non custodivo, ma che la maestra ci aveva tramandato.
Trovate il profumo della carta.
E io lo cercavo ogni giorno, nella speranza che prima o poi uscisse fuori dal libro usurato e non ancora restituito, senza sapere come fosse quell’odore, il profumo di un libro fresco di stampa, forse asettico, forse impersonale. Così quella mattina lo annusai.
Il libro dalla copertina azzurra non emanava che un vago profumo acido che mi ricordava quello di una cantina. Le sue pagine erano leggermente taglienti e disegnavano un merletto imperfetto. Anche le cuciture erano grossolane: sapevo di dover prestare attenzione a non perdere la carta, l’oro bianco e ruvido che custodiva un bene ancora più prezioso, stampato appena in nero.
Sentii un aereo passare vicino al nostro tetto. Tremarono i vetri, e le gambe della maestra. I suoi occhi preoccupati ci osservarono con fare interrogativo e tutto vibrò ancora più forte, mentre un tuono accompagnava le scosse. La nostra insegnante urlò di nasconderci sotto i banchi. Di non pensare ad altro che a nasconderci. E io, prima di farmi ancora più piccola e chinarmi sul pavimento, ricordo di aver stretto più forte il libro azzurro per salvarlo da tutta quella distruzione. Invece sarebbe stato lui a salvarmi, ma io non potevo saperlo. Sarebbe stata la sua mano a posarsi sul mio cuore.
Quando le finestre schizzarono via in mille frantumi pensai che fossero simili a coriandoli. Coriandoli dalle magiche sfumature. E quei pezzi, pezzi appuntiti, si scagliarono contro i nostri corpi e i nostri sogni, tagliando e trafiggendo la carne e le cose.
Avevo paura a uscire fuori: non ero pronta a vedere la morte intorno a me. C’era qualcuno ancora vivo: si lamentava, farfugliava parole che per me non avevano senso. Sì, là, tra i vetri e il sangue, stavano pregando, chiedendo perdono. Chiedevano perdono prima di morire, come se una morte così violenta non fosse sufficiente a cancellare ogni colpa. E io, anziché aiutarli nella loro inutile preghiera, strinsi più forte il libro azzurro e mi accorsi che si era rotto: la copertina era squarciata dal vetro, proprio all’altezza del mio petto. Se non l’avessi avuto con me, probabilmente sarei morta.
Nell’aria si sparse un odore diverso. Non aveva una fragranza precisa, ma quando entrava nelle narici, quando si depositava sulla pelle, sentivo bruciare. Non vedevo niente di strano, oltre i frantumi di vetro e i corpi a terra che perdevano la vita.
Anche i vestiti bruciavano, tutto era fuoco, anche senza fiamme, anche senza vento ad alimentarlo. E anche io ero come fuoco: bloccata a terra, con le braccia impotenti rivolte al cielo. Avrei voluto gridare, ma nella gola tutto si fermava e si strozzava, incapace di uscire. Così mi trascinai fuori dalla classe, verso il bagno. Mi spogliai, mi spogliai di tutto. Lasciai cadere vestiti e libro a terra, e iniziai a lavare via quel bruciore, mentre i lamenti, nel corridoio, nelle altre aule, si facevano più deboli e più disperati.
Non sapevo dove andare, né che cosa fare.
Era la guerra quella?
Perché noi, noi bambini?
Sarei dovuta tornare a casa? O l’avrei trovata distrutta, come le finestre della scuola, come il libro dalla copertina azzurra?
Sarei riuscita a sopravvivere a tutto quel dolore?
Fu allora che la sentii. Era la voce di una bambina che continuava a chiamare la madre. Seguii la voce fino all’atrio: la piccola era nascosta sotto il corpo della mamma. Tossivano entrambe, ma la donna era stremata, stanca di disperarsi.
Poi la donna mi vide. E qualcosa nei suoi occhi cambiò.
«Vieni», mi disse. La sua voce era ridotta a un filo.
Obbedii, come un automa.
Si alzò sulle braccia, liberando la bambina dalla morsa sicura che l’aveva salvata. Si tolse l’anello e lo mise al dito della figlia.
«È mia figlia...».
Un colpo di tosse le impedì di finire la frase.
«…te la affido».
E sorrise, mentre la bambina mi prendeva la mano. E capendo che la sostanza invisibile aveva colpito anche la piccola, corsi a lavarla come meglio potei.
Quando ripassammo attraverso l’atrio, nude, impaurite, ma vicine, la donna non si muoveva più. Non avevo fatto in tempo a chiederle come si chiamasse la bambina.
La luce, fuori, era diversa dal solito. Poggiavamo i nostri piedi su un tappeto di macerie, vetro e carne.
«Stai attenta a non tagliarti», le dissi.
Non sapevo dove andare, né se fossimo al sicuro. Il sole era ovattato da nuvole sottili. I frantumi di vetro, a terra, riflettevano la sua luminosità. E poi c’era quello strato grigio, che prima non avevo mai notato. Non avevo mai notato perché non c’era. Non c’era la cenere. Non quella cenere d’argento. Risplendeva più del sole e del vetro. Per capire da che parte andare mi tappai gli occhi con una mano. Ma tutte le vie erano cancellate. C’erano nuove strade, strade di detriti, che i nostri piedi non erano pronti a calpestare.
«Cos’è successo alla mia mamma?», mi chiese quando eravamo arrivate in cima a un cumulo di ferro, cemento e polvere d’argento.
Io non sapevo che risponderle. Perché eravamo sole, adesso. Sole in quel mondo. Avrei voluto la mia di madre. O anche la sua. Qualcuno che mi proteggesse e che badasse a me. Avevo voglia di piangere e di gridare, ma rimasi in silenzio.
«Sei la mia nuova mamma, ora? Dove andiamo, mamma?»
La sua mano strinse più forte la mia.
Un palazzo era sopravvissuto. Dopo settimane di cammino, quella mattina avevamo trovato quello scheletro ancora eretto. Era il primo che trovavamo quasi intatto.
«Aspettami qui, Amal».
Avevo scelto questo nome. A lei era piaciuto. E le calzava a pennello. Amal: speranza. Perché era lei la mia speranza.
La bambina si rannicchiò nella buca nascondendosi sotto la coperta grigia. Per la prima volta saremo state lontane alcune ore. E i rischi non erano pochi. Più di tutti mi preoccupava la possibilità di non ritrovare il suo nascondiglio: dovevo memorizzare bene i numeri dei passi, ma non avrei potuto prendere punti di riferimento precisi. Il sole non era affidabile. E poi c’era il vento. Il vento avrebbe potuto coprire l’entrata. Avrebbe, certo. Mi restava da sperare che non si alzasse. Disegnare una mappa sarebbe stato ancor più pericoloso: se ci fosse stato qualcuno, là, dentro o intorno al palazzo, e avesse avuto cattive intenzioni… Se mi avesse catturato e avesse trovato quel foglio… No, non potevo correre quel rischio. Per il bene della bambina.
Gli occhi di Amal erano spalancati e fissi su di me. Riuscivo a vederli, perché brillavano come la polvere. Come la cenere. Erano dello stesso colore, ormai. Di un grigio intenso.
Era entrato dentro di lei quel grigio. L’avrebbe uccisa? Non volevo pensarci.
«Non avere paura...», le dissi spingendole via una ciocca di capelli. Grigia. Anche la ciocca. E adesso, anche la mia mano.
Ero io ad avere paura. Amal riusciva a sentirlo.
«Canta, canta nella testa, Amal. Canta tutte le canzoni che ti ho insegnato. Se alla fine non sarò tornata, aspetta la notte e scappa».
Non volevo andarmene. Non avrei dovuto lasciarla lì. Lo sentivo.
«Mamma...».
«Sì?».
«Tornerai, vero?».
Avrei voluto dirle di sì, rassicurarla. Ma non potevo mentirle. Non più. Anche se era una bambina, anche se io ero una bambina. Ero stanca delle bugie, delle bugie che i grandi dicono ai bambini, o che i più piccoli si raccontano tra loro.
Le detti un bacio sulla testa e le scompigliai i capelli: adesso anche la mia bocca era appena coperta di grigio. Ormai la cenere era entrata ovunque. Difficilmente saremmo sopravvissute a lungo.
«Stai attenta, per favore, mamma».
Le strizzai un occhio e mi allontanai prima che facesse giorno. Non avrei potuto aspettare la sicurezza della notte, perché avevo bisogno di luce, di più luce. Di vedere. Di vedere, da lassù, se in quel deserto di cenere qualcun altro come noi era vivo e in cerca di aiuto. Qualcuno buono, non uno dei soldati. Vedere se c’era qualcosa, oltre la cenere: una città sopravvissuta, una città ricostruita.
Non c’era niente. Avrei dovuto immaginarlo. Solo polvere: immense distese di polvere grigia. Era tutto uguale. La terra era tutta morta. Almeno da lì. Qualche duna, qualche buca. Eravamo le uniche formiche del formicaio. Neanche i militari si facevano vedere. Non ce ne era traccia, neppure nel palazzo.
Non c’era traccia di vita, là dentro. Di carne, invece, ce ne era fin troppa.
L’appartamento in cui entrai era sulla via del ritorno, all’ultimo piano. Avevo trovato la porta accostata. Ero in cerca di cibo, di provviste.
Il primo corpo era nella sala, a terra, sul tappeto. Non c’erano tracce di sangue. Solo la posizione era innaturale. L’uomo era steso su un fianco. Le braccia sigillate sul petto e le gambe adagiate una sopra l’altra. Il suo viso era rivolto verso una porta bianca.
Il tempo, là dentro, sembrava aver smesso di correre. C’erano ancora le patatine su un tavolo basso, tra il divano e la televisione. Ne presi una: da quanto non ne mangiavo?
Sputai a terra il boccone: sapeva di cenere. Ormai la polvere aveva contaminato anche il cibo. Non mi avevano ucciso le bombe e, iniziai a temere, mi avrebbe fatto morire quella polvere. Se fosse stato così avrei prima dovuto mettere in salvo Amal.
Il resto delle patatine cadde di fianco all’uomo. Feci attenzione a non calpestare la carne e aprii la porta che conduceva in un’altra zona della casa.
Il corridoio interno era buio. Ero costretta a procedere a tastoni. Sulla destra trovai una maniglia fredda. La tirai giù e un po’ di sole filtrò da una persiana di legno leggermente aperta. La prima cosa che vidi fu un carillon: non girava, non suonava più. Poi vidi il cadavere sul letto. La ballerina era rimasta immobile, forse già da tempo, o forse nel momento esatto della prima esplosione. Il suo tulle era ancora bianco: era il primo oggetto ad aver conservato il suo candore su cui si fossero posati i miei occhi negli ultimi mesi.
La avvicinai al raggio di luce e sfiorai il suo vestito.
Tornai la bambina che ero, per un momento.
Quanto tempo era trascorso? Quanto ero rimasta nella cameretta a osservare il carillon e la bambina che ne era stata proprietaria? Aida, a giudicare dal nome scritto sulla parete sopra il letto. Colei che torna. Ma non sarebbe tornata. Non sarebbe tornato nessuno. Erano tutti morti. Soltanto morti.
Afferrai il carillon e lo misi nello zaino. Aida mi avrebbe perdonato, pensai. In fondo non era per me. Era un regalo. Spalancati verso il soffitto c’erano i suoi occhi. Incapaci di piangere. Incapaci di vedere. Occhi ciechi. Sarebbero rimasti così per sempre? Quel pensiero era insopportabile.
Di tanto in tanto sogno ancora quei grandi occhi. Spalancati. Sul niente. Sul buio. Un buio eterno. Allora, mi dico, immagino di dirle, continua a dormire, Aida.
Lo zaino adesso era pieno: provviste, qualche abito, il solito binocolo. Il regalo per Amal. Sarebbe stata felice. Avrei fatto di tutto per vederla sorridere. Per vederla sognare, ancora, come facevamo entrambe prima della grande pioggia di cenere.
Il vento aveva concesso una tregua. Si alzava soprattutto di notte. O quando stava per cambiare il tempo. Mentre mi avvicinavo alla buca sentivo che qualcosa non andava. La notte stava arrivando e non c’erano nemici intorno. Era un posto sicuro. Perché quel terrore?
«Amal?».
La chiamai sottovoce, quasi per non svegliarla.
«Amal? AMAL?!».
Girai intorno all’ingresso della buca e realizzai che era vuota.
Amal non c’era più.
La coperta grigia era rimasta a terra, tra la polvere e i disegni. Sì, Amal aveva raccolto uno stecco e disegnato. Aveva reso l’attesa meno pesante, ma non era bastato.
Solo allora notai delle impronte. Impronte di passi, passi di bambina e di qualcuno più grande, impossibile dire di quanto. Non sembravano lontani gli uni dagli altri: procedevano a distanza costante sulla cenere, almeno fino a dove riuscivo a vedere.
E mi misi a seguire le tracce, mentre il vento si alzava e quella notte, sì, faceva freddo. Minacciava di cadere altra polvere e dovevo fare in fretta, prima che le orme fossero cancellate. E con esse, la speranza di ritrovare Amal.
Cercai di capire, guardai dappertutto. Dopo un’ora di cammino le due file di impronte erano diventate una sola. I piedi erano quelli più grandi. Nessuna traccia di quelli di Amal.
Osservai meglio, con più attenzione: sembravano trascinarsi. Inciampare. Le impronte erano più profonde. Il solco, nella cenere, più marcato.
Non c’era traccia di sangue. Nessuna macchia rossa intorno a quelle orme.
Cosa era successo ad Amal? L’avevano presa in braccio?
Amal stava morendo.
Stavamo morendo. Perché la cenere continuava a entrare dalla pelle e dalle narici. La sentivo. Percorreva tutto il corpo scorrendo nelle vene. La polvere stava rendendo tutto grigio. Sì, era il grigio il colore della morte.
Ma Amal stava morendo un po’ di più. Non riusciva a camminare per troppo tempo. Faceva fatica anche a respirare. E allora doveva aprire la bocca, e respirare con quella. Incamerare più aria. La stessa aria avvelenata.
Mi lasciai cadere sulle ginocchia, alzando cenere. Il vento cominciava a mulinare. E sembrava chiamare il mio nome. Il nome che neppure ricordavo, perché da tempo nessuno lo pronunciava. Ma chiamava me, ne ero certa.
E allora, con le ultime forze, seguii il vento. Non sapevo se mi avrebbe condotto alla morte, ma se non fossi più riuscita a trovare Amal tutta la mia vita avrebbe perso importanza.
C’era della musica. Non era una voce. Erano note. E io stavo seguendo quel suono, quasi ipnotizzata. Sapevo che mi avrebbe portato da lei. Era una delle canzoni che le avevo insegnato da quando ero diventata sua madre, quella che cantavamo sempre, quando una delle due era stanca o triste. Ci faceva sentire meno sole, più unite.
Il vento l’aveva portata, leggera come un soffio, a chilometri di distanza. È incredibile quanto viaggi il suono, nella notte, nel buio, nel deserto grigio di cenere.
Raggiunsi la capanna, messa su con le macerie di mattoni e di ferro, alla periferia della città fantasma. Tutte le città, ormai, erano così. Tutte le città. E tutti noi. Spettri. Scheletri. Senza vita.
La musica, dentro, era davvero forte. Me ne accorsi prima di aprire la porta. Nella capanna c’era odore di chiuso. E di cenere. L’odore della cenere era ovunque.
Il giorno era vicino e nella stanza iniziava a filtrare la luce dell’alba.
Su un tavolo, di fronte a me, c’era una lenzuolo bianco. Gonfio.
Sotto c’era qualcuno, qualcuno di piccolo.
Ne alzai un margine e guardai sotto. La vidi.
Amal, con la sua bocca a cuore colorata di grigio. E la pelle, dura, fredda, anch’essa d’argento. E i capelli, i vestiti, tutto era così. Sotto una nuvola bianca, c’era il corpo, il cadavere grigio di Amal.
Prima di piangere portai lo zaino in avanti ed estrassi il carillon, quello che non avrei più potuto donarle. Lo lasciai lì, un’altra macchia candida vicino alla coperta. Lo lasciai aperto, illudendomi che potesse vederlo, ovunque fosse.
Dietro di me sentii dei passi.
E quando mi voltai, vidi uno come me. Un ragazzo, intendo. Appena poco più di un bambino. Aveva una sciarpa a coprirgli il naso e la bocca. I suoi capelli erano grigi.
«La conoscevi?», mi chiese.
«Chi sei?».
«Adham».
«Cosa le hai fatto?».
Senza accorgermene mi ritrovai a pochi passi da lui. Stavo urlando, piangendo. Sentivo che le vene della mia testa erano sul punto di esplodere.
Sì, un’esplosione di sangue e cenere.
«Mi dispiace. Non sono riuscito a salvarla...».
«Non ti credo».
«L’ho trovata nella buca, sola. Era quasi svenuta».
Era il senso di colpa quello che sentivo? Quella fitta che mi trapassava in due il centro del petto, leggermente a sinistra?
«Ha camminato per un po’, poi non ce l’ha più fatta. L’ho portata in braccio fino a qui».
Non volevo più ascoltarlo.
«Non ti credo».
«Quando si è svegliata mi ha chiesto se fossi il suo nuovo papà».
E dubitai, per un istante. Pensai che potesse essere sincero.
No, non poteva.
L’aveva fatta morire. E avrebbe ucciso anche me.
«Non ti credo».
Infilai la mano destra in tasca e impugnai il coltellino.
«Mi dispiace per quello che è successo...».
Ma i suoi occhi non piangevano. Erano freddi, di pietra. Grigi. Come la cenere.
«Ti prego, non farlo...».
Ma io avevo già deciso.
Lo colpii. Lo colpii finché non smise di muoversi. Di respirare.
Sono caduta nella cenere.
Ho tirato fuori il coltello.
Poi l’ho riposto.
Non sono riuscita a fare quello che dovevo.
La notte non è fredda. Stanotte non c’è neppure il vento.
Penso che ad Amal sarebbe piaciuta.
E allora mi alzo e continuo a camminare.
In questo deserto di polvere grigia.

"La vita segreta delle parole", tratto dal bellissimo film di Isabel Coixet
Come sempre potete ispirarvi all'opera originale e prendere qualsiasi direzione troviate inerente.
Le regole, sempre le stesse:
I racconti (inediti) devono essere inviati a: contest@jonaeditore.it
Scadenza 31 gennaio 2018.
I due o più vincitori (se i racconti inviati saranno meno di cinquanta decreteremo solo un vincitore) avranno pubblicazione in www.jonaeditore.it
Link a Prospettive, l'ebook della prima antologia.
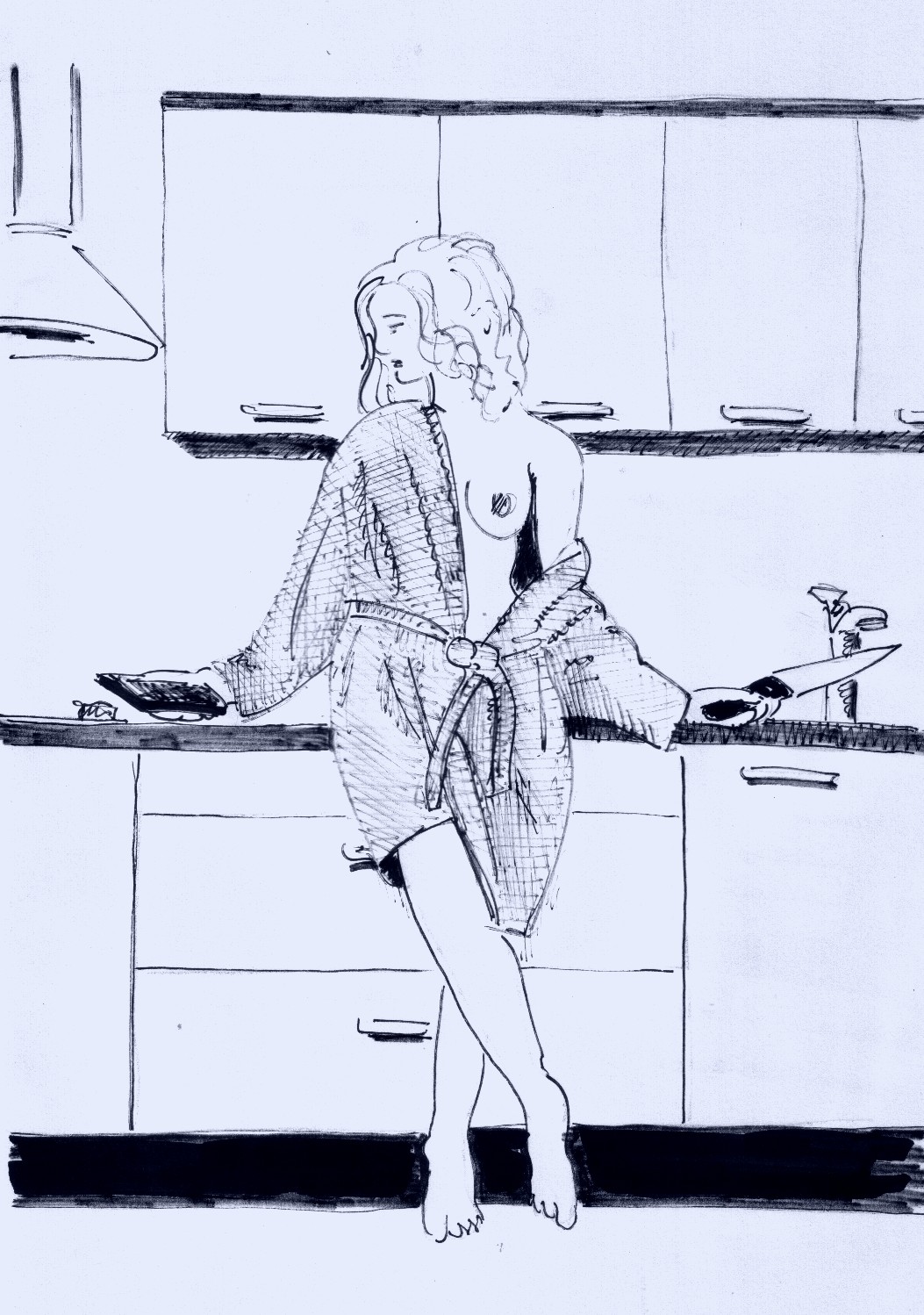
Margherita Solani e Andrea (Antropologo) Gori, per la prima volta, dopo due mesi di frequentazione virtuale, si incontrano.
Queste il loro resoconto (prima di lei, poi di lui)
Mi hai sciolto il fiocco con il quale tenevo legati i capelli in una coda bassa. Non mi sono girata subito, ho preferito aspettare qualche istante. Il tuo anticipo e la descrizione che ti avevo fornito ti avevano lasciato l'opportunità di sapere, prima di me, chi sarebbe stata la persona che avresti incontrato. Non avrei mai immaginato che la prima cosa che avresti fatto, ancora prima di darmi il modo di guardarti per bene, sarebbe stata baciarmi. Ogni promessa è debito, è così che siamo rimasti per quasi mezz'ora davanti a Santa Maria del Fiore, incollati, in mezzo ai passanti e immersi in quella densa nebbiolina che rendeva Firenze ovattata. Adoro le città con il fiume, l'ho scelta per questo, oltre che per la comodità reciproca. Dalla tasca ho tirato fuori le chiavi e ti ho condotto fino al monolocale in prestito. Una volta saliti ti ho detto di metterti comodo e ti ho chiesto di aspettarmi sul divano. In bagno mi sono cambiata e ho indossato la vestaglia blu che mi hai regalato. Solo quella. La sensazione della pelle a contatto con la seta è stata ancora più piacevole pensando che di là, c'eri tu ad aspettarmi. Mi sono seduta di fianco a te e abbiamo iniziato a parlare, dimenticandoci per qualche istante della cena. Mi hai sorpreso una seconda volta, ordinando tu, in un posto che conoscevi. Del resto, sui piatti tipici non potevo competere in alcun modo. Quando è arrivato il fattorino, ci ha sorpreso di nuovo incollati e vista la mia tenuta, poco idonea a tuo avviso a riceverlo, ti sei alzato per ritirare e pagare. Ho accettato di buon grado le tue premure e ti ho atteso lì dove mi avevi lasciata. Non abbiamo fatto nemmeno la fatica di spostarci, abbiamo mangiato utilizzando il tavolino che avevamo di fronte e interrompendo di nuovo il contatto fisico. Hai mantenuto anche tu le tue promesse. Hai assaggiato un sorso del brandy che mi sono gustata dopo, mentre pianificavamo i nostri prossimi esperimenti. Il tempo è volato, e man mano che prendevamo confidenza l'atmosfera si è fatta sempre più rilassata fino a che le luci non sono state più un problema. Tu te lo ricordi se erano accese o spente? Al massimo o soffuse? Io no, però mi ricordo di tutto il resto. Dalla prima volta che hai fatto scivolare le dita sotto il tessuto, a contatto con la mia pancia, fino a quando hai slacciato il nodo della cinta, come avevi fatto qualche ora prima davanti alla chiesa. Non ero mai stata la prima volta di nessuno fino a ieri sera, e questo in qualche modo rende te anche la mia, di prime volte. Era da tempo che non mi sentivo così impaziente ed eccitata. Tanto da farmi addormentare al tuo fianco e da farmi risvegliare nello stesso modo. Una volta non ti sarebbe bastata, questo io lo sapevo. Non sarebbe bastata nemmeno a me, anche se per me è tutto più facile per certi versi. Perdonami per averti negato la doccia insieme. Troppo intimo, per adesso. Ogni cosa a suo tempo. Camminare per Firenze questa mattina aveva un altro sapore. Grazie per la colazione Antropologo, e per avermi accompagnato al treno. Un ultimo bacio e sono salita.
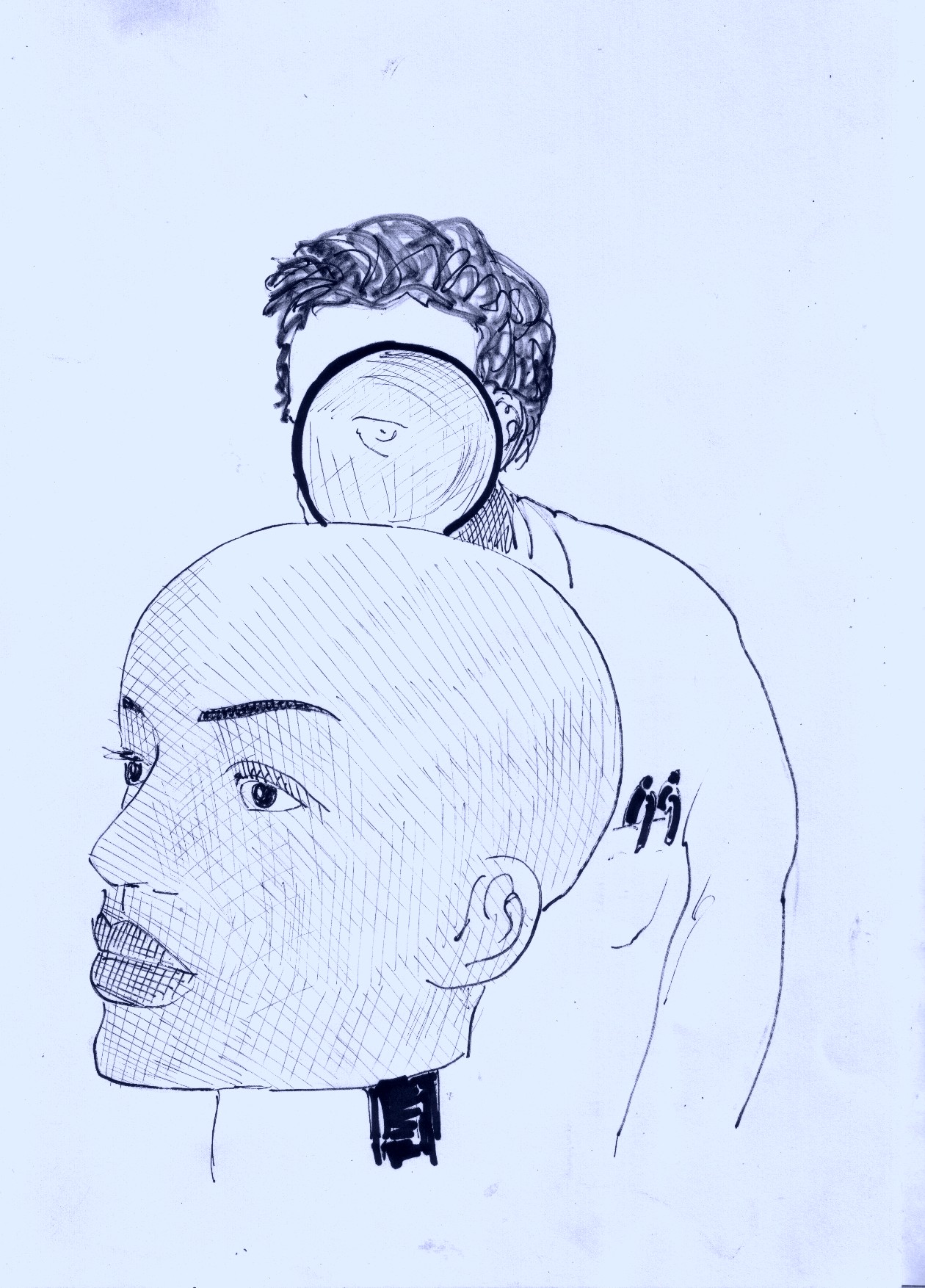
Ti ho cercata in ogni sguardo, in ogni cappotto rosso che passava vicino a me. Nessuna sarebbe stata bella quanto te. Lo sapevo. Tutte erano niente, in confronto a te. Un fantasma, un simulacro. Nessuna poteva essere come te.
Mi sono preso tempo per osservarti, per osservare il tuo muoverti leggero, ma al contempo meno sicuro di quanto credessi. Eri emozionata? Questo mi sono detto, quando tremando ho sciolto il fiocco, stando attento a non fare male ai tuoi capelli.
Ti sei voltata. Eri bellissima. Se ti avessi detto qualcosa, sarei risultato stupido, perché mi sentivo un ragazzino, in quel momento. I miei occhi non riuscivano a staccarsi dalle tue labbra, e allora le ho baciate, ti ho baciato. Sarei rimasto così tutta la notte, perché già era tanto, eri il mio tutto in quel momento. E anche Firenze era svanita, svanita oltre quel bacio.
Ti ho porto una fresia bianca e hai sorriso. Ho intravisto del colore sulle tue guance. Forse sei arrossita. E mi hai abbracciato e abbiamo ripreso a baciarci, baciarci a lungo, come se il mondo stesse per finire e non avessimo scampo, se non nelle braccia l’uno dell’altro. Ho rilegato i tuoi capelli, appuntando il fiore nel nodo del fiocco. E mi sei sembrata più bella di una dea, eppure umana, vicina, concreta.
La campana ha rintoccato. Ho scorto un brivido lungo il tuo corpo. Ho avuto paura che tu avessi freddo. Ti avrei dato il mio cappotto, ma eri così bella nel tuo cappotto rosso. Allora abbiamo iniziato a camminare per un tempo indefinito, perché parlavamo e guardavamo Firenze come non l’avevamo mai vista. E poi ci stringevamo lungo i marciapiedi e ridevamo, ridevamo come bambini, perché Firenze, in quel momento era solo nostra.
È incredibile come non basti il tempo. Avrei voluto baciarti tutta la notte. Avrei voluto parlare con te tutta la notte. E poi fare l’amore fino all’alba. Tutto, senza sacrificare niente, perché tutto con te è naturale e speciale.
Ti ho osservato con la vestaglia blu. Avevo scelto bene: la seta si posava leggera sulla tua pelle e il blu risaltava il tuo candore, la tua pelle così chiara e delicata.
Avrei voluto dirti che eri bellissima, ma la voce non è uscita, fino a che tu non hai iniziato a parlare e io, finalmente, ho riacquistato il mio coraggio.
Hai gradito la cena e io il bicchiere che mi hai offerto. Ho sperato che mi aiutasse a essere meno impacciato, a non fare figurette. Avrei voluto ridere, ridere forte, per rompere quella sacralità che circondava la nostra stanza. Invece ti ho guardata, ho guardato il tuo viso, il tuo corpo. E mi sono lasciato andare.
Sono stato tuo. Sei stata mia. E dentro di me sentivo che era speciale come lo era per te. La mia prima, in qualche modo il tuo primo. Sentivo che se nessuno dei due finirà per scappare, qualcosa di incredibilmente nuovo stava nascendo, come una luce, al mattino, nel momento prima dell’alba.
Ti ho guardata dormire. Ho osservato i tuoi lineamenti distendersi. Eri così dolce, innocente. Così diversa dalla Margherita che gli altri conoscono e che tu, invece, avevi concesso di vedere proprio a me.
Avrei voluto non crollare. Resistere, continuare a osservarti. Ma la tensione si è scaricata e sono crollato vicino a te, quasi abbracciandoti. Avevo paura di toccarti. Di sfiorarti.
E adesso che sei salita su quel treno, che sei di nuovo lontana da me, devo trattenermi per non prendere il treno e venire a cercarti, ovunque tu sia, in tutta la tua città.
Ci siamo salutati con un abbraccio stretto, un bacio che non saprei descrivere. Forse disperato, sì. Perché avrei voluto dirti di restare, restare ancora, non andartene subito.
Resta ancora un poco, Margherita. Prendi il treno successivo o non prenderlo affatto. Torniamo nel monolocale, a parlare, a baciarci, a esplorarci. A studiare quel fuoco che si espande dentro noi, così naturale, così nuovo, così nostro.

Oggi nasce una nuova sezione del sito: Il gioco.
Un paio di mesi fa scrivemmo di questo progetto.
In realtà, oltre a essersi sviluppato, si sta espandendo.
Nato come esperimento di scrittura schizofrenica, sta volgendo a termine la prima fase.
I dieci autori superstiti alle eliminazioni si affronteranno nelle prossime settimane e il 15 gennaio avremo il vincitore assoluto.
Molti di essi parteciperanno in pieno al primo romanzo di scrittura schizofrenica legata a “Il gioco”.
Nasceranno degli spin off. Alcuni personaggi avranno vita propria (magari insieme ad altri dello stesso gruppo) e continueranno a darci la loro prospettiva e a farci vivere le loro storie.
Molte altre iniziative ci saranno, a partire dal 15 gennaio.
Per adesso, nella nuova sezione pubblichiamo alcuni dei loro scritti.
Abbiamo incontrato Giovanna Preve, autrice di Tra il rumore e il silenzio.

Giovanna, puoi parlarci di te oltre alla poesia e alla pittura? Cosa fai nella vita?
La mia vita è divisa tra l’arte e la famiglia, tra Torino, dove lavoro ed Azeglio, in provincia di Torino, dove vivo insieme a mio marito e mia figlia di 5 anni, Maria Sole, in una bellissima casa a pochi metri dai campi e dai boschi di pioppi. Oltre all’arte ci sono i miei affetti e niente di più. Infatti sono sempre in viaggio se non lavoro e non sto con loro. Oltre alla poesia e alla pittura faccio parte di un gruppo di ricerca sulla cultura visiva attraverso la fotografia analogica che si chiama Specchio Patibolare. Ho dedicato molto tempo anche a questo progetto. Comunque no, non ho altri interessi nella vita: l’arte è il mio lavoro e il mio hobby insieme. Mi piacerebbe viaggiare di più, questo sì e non solo come pendolare.
Quando hai iniziato a scrivere?
Sassi accesi, è la mia prima, l’ho scritta nell’estate del 2007. Mai, prima di quel momento, avevo pensato di scrivere una poesia. Invece è stata una forza trascendentale più forte di tutto. Della grandissima fragilità di quel momento, della tristezza e della mia ignoranza. Avevo bisogno di descrivere un’esperienza che avevo vissuto ed esprimere i sentimenti che non riuscivo a voce a comunicare. A differenza delle altre poesie che ho scritto per lo più “di getto” questa l’ho costruita con metodo, ripensandone la struttura, riscrivendola più volte su uno dei miei quaderni da cui non mi separo mai. Nonostante la confusione in cui ero, sono riuscita a costruirla.
Sempre poesia o anche narrativa?
Dopo la prima poesia sono passati anni prima che ne scrivessi altre. Ma nel 2009 ho lasciato il dottorato in architettura e ho lavorato come cameriera per scrivere la mia autobiografia dal titolo Giovanna è stata la migliore, tratto dalla canzone Niente da capire di Francesco De Gregori.
De Gregori per me è una fonte importante: da sempre amo le sue canzoni, mi sono entrate dentro al punto che penso mi abbiano modificato geneticamente. Il racconto è incentrato sulla mia vita, che è stata molto difficile e sul mio amore per De Gregori che ha complicato il tutto. Non me lo hanno mai pubblicato però, né De Gregori l’ho mai conosciuto nonostante io abbia realizzato altri progetti che lo riguardano.
Oltre alle poesie, dipingi. Ci spieghi la differenza? Alcune sensazioni ti spingono a scrivere, altre a dipingere?
Dicono che la mia pittura sia espressionista. I miei lavori ricordano Kokoschka, Schiele, Kirchner. Quando dipingo, come quando scrivo, programmo poco, sono molto emotiva e trasferisco sul quadro le sensazioni che emorgono sul momento in una sorta di catarsi. Come quando compongo una poesia, quando dipingo, entro in uno stato di trance in cui lascio che il pensiero inconscio si manifesti. Impulso a cui cerco di dare una forma o con il colori o nel caso delle poesie con le parole che conosco che “arrivano” senza che io le riesca a controllare. Ho bisogno di scrivere una poesia, difficilmente lo decido a tavolino: in dieci anni ho scritto quasi lo stesso numero di poesie che in un mese particolarmente “felice”.
Per la pittura è leggermente diverso perché ormai lo faccio con metodo. Infatti, per quanto l’espressività sia il carattere dominante del mio lavoro, cerco di applicarmi con assiduità per migliorare la tecnica. Mi sono iscritta all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nel 2014 proprio per acquisire degli strumenti attraverso cui plasmare l’impulso creativo e non escludo che in futuro non decida di iscrivermi alla Facoltà di Lettere.
Mi spinge a scrivere lo stesso bisogno che mi porta a dipingere e cioè vedere “fuori” quello che c’è dentro e non si conosce.
Com'è "il tempo della poesia" e come "il tempo dei dipinti"? Dovessi spiegarci com'è quel tempo, come lo vivi, se sei isolata e felice o al centro di tutto, oppure, ancora, connessa solo a te stessa: di cosa è fatto il tempo della poesia e come quello della pittura?
“Il tempo della poesie” è un temporale che mi coglie sempre di sorpresa e che amo vivere in totale solitudine. Dipingere ultimamente è diventato un momento di socializzazione. Infatti in Cavallerizza Reale, in via Verdi a Torino, dove ho un laboratorio di pittura, faccio ritratti a coloro che frequentano questa realtà fortemente intrisa di energie a cui è impossibile sottrarsi. In Cavallerizza Irreale non posso isolarmi come sarei portata a fare di natura. Mi faccio contaminare dall’esperienza degli altri artisti ma anche cittadini che quando vengono da me a farsi ritrarre entrano nel dipinto attraverso un processo di conoscenza che anche se si consuma in un’oretta circa di posa, raggiunge, almeno da parte mia, momenti di grande intensità. E allora uno sguardo diventa importante, un dettaglio che mi parla dell’altro e che salvo all’interno del ritratto.
Tanto per la poesia che per i dipinti vivo il momento della creazione con immensa gratitudine nei confronti dell’arte, che quando arriva mi rende quello che la vita mi ha tolto ogni volta che ho sofferto, che quando c’è mi regala una felicità incommensurabile, non paragonabile agli sforzi e ai sacrifici che ho dovuto fare per arrivare almeno ad intravederla.
Una poesia che ami più delle altre nel tuo nuovo libro e perché.
Non c’è una poesia in particolare, ognuna ha un ricordo importante a cui sono legata.
La prima parte del libro è composta principalmente da poesie “d’amore” che ho dedicato a Francesco De Gregori. Le ho scritte in circa un mese, a novembre di quest’anno. Ero molto ispirata e le ho scritte come se davvero io avessi una relazione con questo artista nonostante io neanche gli abbia mai rivolto la parola. Trovo che questo sia una cosa molto particolare e mi affascina la potenza che la musica esercita su di me. Ho scritto anche una poesia mentre ascoltavo Chopin. Questa racconta benissimo il mio amore per la musica. Chopin, come De Gregori li canto come fossero presenti e vicini. È il potere della musica che prende in ostaggio la mia razionalità e mi trascina in una realtà parallela dove tutto diventa possibile. È una questione neuronale, quasi patologica.
Dipinti: hai in mente mostre? Hai molti lavori?
Ho molti lavori, sì. Lavoro tanto. Non ho in programma mostre imminenti ma mi spendo costantemente per trovare nuove possibilità di esporre. Quest’estate ho preparato 10 grandi tele che illustrano altrettante canzoni sempre di De Gregori. Mi piacerebbe fare una mostra con questi lavori perchè sarebbe un risultato importante dopo più un decennio di ricerca che comunque dubito si sia esaurita ancora.
Poesie: prevedi altri libri?
Come ho già detto, le poesie arrivano come la pioggia. Non posso programmarle. Sono fiduciosa di provare ancora l’ebrezza di comporre ma non ne sono sicura.
Anche se mi spaventa solo l’idea, sono certa che Giovanna è stata la migliore non potrà restare per sempre in un cassetto. Quindi chissà, forse lo riprenderò in mano.
La pubblicazione di Tra il rumore e il silenzio è già un regalo immenso che Jona Editore mi ha fatto e che non osavo neanche sperare. Mostre, altre pubblicazioni, etc. sarebbero importanti ma già così mi sento molto fortunata. Sento che gli sforzi che faccio quotidianamente siano ripagati dalla gioia infinita che mi dà vivere per l’arte.
Devi fare ciò che ti fa stare bene
La vita dentro una canzone
Ormai era diventato il mantra di un eco lontano. “Eppure era così vicino”. Una frase che portava sempre nel cuore e che teneva bene a mente. “Un ordine impartito”. Solo nel corso degli anni aveva compreso, dal timbro caldo e dall’ampiezza del tono della voce di sua madre, che si trattava di un ordine gradito, l’opposto dell’arido imperativo che gli imponeva ogni giorno suo padre. “Studia! Non sognare!” Sì: sognare, ascoltare una favola raccontata da suo padre e cantare una canzone erano nella lunga lista delle cose non contemplate nella sua educazione. Ordinato, diligente, preparato, elegante, in sintesi un concentrato di tutto ciò che prevedevano l’istruzione e il comportamento nell’alta società. “Devi fare ciò che ti fa stare bene”. Ogni volta chiedeva a sua madre: «“cosa” devo fare», senza dare un tono interrogativo alla frase perché in quella casa non si potevano porre domande. Tra quelle mura non potevano essere esposte questioni o idee: bisognava solo eseguire gli ordini, intonati con severità, oppure scritti, come se fossero legge. Lei rispondeva in maniera evasiva, ma lui aveva imparato a comprendere che, all’insaputa di suo padre, al contrario di quelle che erano le sue volontà, nello studio e nella vita avrebbe sempre potuto contare su di lei.
Come se fosse un rito, sfilò con calma il foglio consumato, ma pur sempre intatto, dal taschino posto sotto i documenti del portafoglio, quella che una volta era una semplice tasca dei pantaloni, corti e blu, che indossava assieme alla camicia bianca, per andare a scuola. “Tutte le mattine”. Anche a causa di quell’abbigliamento sempre uguale era stato denigrato e isolato da una parte dei suoi compagni di scuola: “non meritava l’amicizia di nessuno”, così diceva quella banda di bulletti, e lo mettevano nelle condizioni di provare vergogna per se stesso, una vergogna che aveva preso la forma dei pensieri di suo padre e dell’unica cosa che riusciva a provare suo padre in quella casa. “Indifferenza”.
Ricordava ancora l’ansia che aveva provato nel cercare un posto nascosto in cui leggere per la prima volta quel biglietto. Il tremore si era impossessato delle gracili gambe, le mani sudavano. E ricordava anche l’emozione di leggerlo all’oscuro di tutto. “E di tutti”. Era stato scritto su di un semplice foglio, che sua madre aveva estratto con cura da uno dei suoi quaderni, senza che suo padre se ne accorgesse, perché i quaderni dovevano essere integri e perfetti! Si chiese se anche lei scrivendolo avesse provato lo stesso tremore e la stessa contentezza.
Lo custodiva con molta attenzione. Quella frase l’aveva letta almeno un milione di volte e l’aveva trascritta ovunque potesse essere posta di fronte ai suoi occhi, nella sua vita quotidiana, così da fare riaffiorare quelle parole. Continuamente. Nel suo cuore. L’aveva scritta su ogni diario. Compariva su tutte le agende che lo avevano accompagnato in quegli anni, di studio e di lavoro. Con lettere nitide. Precise. Ordinate. Con una grafia ricercata. L’aveva salvata sullo screen saver del computer. L’aveva memorizzata come sfondo nel cellulare. E l’aveva racchiusa in una cornice grigia di grandi dimensioni, che teneva appesa alla parete della sua stanza, disposta perfettamente al centro, davanti al suo letto. In fine l’aveva affissa sullo specchio, di fronte al quale dedicava fin troppo tempo rispetto a quello necessario a radere quel po’ di barba che osava togliere dal viso. Un viso sempre adornato dal pizzetto nero, così come nera e crespa era la montagna di capelli che si portava appresso, da sempre, e per la quale suo padre non aveva mai trovato il tempo di portarlo dal barbiere. “Non gli dedicava mai il proprio tempo”. Un tempo che non era contemplato nella dimensione della famiglia, tanto suo padre era preso dal lavoro. Così non c’era tempo per rispondere alle sue domande, per giocare con lui, per aiutarlo a studiare. “Il tempo è denaro”, diceva, e non ne sprecava neanche per interagire con sua madre - terza protagonista di quell’atto - i cui unici compiti erano quelli di accudire la casa e il giardino, enorme, che si era voluto concedere lui. “Isolandola da tutto e da tutti”. Nell’accudire la casa rientravano anche lavare i vestiti e preparare i suoi piatti preferiti, mai alla stessa ora. Gli orari li comunicava lui di giorno in giorno perché la sua vita da imprenditore non gli concedeva di fare diversamente, diceva. Sua madre gli aveva confidato, solo molti anni più tardi, che considerava quella casa un lager.
Crescere lui non era semplicemente in fondo alle priorità di suo padre, in quella lista non c’era proprio; ciò nonostante doveva essere il primo nello studio e nello sport e per questo lo aveva iscritto ad atletica, senza ammettere repliche. Ma non si era mai degnato di presentarsi a nessuna delle sue gare, anche se il suo corpo sembrava una macchina nata per vincere. Al traguardo gli unici applausi che sentiva erano quelli di sua madre e degli spettatori. “Tutto serve”. L’unica arida risposta che dava suo padre, una volta venuto a conoscenza della vittoria era: “Hai fatto solo il tuo dovere”.
Per fortuna aveva quel foglio che gli ricordava, ogni volta che voleva, la presenza sicura di sua madre. Aveva passato i suoi anni a nasconderlo nel cuscino, sotto al materasso o dietro a un quadretto, appeso nella propria stanza, che conteneva una foto di suo padre e che lui non amava guardare. “Lì era al sicuro”. Lui non lo doveva trovare, non lo doveva vedere, non lo poteva leggere.
Il fruscio di quel foglio era musica per le sue orecchie. Lo avvicinò alle narici e inspirò, prima di rileggere quelle parole che gli placavano l’anima. Avrebbe voluto ritrovarvi anche il profumo di sua madre, ma suo padre le aveva sempre vietato di comprare fragranze e trucchi, inopportuni per una donna che doveva solo curarsi della casa e delle cose. Fece vibrare le corde vocali per scaldarle, ripetendo quella frase che amava tanto. “Siamo rimasti in venti calmi.” Poi socchiuse le labbra e iniziò a leggere:
Devi fare ciò che ti fa stare bene
anche quando ti dicono che non conviene
perché nel tuo cuore c’è soltanto il bene.
Devi camminare verso la via d’uscita
anche se fosse in salita
dovesse volerci tutta la vita.
Scegli la porta che vuoi varcare
ma non avere mai paura di volare
nel tuo cuore è già scritto dove devi arrivare.
Circondati di persone fidate
sono le uniche che possono essere amate
le uniche compagnie a poter essere considerate.
Stendi le ali e vola come un airone
il vento conosce già la direzione
e ti porterà dritto al tuo futuro senza esitazione.
Verrà il giorno in cui avverrà il cambiamento
lo vedrai dal luogo in cui ti avrà portato quel vento
e a quel punto capirai che è giunto il momento
sarà giunta l’ora di lasciarti andare
il tuo futuro non potrà più aspettare
prendi coraggio e fai ciò che devi fare.
Era una metrica imprecisa, piena di imperfezioni anche grammaticali, ma conteneva tutto quello che avrebbe voluto sentirsi dire.
Premette il foglio con il palmo aperto della mano verso il naso, con le sue dita grandi, quasi accartocciandolo, poi inspirò fino a dilatare i polmoni, portandoli al limiti, e rimase così per pochi secondi. Richiamò alla memoria il profumo della torta di mele appena sfornata, che tanto adorava aspettare seduto in cucina su quello sgabello così alto da non permettere ai suoi piedi di toccare per terra, rimasta impressa nei suoi pensieri, poi lo ripiegò con cura. Prese il portafoglio e lo infilò al suo posto, poi mise via anche quello. Fece incontrare le mani davanti a sé e allargò le dita posandovi le labbra. Ora capiva: quel giorno era arrivato. Indossò la tenuta da corsa e si diresse verso il campo sportivo dove si ritrovavano i lavoratori dell’azienda. Si dispose sulla riga di partenza. Poi contrasse i muscoli e fece leva sui legamenti, il corpo iniziò subito a rispondere alla loro contrazione, accanto a lui altri atleti correvano, ma era sempre stato quello più veloce, quello più forte, il più difficile da battere. Il primo della classe, il primo sul lavoro. “L’ultimo ad essere scelto dalle ragazze”. Fece un ultimo sforzo, poi un altro, mentre la sua mente giungeva al culmine del significato di quella strofa, miscelandosi alla frase sillabata che le ripeteva sempre sua madre quando tornava a casa frustrato per essere stato deriso, ancora una volta, a causa della sua perfezione, della sua impostazione, della sua compostezza. “Vuoi stare bene. Stare bene e ce la farai”. Quella frase sillabata prese ritmo con il suo cuore mentre il sangue gli pulsava nelle orecchie. Era solo davanti a tutti, solo come sempre e come sempre il primo. Fu allora che diede ordine ai suoi muscoli di rallentare mentre un’altra frase prendeva il sopravvento. “Voglio essere superato”. La contrazione sui muscoli si ridusse, gli arti continuarono a rallentare e mentre acquisiva la percezione del suo corpo, il sangue nelle sue orecchie rallentò anch’esso, pulsando con minore intensità. Fu allora che si accorse di essere stato superato e pensò che questo lo facesse “stare bene”. O almeno così gli sembrava. Chiuse gli occhi concentrandosi sui suoi organi di senso. Si accorse solo allora che le sue orecchie avevano un potere enorme. Un potere di cui non era consapevole, teso sempre verso l’obiettivo da raggiungere, l’ordine da rispettare, l’ostacolo da superare. Iniziò a percepire il vociare delle persone che si trovavano attorno a lui, il rumore del piede battuto sopra la gomma rossa che ricopriva la pista, il ringhio di chi stava forzando il proprio corpo per raggiungere più in fretta la meta. Tutti questi suoni e altrettanti rumori colpirono il suo udito, provocando lo stesso dolore di un muscolo indolenzito dalla colpa di non essere mai stato usato. Fu allora che si dedicò all’olfatto e si accorse che gli alberi di magnolie, che circondavano la pista, sovrastavano con il loro profumo il tanfo di sudore, oltre all’odore della terra e della gomma della pista. Le sue gambe rallentarono ancora, finché si accorse di essere stato superato e questo non lo faceva stare bene. Il pensiero andò a sua madre, dopo la morte di suo padre aveva iniziato a vivere: la camminata decisa e cadenzata, resa fluida dall’abito elegante e dalle scarpe all’ultima moda che finalmente si era potuta comprare, il viso truccato in modo leggero ma evidente, come qualche volta le vedeva fare di nascosto, davanti allo specchio, per ammirarsi solo pochi secondi subito prima di cancellare ogni prova. Ora erano gli altri che la ammiravano. “Lei aveva trovato ciò che la faceva stare bene”.
Lasciò il campo da atletica e mentre si dirigeva verso casa sfilò il cellulare dalla tasca e lo aprì sulla rubrica. La maggior parte dei numeri corrispondeva a colleghi di lavoro, persone prive di intelletto e di capacità, ma in grado di ferire con una sola parola detta dietro alle spalle, come un colpo di spada inferto per distruggere l’immagine dello sfortunato soggetto su cui avevano diretto la loro attenzione. Nella totalità delle volte si trattava di lui. Lui che era il responsabile di tutti loro, il direttore di tutti quei pigri succhia stipendi che infestavano l’azienda ricevuta in eredità da suo padre, un’eredità che gli pesava addosso come un macigno. Non avrebbe mai potuto rallentare sul lavoro come aveva fatto sulla pista di atletica, nessun neurone del suo cervello gli avrebbe mai e poi mai permesso di lasciare colare a picco l’azienda e lui con essa, ma qualcosa poteva fare. “Voleva fare”. Una bella ripulita allo staff e ai suoi capelli. Non avrebbe più permesso a nessuno di trattarlo come uno spauracchio, un ridicolo idiota di cui farsi beffa. Era capace. “Pensare a questo lo faceva stare bene”. Lo dimostrava il fatto che a venticinque anni aveva preso in mano le redini di quell’azienda e l’aveva fatta risorgere dalle macerie in cui era finita con suo padre, che, al contrario di lui, si era arreso alla propria incapacità e si era punito con un’arma. Anche lui si era armato, ma di buona volontà e con coraggio aveva messo a frutto la propria formazione e l’aveva trasformata in successo in omaggio a sua madre, che lo aveva sempre fatto stare bene. Così le aveva donato la dignità e l’indipendenza che non aveva mai ricevuto dal marito.
Nel proprio intervento di ristrutturazione aveva mantenuto tutto il personale dell’azienda, ma ora si era accorto che la metà di questo non lavorava e si assentava in orario di lavoro, a scapito dei colleghi che davano il doppio. Tutto questo sarebbe finito. Avrebbe dato una bella ripulita e al loro posto avrebbe assunto personale fresco e motivato, prima di tutti Giulia. L’aveva sempre guardata a distanza, lei che per laurearsi era stata costretta a lavorare tutte le sere poiché nella sua famiglia i soldi erano a malapena sufficienti a garantire il sostentamento. Lei che proveniva da una famiglia troppo povera per essere considerata nei colloqui di lavoro adatti al suo livello di studi. Lei che era guardata con la stessa supponenza con cui era sempre stato guardato anche lui. Si erano sempre osservati a distanza, come due prede che si studiano senza mai fare il primo passo. L’avrebbe assunta come braccio destro e le avrebbe chiesto di uscire con lui. “Anche questo lo faceva stare bene”.
Si diresse nuovamente al campo, come se nuova linfa avesse preso a circolare all’interno del proprio corpo, una linfa che forse faceva parte di lui da sempre, ma che non si era mai accorto di possedere. Arrivato alla pista si mise in linea accanto agli stessi atleti coi quali aveva gareggiato poco prima. Ora la chiave d’accesso del suo “stare bene” gli era nota e cara. La risposta non era il “cosa” ma il “come.” Partì all’unisono con i suoi compagni, guardandoli sghignazzare. Pochi minuti prima lo avevano battuto, erano convinti di essere più forti di lui? Contrasse i muscoli con decisione ma senza forzare, lasciando che l’odore delle magnolie penetrasse nelle sue narici, alle quali arrivavano anche altre fragranze di cui non conosceva le origini, né l’esistenza. Rimase affiancato agli altri. La linfa divenne improvvisamente fresca, come una doccia ristoratrice in un caldo giorno d’estate e allora affondò. Ricambiò il ghigno, superò il traguardo con disinvoltura e si voltò a braccia conserte a guardare i compagni ancora in arrivo. Fermo. In piedi. La loro andatura era scomposta e rabbiosa. “Scomposta, come la loro attività lavorativa, ma soprattutto scostante”. Non erano di nessuna utilità per l’azienda, lavoravano poco e male, mai in collaborazione con i colleghi, sempre in antitesi con lui. S'incamminò nuovamente verso casa. Fece una doccia e si recò dal barbiere. “Devi fare ciò che ti fa stare bene”. Guardò le ciocche cadere per terra formando una montagna. Il pavimento bianco improvvisamente era diventato nero, un nero che fino a pochi minuti prima invadeva la sua mente e oscurava i suoi pensieri. Pensò a come sarebbe stato sedersi su quella sedia di fianco a suo padre, mentre il suo volto emergeva in quello splendido taglio. “Questo mi fa stare bene”. Alzò gli occhi guardando nel vuoto, come se in quella dimensione potessero manifestarsi i suoi ricordi e scorrere sullo schermo come in un film. Un film che al cinema, sul grande schermo, lui non aveva mai visto. Si chiuse in se stesso giusto il tempo per ricomporre i pezzi della propria vita, ma solo per accorgersi che erano stati tenuti insieme da quelle parole. Scritte. Con cura. Su quel foglio. Fece il vuoto nella sua mente, ma il vuoto non c’era. C’era solo una parola che rimbombava, come un eco. “Devi”.

"Di cosa parliamo quando parliamo d'amore", titolo che arriva direttamente dal genio di Carver.
Come sempre potete ispirarvi all'opera originaleoriginale e prendere qualsiasi direzione troviate inerente.
Le regole, sempre le stesse:
I racconti (inediti) devono essere inviati a: contest@jonaeditore.it
Scadenza 31 dicembre 2017.
I due o più vincitori (se i racconti inviati saranno meno di cinquanta decreteremo solo un vincitore) avranno pubblicazione in www.jonaeditore.it
Link a Prospettive, l'ebook della prima antologia.

Da oggi è possibile iscriversi ai nostri corsi.
Questi i link (che trovate anche nel menu in alto e in quello a sinistra):
Descrizione dei corsi
Racconto
Punteggiatura
Struttura
Scrittura schizofrenica
Ma, visto di cosa trattano e capita la linea di pensiero che li unisce, come funzionano?
Dopo che effettuerete l’iscrizione, facendo il log-in, sulla destra della home page vedrete il vostro “menu utente”.
All’interno di esso troverete: “materiali”. In questa sezione ci sarà il link per partecipare alla lezione e, successivamente il video della lezione stessa e tutto il materiale che distribuiremo agli studenti.
Come partecipare alla lezione?
Il link vi porterà su youtube, in diretta streaming. A questo punto (se avete una webcam e se volete apparire) sarete “in classe” e potrete conoscere e interagire con il docente e partecipare alla lezione. Se non avete una webcam o semplicemente non amate mostravi, nessun problema, sarete in classe, vedrete tutto, gli altri potranno sentirvi. Se non volete neanche partecipare attivamente o doveste saltare una lezione, avete una alternativa: nella vostra area utente guarderete il video della lezione tutte le volte che vorrete.
In che orario saranno tenuti i corsi?
Al raggiungimento di almeno dieci iscritti si potrà iniziare.
Vi manderemo una mail per comunicarvi il giorno e l’orario della prima lezione. A seguire la cadenza sarà settimanale.
L’orario dovrà essere necessariamente comodo per tutti, lavoratori compresi, quindi l'inizio sarà tra le18 e le 20.
Ci sarà una lezione zero del corso, della durata di una mezz’ora, in cui vi presenterete e il docente vi spiegherà sia l’iter del corso, sia le procedure (qui descritte) per frequentare. In questo modo saremo tutti pronti per iniziare il percorso.
Per la sezione “racconto” gli studenti potranno partecipare, insieme al loro docente, alla scrittura di una antologia comprendente i loro racconti e avranno pubblicazione e contratto di editoria (ebook).
Per le altre specifiche vi rimandiamo ai link qui sopra pubblicati.
Per ulteriori informazioni potete scriverci a: corsi@jonaeditore.it o mandarci un messaggio nella nostra pagina facebook.
(Armonia in rosso)
Di fronte a lui era seduta una donna di mezz’età dall’aria affranta, forse per la giornata che si lasciava dietro le spalle, o forse per la serata che l’aspettava. Magari per entrambe. Il vagone della metro era quasi pieno. Sergio aveva trovato posto, non gli capitava spesso, e poteva osservare chi gli stava attorno senza preoccuparsi di restare in equilibrio o di impedire agli altri passeggeri di salirgli sui piedi. I suoi orari erano sempre gli stessi, e coincidevano con quelli di tanta altra gente che lavora dalle otto e mezza della mattina alle sei e mezza della sera. Solo quando andava in trasferta in qualche paese della provincia prendeva la macchina, che per tutta la settimana restava chiusa in garage. La tirava fuori il sabato per andare a fare la spesa in un supermercato distante da casa sua, che aveva prezzi più bassi rispetto agli altri. Con un solo stipendio e con la famiglia che s’allargava non poteva permettersi neanche la più piccola spesa superflua. Sua moglie era bloccata in casa nell’ultima fase della gravidanza per ordine del medico. Avevano sperato che potesse lavorare fino a due mesi prima del parto, ma le minacce di distacco della placenta, che si erano presentate alla tredicesima settimana, avevano interferito con i loro piani. Naisha, prima della pausa forzata, lavorava qualche ora la mattina, come segretaria, presso una cooperativa sociale. Era stato così che si erano conosciuti: lui era andato a ritirare un computer guasto e aveva trovato lei, che gli aveva spiegato con una dolcezza a cui non era abituato quali problemi avesse il proprio computer. Quando, dopo la riparazione, era arrivato il momento di riconsegnarlo, Pietro aveva insistito per andare di persona e ne aveva approfittato per offrirle un caffè al bar vicino alla cooperativa. Poi c’era stato un invito al cinema, e da lì era proseguito in modo del tutto naturale. Sua madre aveva fatto qualche obiezione all’inizio, troppe differenze culturali, ma alla fine anche lei aveva ceduto alla magia di quegli occhi neri, dentro i quali s’intuivano tutti i misteri della terra da cui proveniva la ragazza. Tutta un’altra cosa da quelle che le erano state presentate, in modo più o meno ufficiale, fino a quel momento.
Sergio era in ritardo di almeno due ore. Aveva telefonato a casa per avvertire, ma non sapeva di quanto tempo avrebbe avuto bisogno per portare a termine quello che stava facendo. Dipendeva da tutta una serie di fattori. Doveva aspettare e vedere come evolveva la situazione. Quando aveva staccato, alla solita ora, era sceso nel garage che si trovava sotto il palazzo, un complesso di uffici dove aveva sede anche la sua ditta, e dove erano parcheggiate tutte le auto degli impiegati e dei dirigenti. La sua intenzione era quella di affrontare il dottor Emili, il suo capo, in un faccia a faccia appartato, senza timore che qualcuno potesse sentirli. In ufficio aveva provato a spiegargli la propria situazione, ma era troppo sconvolto, le parole gli morivano in gola, tutto quello che era riuscito ad articolare erano concetti scollegati, il cui nesso era chiaro solo a lui: nessuno sarebbe riuscito a capirne il senso, figurarsi quell’uomo tutto compreso nel suo ruolo di selezionatore di scarti: questo sì, questo no, questo forse, vediamo. Il responsabile delle risorse umane. Forse il concetto che sua moglie fosse incinta l’aveva afferrato, quello Sergio era sicuro di averlo esposto in modo chiaro, ma, anche se l’aveva capito, aveva fatto finta di niente continuando a recitare la sequela inarrestabile di spiegazioni e di giustificazioni come una litania imparata a memoria: cifre, statistiche, bilancio, microeconomia, profitto. Il suo fiume di parole aveva tracimato, riversandosi con violenza brutale nella sua vita. E sbaragliandola. Ma adesso avrebbe potuto recuperare. Sapeva che Emili si sarebbe trattenuto qualche minuto di più in ufficio, usciva sempre dopo che tutti se ne erano andati. Si preparò ad aspettarlo, sperando nel frattempo di calmarsi e di riacquistare la lucidità necessaria per dire tutto quello che aveva in mente. Nel garage individuò subito la macchina dell’uomo, una Lexus nera, sempre tirata a lucido, arrogante come possono esserlo le auto che servono a far dimenticare la mediocrità di chi le guida. E che doveva essere costata quasi quanto la casa di cui lui e Naisha stavano pagando il mutuo. Si mise non lontano dall’auto, dietro un muretto, per non essere visto da nessuno: il garage s’era quasi svuotato, ma, oltre a quella di Emili, c’erano ancora diverse vetture parcheggiate in ordine sparso, in attesa di essere ritirate. Mentre aspettava, iniziarono a scorrergli nella testa le immagini al rallenty della scena di cui era stato, suo malgrado, protagonista un paio d’ore prima, e riprovò le stesse sensazioni, amplificate dalla consapevolezza, che si era rafforzata con lo scorrere dei minuti, che ci fosse ben poco da fare per uscire da quel dedalo inestricabile tracciato sulle sue paure.
Prima di allora non aveva mai notato quanto fosse sgradevole quella faccia. Lui lavorava a testa bassa, non aveva tempo per occuparsi d’altro. Ma quel giorno, durante il colloquio, quell’uomo era lì, a qualche centimetro da lui, a separarli la scrivania col piano di cristallo. Non erano mai stato così vicini. Emili era uno che si rintanava nel proprio ufficio e ne usciva solo per andare a pranzo e per tornare a casa. I contatti con i dipendenti erano tenuti dai responsabili di settore. Senza rendersene conto, Sergio si ritrovò a prendere consapevolezza dei tratti disarmonici, sproporzionati, del viso che gli stava di fronte. Non era solo l’aspetto esteriore: quello ormai cominciava ad apparigli come un guscio deforme e sgraziato dentro cui si adattava, seguendone in modo preciso i contorni, una massa duttile e malsana. Gli capitava di rado di considerare le caratteristiche fisiche delle persone, non gli interessavano, ma in quella situazione non riusciva a evitarlo. All’immagine di quell’uomo si sovrapponeva, in un gioco di trasparenze, quella di un suino, un maiale, come quelli che i suoi nonni in paese allevavano per tutto l’anno per poi far loro la festa a gennaio. Il testone dalla fronte stretta si allargava sulle guance fino alle mandibole, che erano la parte più larga del viso, quasi attaccate al collo largo e tozzo, corto, quasi inesistente. Gli occhi piccoli, con dentro due puntini neri che in quel momento erano fissi su di lui, ma che a tratti vagavano per la stanza alla ricerca di un oggetto qualsiasi su cui soffermarsi, da mettere a fuoco, come per permettere al portatore di quello sguardo sfuggente di riprendere lena, per finire un discorso che diventava sempre più penoso. Le parole filtravano tra le labbra sottili, la bocca larga sembrava un taglio, una ferita tra il naso e il mento. Nell’ascoltare quello che diceva, Sergio si sentiva montare dentro un’ondata di rabbia che cominciava a diventare difficile arginare. Lui non era un violento, non lo era mai stato. Ma di fronte a quella faccia imperturbabile nella sua sfrontatezza cominciava ad avvertire il desiderio di scuotere quell’uomo fino a fargli perdere quella sua aria da padreterno in overdose di onnipotenza. Avrebbe dato qualsiasi cosa per cancellare quel sorriso stereotipato, buono per tutte le stagioni e per ogni circostanza. Ma oltre a ribollire dentro non poteva permettersi altro: qualsiasi cosa avesse fatto avrebbe finito per ricadere anche sulla sua famiglia appena abbozzata. La concentrazione al minimo, sentiva solo a tratti quello che l’altro gli stava dicendo. Coglieva parole qua e là, ma il concetto era stato già espresso all’inizio, anche se lui ci aveva messo un po’ a rendersene conto. «… esubero… sei giovane … la crisi… referenze…». Se ne sbatteva grandemente delle sue referenze, dove diavolo lo trovava un altro lavoro, così su due piedi, e con la moglie incinta di sei mesi? Puntaccapo, si chiamava così il centro di vendita e riparazione dei computer dove prestava la sua opera, forse più qualificata di quanto non fosse richiesto. Aveva frequentato due anni di ingegneria informatica all’università e a lui quel lavoro piaceva: gli permetteva di mettere in pratica l’esperienza e le conoscenze acquisite. Non aveva mai finito gli studi perché, dopo la morte del padre, non se l’era sentita di gravare sulle spalle della madre, che ormai doveva vivere con la pensione di reversibilità e pensare anche a sua sorella minore. E quando aveva provato a cercarsi un lavoro part-time, aveva dovuto ammettere che i pochi soldi guadagnati non gli sarebbero bastati per tutte le spese e, se avesse lavorato di più, non avrebbe potuto dedicare allo studio il tempo necessario. Allora si era detto che avrebbe lavorato per un po’, messo da parte un po’ di soldi, per poi riprendere quando gli fosse stato possibile. Ma più il tempo passava, più quel proposito si allontanava. Ormai se ne rendeva conto anche lui, la laurea era destinata a rimanere uno dei tanti progetti naufragati strada facendo. Per la verità nella sua vita non ce ne erano stati molti, ma rinunciare a quello gli era bruciato più degli altri perché aveva tradito le aspettative di suo padre, che sognava di vedere in lui il primo dottore in famiglia. Puntaccapo, in quel momento quel nome manifestava un’ironia spietata. Lui non poteva mettere un punto, e non poteva andare a capo, perché non era più solo, sebbene non lo fosse mai stato, solo, come in quel momento. Era stato cacciato in quel labirinto e doveva percorrerlo senza appoggiarsi a nessuno.
Fu strappato a questi pensieri dal rumore metallico della pesante porta di ferro dell’interrato, che sbatteva richiudendosi. Doveva essere quella che portava agli ascensori e, nel deserto silenzioso del grande parcheggio sotterraneo, il rimbombo rimandò un’eco quasi sinistra. Qualcuno era entrato, se ne sentivano i passi veloci sopra il cemento. Sergio sbirciò dal suo angolo per vedere se si trattava di Emili, ma riconobbe nell’uomo che si avviava verso un’utilitaria uno degli impiegati della ditta, stacanovista o forse solo ritardatario. Si rimise in attesa, ormai non doveva mancare molto. Fece respiri profondi per allentare la tensione, doveva mantenersi calmo. Sentì il motore avviarsi e la macchina partire. Poi di nuovo silenzio, e allora ebbe l’impressione di sentire un rumore non lontano. Mise di nuovo la testa fuori dal proprio nascondiglio: Emili era vicino alla sua auto, a qualche passo da lui. Aveva appena aperto la portiera e si stava togliendo l’impermeabile prima di salire. Non poteva farselo sfuggire. Uscì di corsa da dietro il muro: «Dottor Emili, aspetti un secondo, la prego!», gridò. L’altro si voltò sorpreso e, nel riconoscerlo, assunse la stessa aria di sufficienza di due ore prima. «Ferranti, cosa c’è adesso? Ci siamo già detti tutto, non c’è nulla da aggiungere, mi dispiace.» «Ma mi lasci spiegare», quasi implorò Sergio. «Prima sono stato colto di sorpresa, non me l’aspettavo…» continuò. «Mi creda, la situazione è chiarissima, ma le ho anche spiegato le esigenze della ditta. Mi scusi, vado di fretta, ho gente a cena. Buonasera», e fece per salire. Sergio lo afferrò per un braccio: «Mi ascolti, me lo deve! Almeno questo, me lo deve!» «Ma che ca…! Ma è impazzito! Mi tolga subito le mani di dosso.» Sergio si controllava a fatica: le sistoli e le diastoli s’erano scatenate in una danza frenetica dentro il suo petto, il cuore si era come dilatato a occupare tutto lo spazio, le tempie pulsavano, le mani tremavano. Lui non mollava la presa, mentre Emili cercava di liberarsi: «Farabutto esaltato, lasciami in pace!», urlò il selettore di scarti. «Lasciami in pace? Brutto figlio di puttana! », sibilò Sergio, ormai fuori controllo, «a me la stai togliendo la pace! Mi stai togliendo tutto, grandissimo pezzo di merda! Lo capisci questo? Mi stai togliendo tutto!». Aveva iniziato a strattonarlo. Emili cercava di liberarsi per salire in macchina. Nei suoi occhi, che non avevano comunque perso l’arroganza ormai consolidata, era affiorata anche la paura. Si guardava attorno nella speranza di vedere arrivare qualcuno, ma c’erano solo loro due. «Ma va a farti fottere, buffone imbranato!», e fece un ultimo tentativo per liberare il braccio stretto nella morsa delle mani di Sergio, che a quel punto perse quel briciolo di autocontrollo che gli era rimasto e, afferrata la portiera, iniziò a sbatterla con forza contro l’uomo. Nel tentativo di entrare in macchina, Emili era rimasto con una gamba dentro e l’altra fuori, incastrato e destinato a subire i colpi senza possibilità di scampo. La pesante portiera si abbatteva su di lui con la violenza della rabbia repressa. Sergio non riusciva a fermarsi: «Infame barile di lardo, vuoi essere lasciato in pace, eh?», e continuava a colpire. «Hai gente a cena, vero? Adesso ti concio per le feste, e poi ti ci mando io dai tuoi preziosi ospiti!» I colpi diventavano sempre più violenti. A un certo punto Emili scivolò verso terra e, nella caduta, la sua testa si trovò nella traiettoria della portiera che si abbatteva su di lui per l’ennesima volta. Dalla tempia dell’uomo uscì un fiotto di sangue che in un attimo si diffuse su tutto il viso. Fu a quel punto che Sergio si fermò e, come paralizzato, fissò sconvolto l’altro, riverso sul pavimento di cemento del garage. Gli ci volle del tempo, lui non saprebbe dire quanto, per rendersi conto di quello che era successo: il suo incubo era diventato un incubo peggiore. Quando sentì sbattere la porta di ferro dalla parte degli ascensori, riuscì a scuotersi e, riacquistato un barlume di lucidità, si rese conto che doveva allontanarsi, e alla svelta. Cercando di restare nell’ombra si avviò verso una porta che stava dalla parte in cui si trovava lui e, attento a non fare rumore, l’accompagnò nel chiudersi e salì di corsa le scale che l’avrebbero portato fuori di lì. A casa.
Si era fatto due chilometri a piedi per arrivare alla stazione della metro: avrebbe potuto prendere il bus, come sempre, ma sentiva il bisogno di camminare, di scaricare il miscuglio di tensione, rabbia e paura. Ridiventare padrone di sé, almeno per quella sera. Doveva riuscire a dominare il terrore che gli era rimasto dentro per quanto era successo nel garage, non poteva portarlo a casa. Doveva anche tenersi dentro tutti gli interrogativi sulla sorte di Emili che gli si affollavano in testa: i giorni successivi sarebbero stati decisivi per il corso della sua vita futura. Poteva succedere tutto. O niente.
Quando era sceso dalla metro aveva percorso le poche centinaia di metri che lo separavano da casa sua quasi di corsa. Era già buio, in genere arrivava prima. Non vedeva l’ora di rientrare nella villetta a schiera nella prima periferia della città, dove aveva sognato di passare il resto della vita con Aisha e con i figli che sarebbero venuti. Quella sera più che mai aveva bisogno di un rifugio certo. Della presenza di sua moglie. Una donna coraggiosa: era partita dall’India settentrionale da sola per frequentare l’università in Italia. Quando si erano conosciuti era al terzo anno, e lavorava anche qualche ora nell’ufficio in cui si erano conosciuti. Col matrimonio e la gravidanza aveva rallentato, ma non rinunciato del tutto: aveva intenzione di riprendere appena possibile. Da dov’era Sergio cominciava a intravedere la luce del loro piccolo giardino: Aisha l’accendeva sempre, diceva che portava bene. E che nel suo paese c’era la festa della luce, e la divinità della ricchezza, in quel giorno, faceva visita nelle case dove ce n’era.
Era a due passi dal piccolo cancello della sua casa: si fermò un attimo per essere sicuro di riuscire a mantenere l’atteggiamento pacato che si era imposto. La finestra del salotto era aperta e ne usciva tanta luce: Aisha doveva aver acceso il lampadario centrale. Di solito accendeva solo le due lampade sulla credenza, mentre guardava la televisione dopo cena. Nell’avvicinarsi alla casa, giunse davanti alla finestra e vide che dentro c’era il tavolo apparecchiato. Sua moglie stava sistemando dolci e frutta sulla tovaglia rossa, come il suo sari. Era quello che aveva indossato quando si erano sposati: rosso, con ricami in varie tonalità di blu. Il rosso era il colore dell’abito da sposa nella parte del paese da cui lei veniva, era considerato il colore della purezza. Lo aveva cercato tanto in Italia, senza successo, e poi aveva chiesto alla sua famiglia di spedirgliene uno dall’India. Lui ne ricordava ancora la meraviglia quando aveva aperto il pacco. Lo aveva indossato solo un’altra volta dopo il matrimonio: in occasione del loro primo anniversario. E di colpo, con uno spasimo di consapevolezza, Sergio si rese conto che quel giorno era proprio il loro anniversario, il secondo, e lui, trascinato e stritolato nel tritasassi di quella giornata, lo aveva completamente dimenticato. Non riusciva a staccare gli occhi da quella scena, e l’armonia che sprigionava dai gesti distesi di sua moglie gli restituiva un po’ della fiducia che si era dissolta nella confusione, nella paura, nella rabbia, e nel senso di colpa, delle ore precedenti. Cercò le chiavi nella tasca dei pantaloni e si preparò a entrare in casa: aveva già fatto fin troppo tardi.