
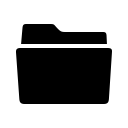
concorso (56)
Pietrasanta, 23/12/2017
stazione, ore 12:31
Ti ho notato da dietro il vetro, mentre il treno frenava in arrivo alla stazione di Pietrasanta. L'orologio a lancette, come ce ne sono a decorare ogni stazione, persino la più piccola, del territorio italiano, testimoniava un ritardo di cinque minuti. Come mio solito. Mi sono infilata il cappotto, quello rosso al ginocchio, lo stesso del nostro primo incontro, e un uomo mi ha aiutato con la valigia. Mentre la tirava giù ha sfiorato non troppo distrattamente il mio fondoschiena. Gli ho sorriso, immaginando quali pensieri ti stessero passando per la mente e godendo di ogni più piccola scintilla della tua rabbia. Che sentimento stupido la gelosia, non credi? Illudersi di possedere qualcuno al punto da sentirlo tuo, rivendicare il diritto di proprietà su una persona, su Margherita.
Ho sceso quei tre gradini sempre scortata dallo sconosciuto gentile e desideroso, che mi ha chiesto se avevo bisogno di un passaggio. Gli ho indicato un uomo fermo sulla banchina e ha capito. Eri lì, immobile, con le mani in tasca e lo sguardo di ghiaccio. Rilassati Antropologo, sono qui per te. Stretto nel tuo cappotto mi hai osservato mentre mi avvicinavo. Mi hai fissato negli occhi. Non hai distolto lo sguardo fino a che non sono stata a pochi centimetri da te e la tua bocca si è unita alla mia. Sono passati solo sette giorni? Anche per te sono stati lunghi quanto lo sono stati per me? Oserei dire di sì, seppur per motivi differenti. Mi hai travolto, sconvolgendo le mie abitudini e costringendomi a un'astinenza alla quale non sono abituata. Il mio letto piange, a ogni invito rileggo le tue parole: dovrò essere il solo, e rivedo le tue teche che mi ricordano la fedeltà. Dalla tasca ho sfilato la cintura della vestaglia di seta blu che mi hai regalato e ti ho chiesto di legarmi i capelli. Mi sono voltata e ho chiuso gli occhi. Mentre le tue mani sfioravano il mio collo ho rivissuto quella sera a Firenze, tu che lo scioglievi e io che immaginavo che uomo fossi: i tuoi capelli, se avessi la barba o se ti fossi ripulito a dovere per la tua prima volta, per me. Non desideravo altro che fuggire da quei binari, diretti a casa tua per perderci l'uno nell'altro. Con una mano hai afferrato la mia valigia e con l'altra hai preso la mia, di mano: «Andiamo, Margherita».
Dove, Antropologo? Avrei voluto chiederti. Non l'ho fatto. Ho lasciato che fossi tu a guidare il nostro incontro. Tornerai, mi avevi scritto, non ti farò male. Baciami, Antropologo, baciami ancora. Nel parcheggio siamo rimasti attaccati ignorando le persone che ci passavano accanto. Come la prima volta a Firenze, solo che a Pietrasanta c'era il sole e di nebbia nemmeno la minima traccia. Una giornata tersa, fredda. Hai preso confidenza. I tuoi gesti si sono fatti più sicuri. Le tue mani, così avide adesso da non temere confini. Hai aperto lo sportello e mi hai fatto sedere. Mi hai portato al mare, subito, prima di ogni altra cosa hai esaudito il tuo desiderio. E il mio.
Avevi prenotato in un ristorante sulla spiaggia, hai chiesto persino che mettessero uno dei loro lettini imbottiti al bordo della piscina vuota, con due coperte, così che potessimo sorseggiare il vino abbracciati guardando il mare. Hai bevuto per me, perché ogni promessa è debito. Forse un po' ti sta piacendo quella confortevole sensazione di torpore che nelle giuste dosi l'alcol sa dare, le inibizioni che piano piano spariscono e fanno emergere il lato più istintivo. Il cameriere ci ha scortato fino al tavolo, ha preso i soprabiti; vi siete detti qualcosa. Hai scostato la mia sedia con la tua solita galanteria. Non è stato necessario che mi preoccupassi di nulla, avevi studiato tutto nei minimi dettagli. Hai gusto, Antropologo, o forse abiti qui da sempre e sai cosa questi luoghi possano offrire. Ogni pietanza è stata accompagnata da un vino diverso, proprio come piace a me. Tutto delizioso. Non sono mancate le parole, non è mancato nemmeno Pietro nei nostri discorsi.
Non devi essere geloso di lui, è acqua passata. Non importa quanto lui provi a riavvicinarsi, o quanto sia abile nel comparire a sorpresa quando meno me lo aspetto. Abbiamo un accordo, adesso. Qualcosa di più.
«Cosa vuoi fare ora, Margherita?».
Ho preso la tua mano e ho rivolto il palmo verso l'alto. Ci ho scritto sopra le lettere del mio desiderio. Mi hai sfiorato la guancia, scendendo giù sul collo fino al nastro che pendeva dai miei capelli. Solo a quel punto ho parlato. «È ora che indossi di nuovo il tuo regalo, non credi?».
Hai sorriso. Non sorridi spesso, e hai annuito. Quando il cameriere ci ha servito i dolci hai chiesto il conto. Dopo aver pagato siamo usciti, ero certa che saremmo andati diretti all'auto e invece mi hai sorpreso di nuovo. Abbiamo camminato fino in fondo alla passerella. Premuta contro la ringhiera di quella strana rotonda, a palafitta sul mare, ho potuto godere della tua bocca e del calore del tuo corpo, stretto al mio. Non c'era nessuno questa volta, a parte noi due. Sentivo gli schizzi delle onde arrivarmi sulle gambe e pensavo che non c'era nulla da temere, il male che avresti potuto farmi non sarebbe stato nulla in confronto a quello che potevi offrirmi.
Arrivati a casa mi hai chiesto se volevo fare una doccia per togliere il freddo di dosso. Avevo in mente altro e sono andata in bagno a cambiarmi. Stessa vestaglia della prima volta, di nuovo solo quella. Avrei voluto chiederti subito della cantina e delle teche, ma mi hai sorpreso facendoti trovare lì, seduto su una sedia di fronte alla porta del bagno, quando l'ho aperta.
«Vieni qui, Margherita».
Le luci erano accese, questa volta, lo ricordo bene. C'era una bellissima lampada in salotto, una di quelle con il paralume enorme che scaldava l'ambiente. Hai slacciato la cinta della vestaglia e l'hai fatta scivolare a terra. Sono rimasta immobile di fronte a te. Ho goduto di ogni attimo in cui hai vacillato. Quando hai baciato la mia pancia, che ti piace tanto, quel lieve rigonfiamento proprio sotto l'ombelico, che ai tuoi occhi mi rende così sexy. L'eccitazione che solo il potere sa dare, il tuo desiderio per me.
Non pensavo che potesse essere così divertente avere in pugno un uomo. Di solito sono una brava giocatrice, tiro i dadi e via; pronta a cambiare tavolo. Cos'è che è diverso con te? Forse sei diverso tu, la tua voglia non si ferma alla necessità, no, si espande e mi avvolge fino a farmi godere del piacere di una replica, e di un'altra ancora.
Siamo rimasti a letto fino a ora di cena. Avevamo tutto il tempo per darci da fare, eppure abbiamo replicato subito. Poco dopo essere caduti esausti uno sull'altro nel tuo letto.
È qui che ha vissuto Adamo per quel breve periodo? La tua cavia n° 0. Il bambino che è riuscito a venire fuori dalla teca e a conquistare, giorno dopo giorno, sempre più spazio. L'hai lasciato libero e lui è tornato. È stato merito tuo, contro il tuo e il suo volere. È questo che stai facendo con me? È per questo motivo che sono qui?
Abbiamo fatto la doccia, questa volta te l'ho concessa. Hai accarezzato con la spugna ogni angolo del mio corpo e io ho fatto lo stesso con te. Il vapore era intriso dall'odore speziato del bagnoschiuma, e caldo l'accappatoio nel quale mi hai avvolto prima di lasciare che mi asciugassi nel suo abbraccio, e nel tuo.
Sei andato in cucina a preparare la cena e hai lasciato che finissi di sistemarmi, mi hai concesso la mia intimità. Te ne sono grata. Per te ho indossato di nuovo la vestaglia e mi sono seduta a tavola.
Il buon cibo e un ottimo vino sanno accompagnare alla perfezione le chiacchiere. Abbiamo parlato a lungo del nostro progetto insieme, di come poter continuare i nostri esperimenti. Lo sapevo che la mia avversione verso il genere umano si sarebbe sposata alla perfezione con la tua inclinazione allo studio della sua natura.
È stato allora che mi hai condotto in cantina tra le tue teche.
Dentro quegli enormi cubi di vetro rinchiudevi i tuoi topolini. Li portavi via dalle loro tane e osservavi il loro comportamento per giorni, fino all'esalazione del loro ultimo respiro. Hai un giardino sufficientemente ampio nel quale regalare loro un posto in cui riposare in eterno. Troppo grandi per cibare i tuoi gatti. Fino ad Adamo, il bambino che amava disegnare. Avevi comprato anche degli acquerelli per lui. Perché lui era diverso. Aveva visto in te qualcosa di simile a quello che ho visto io, e aveva imparato ad amarti. Ho potuto vedere quello che agli altri tieni nascosto: il buio nel quale volevi che ci immergessimo per la tua prima volta. Adesso chi di noi due deve avere paura? Non ci sono coltelli qui, sei in salvo.
Mi hai condotto nella teca che è stata di Adamo e su quel pavimento abbiamo fatto quello che piace a me. Scomodi ed eccitati, a luci spente ci siamo spinti in fondo alla tua anima e abbiamo goduto della libertà di non avere segreti. Ti sei sciolto dall'abbraccio per cercare l'interruttore. Al primo clic la luce non si accesa. È successo al secondo tentativo e ti ho visto, al di là del vetro.
Ho spinto, ma non si è mosso. Non ci sono maniglie all'interno della teca. Mi hai sorriso, da fuori, una luce diversa illuminava i tuoi occhi. Non farmi male, Antropologo, me l'avevi promesso. Tu le promesse le mantieni. Non si può cambiare la propria natura, questo lo so. Apri la porta, ti prego, non salire quelle scale da solo. Hai accesso una telecamera, l'ho capito dalla lucina rossa che ha iniziato a lampeggiare. Ti sei dato una sistemata. Hai appoggiato il palmo della mano sul vetro, dove io avevo il mio.
«Buonanotte, Margherita».
Non andartene.
Mi hai lasciato lì, da sola, con addosso soltanto la vestaglia.
Memento I
Il tempo di mettere a posto la cucina e sarai di nuovo da me, Antropologo. Mi farò desiderare un po' quando aprirai questa porta. Giocare è pane per i miei denti. Farò finta di rimettere le mie cose dentro alla valigia, pronta a ripartire, nel bel mezzo della notte. Tu che cerchi di trattenermi, che mi preghi di restare e io che vado verso la porta con già il mio cappotto addosso. La vestaglia abbandonata sopra una sedia. Chiara intenzione di non rimettere più piede in casa tua e di non rivedersi tanto presto. Un po' di sofferenza, non troppa, non sono poi così cattiva. Solo l'intento di farti provare di nuovo quel senso di solitudine che adesso forse per te è lontano. Non siamo a distanza di sicurezza dalle nostre debolezze. Questo dovresti saperlo meglio di chiunque altro.
È come essere dentro a un grande ninnolo natalizio. Queste pareti di vetro sono davvero molto alte, troppo per essere scavalcate. Tutti ambienti vuoti, per terra solo cemento. Le tenevi così le tue cavie, o davi loro qualcosa con cui intrattenersi durante la prigionia? Il pavimento è freddo, impossibile in questa stagione sdraiarsi per dormire. Era questa la loro tortura durante i mesi invernali, cercare di restare svegli il più a lungo possibile per non morire di freddo? Chissà come facevano quando dovevano andare in bagno, forse eri clemente con loro e al momento dei pasti concedevi una breve gita di sopra. No, non hai mai parlato di cibo. Di acqua sì. Ricordo i primi topi, i primi bambini, sette. Insieme e poi separati in gruppi. La prima perdita, e le conseguenti altre. La sepoltura in giardino, i tuoi gatti. Fine dell'esperimento e sei passato a quello dopo.
Memento II
Dovresti aver finito ormai di riordinare. Chissà perché ci stai mettendo così tanto a tornare da me. Vieni a prendermi, Antropologo, prometto che farò la brava. Niente finte questa volta, lo giuro. Salirò quelle scale con te e ci metteremo sul divano a parlare, oppure nel letto, a fare quello che più ci piace. Magari mi stai preparando una sorpresa. Stai cambiando le lenzuola pensando a un bagno caldo, oppure hai scelto una musica di sottofondo e stai versando del brandy nei bicchieri, pronti ad accogliermi, tra pochi minuti. Forse ti sei messo un attimo al pc e stai chattando con qualcuno, o stai pubblicando i risultati dei tuoi ultimi studi.
Inizia a fare freddo qui, e sono stanca di stare in piedi. Non c'è nemmeno nessuno con cui parlare. Ho provato a gridare sperando che là in fondo, in quell'angolo, il buio nascondesse una presenza, qualcuno che mi potesse fare compagnia. Ti sentivi così, vero, prima che arrivassi io? Stai godendo dei miei lamenti, ora? È bello essere potenti, avere la certezza del dominio assoluto sull'altro. Tu lassù che cammini sopra la mia testa; ascolto i tuoi passi cercando di capire i tuoi movimenti. Il gioco è bello finché dura poco. Ho capito la lezione, Antropologo, non c'è bisogno che mi tratti come fossi un topo. Sono Margherita, quella Margherita.
Memento III
Mi fanno male le mani. A forza di battere sul vetro finirò per lussarmi qualcosa. Cazzo, Antropologo, liberami! Cosa vuoi farmi, eh? Vuoi farmi restare qui tutta la notte, o forse giorni, vuoi studiarmi, è questo che vuoi? Mi stai forse dicendo che sono una delle tue cavie, sì, uno di quei dannatissimi topi che hai lasciato morire di stenti? Se speri che come Adamo, quando potrò di nuovo essere fuori di qui, starò buona nella tua stanza in attesa di un tuo cenno, o a mendicare un tuo regalo, te lo puoi proprio scordare. Me ne andrò, ecco cosa farò, tornerò da dove sono venuta e ci resterò per sempre. Non posso nemmeno denunciarti. Non ho paura di morire, razza di psicopatico, non voglio finire in galera! Io so quello che hai fatto e tu sai quello che ho fatto io. Potremmo accordarci e stringerci la mano da buoni amici. Che ne dici, non ti sembra una buona idea? Ottima, ottima.
Quando mi hai chiesto se volevo vederle da dentro o da fuori, le tue teche, e io ti ho detto che ti avrei lasciato la scelta, che sapevo i rischi che correvo, non credevo che avresti avuto il coraggio di farlo sul serio. È da sempre che mi studi, vero? Sin dal primo istante hai tenuto il tuo sguardo puntato su di me in attesa che arrivasse il momento adatto per colpire. Affondata, Antropologo, hai centrato il bersaglio. Portami almeno una coperta, per favore, affacciati, chiedimi se va tutto bene. Fammi capire che non sono come quei bambini. Concedimi almeno di essere Adamo.
Memento IV
Nessuna premura per la tua povera Margherita. Chissà che ore sono, non mi hai lasciato nemmeno l'orologio. È già mattina? Speriamo che aprendo gli occhi tu ti ricordi di me, di venirmi a liberare. Spero che tu mi dica che è stato uno scherzo, che ti sei addormentato contro la tua volontà ed è per questo che hai aspettato tanto. Ti svegli presto, Antropologo, non manca molto a uscire di qui; mi preparerai la colazione e mi riempirai di baci, io ti perdonerò e faremo l'amore fino a cadere esausti uno nelle braccia dell'altro.
È così che si è sentito Greg negli ultimi istanti della sua vita? Povero Gregorio, chiuso dentro quella cella frigorifera. L'hai fatto per farmi capire, per farmi provare quello che io ho fatto provare a lui. Un regalo. Poter gustare fino in fondo il piacere di infliggere sofferenza a chi si crede invincibile. Basta un attimo, una distrazione. Com'è successo a lui, e da carnefice per magia ti ritrovi vittima. No, riaccendila per favore, lasciami almeno la luce. Ti supplico, non mi serve dormire, voglio vedere, voglio restare vigile. Devo ricordare di essere qui, nella tua cantina. Lascia almeno che i miei occhi possano avere qualcosa su cui distrarsi. Sono prigioniera, sono tua Antropologo, sono tua.
Memento V
Sono lacrime, queste? Ho il viso bagnato, sento ancora più freddo adesso. Non lo so quanto tempo è passato dall'ultima volta che ho pianto. Non me lo ricordo. Forse è stato quando sono morti i miei genitori, ero solo una bambina. Sei un uomo galante, Antropologo, fammi almeno andare in bagno. Ho bisogno di andare in bagno. Ho sete, Antropologo, non ce la faccio più a urlare. Mi fa male la gola, le mie gambe hanno ceduto. Il pavimento è freddo. Mi fa male anche la testa. Il cranio è duro e per quanto abbia sbattuto la fronte contro il vetro non sono svenuta. Accadrà presto se non mi darai qualcosa da mangiare. Ho fame.
Non voglio più tornare a casa. Ti prometto che resterò qui con te, povero, dolce assassino. Uccideremo insieme Pietro, così lui non sarà più un problema. Non mi importa di lui, non mi è mai importato nulla. Può tornare da me tutte le volte che vuole, io non sarò mai sua. Voglio te, Antropologo, ancora non l'hai capito? Cos'altro devo fare? Amami, Antropologo, non chiedo altro. Ma tu non mi farai uscire, vero? Morirò qui, con addosso soltanto la vestaglia che mi hai regalato. Dovrei ridere in vece di piangere. Che ironia, morire nei propri panni. Sei un uomo abile, è per questo che mi piaci. Va bene così, Andrea, hai vinto tu.
Clic. La luce si è accesa. Clic. La telecamera non lampeggia più. Ho sentito le tue braccia, mi hanno cinto da dietro e mi hanno sollevato da terra.
«Che ore sono?».
«È da poco passata la mezzanotte».
«Scorre così lento il tempo senza riferimenti...».
Mi hai preso in braccio. Mi hai portato su e mi hai avvolto in una coperta. Lasciandomi sul divano, sei andato in cucina e mi hai portato una tazza di tè bollente. Ti sei seduto di fianco a me e mi hai abbracciato. Ti ho guardato e tu mi hai sorriso, questa volta con dolcezza. Hai aspettato che smettessi di tremare e mi hai lasciato andare in bagno. Mi sono sciacquata il viso e ho risistemato il trucco. Quando sono tornata avevi gli occhi chiusi, la nuca appoggiata alla spalliera. Sono rimasta immobile, in piedi di fronte a te per qualche secondo. Hai allungato la mano e hai sciolto il nodo della cinta. Ti sei alzato per legarmi i capelli e scoprirmi le spalle, lasciando scivolare la seta sul pavimento. I tuoi gesti erano sicuri, forti della conquista appena ottenuta. Mi hai fatto chiudere gli occhi. Ho sentito qualcosa di freddo appoggiarsi al mio petto. Un ciondolo. Il mio regalo di Natale. Come lo sai che mi piacciono i gioielli? Non ne sbagli una, Antropologo. Un diamante: simbolo di purezza, resistenza, unione, perfezione, amore eterno. Ti ho ringraziato, nel modo in cui può far piacere a un uomo. A te, Andrea. Mi hai aperto gli occhi. Siamo andati a letto e ci siamo addormentati abbracciati.
«Domani riguarderemo il video, insieme,» hai sussurrato.
Devo chiuderla in un cassetto quella dannata cornice.
Quella serpe di mia moglie continua a fissarmi attraverso il vetro polveroso.
Ah! Mia moglie!
Me la ricordo bellissima davanti all’altare, fasciata in un abito bianco pieno di pizzo e con un diadema tra i capelli. Aveva un sorriso radioso e le brillavano gli occhi mentre quasi urlava "lo voglio!".
Due anni dopo mi lanciava i piatti, quella pazza.
Io che le servivo la colazione a letto, la portavo fuori tutte le sere, le lasciavo dei fiori sul tavolo prima di andare al lavoro.
Io che la riempivo di attenzioni e complimenti.
Mi domando ancora perché l'abbia sposata, avrei potuto avere qualsiasi donna, perché sì, modestamente ero proprio un gran bel ragazzo, diciamocelo.
Eppure ho scelto lei, una ragazzetta bassa, magra magra, che sembrava quasi una bambina.
Quando la vidi la prima volta ballava in mezzo alla pista, da sola, e aveva una tale energia che contagiava anche il più pigro dei ballerini. Indossava un vestitino azzurro con la gonna un po' svasata, che quando ballava si gonfiava e svolazzava di qua e di là. La guardavi dimenarsi e le gambe ti partivano da sole. Che grinta che aveva!
Chissà che fine ha fatto quella ragazzetta svitata; quando, di preciso, si è trasformata in una moglie acida e prepotente. Non le stava mai bene nulla, ogni scusa era buona per aggredirmi.
Come quel giorno, lo ricordo bene.
Tornai a casa con le buste della spesa convinto di averle evitato l'incombenza per quella settimana, e lei iniziò a gridarmi contro, a darmi dell'irresponsabile, del buono a nulla.
Ma dico io, si tratta così un marito premuroso?
E pensare che volevo portarla fuori a cena, quella sera.
Invece finimmo per litigare come al solito e mi ritrovai di nuovo a dormire sul divano.
“Oh, ma che hai da guardare ancora?
Sto parlando con te, sì, mia cara Giuliana.
Puoi anche smetterla di fissarmi a quel modo, prima o poi ti ci butterò davvero in quel cassetto a marcire, tu e la tua bella cornice d'argento. Ce l'hanno regalata per le nozze, te lo ricordi?”.
Mi rendo conto che sto parlando a una fotografia, forse è il caso che me ne vada a letto.
"Buonanotte Giuliana, dormi bene".
"Buonanotte Pietro, abbi cura di te".
Chissà perché ancora do la buonanotte a quel disgraziato, mi ha fatto passare due anni d'inferno.
Eppure la sua foto è lì, vicino al portagioie.
Non so nemmeno dove vive, adesso.
Avrà preso in affitto un buco di appartamento; immagino sia spoglio e triste, perché lui figuriamoci se l'ha arredato. Montare delle tende, prendere dei soprammobili, o anche solo dei mobili che non siano necessari. E le sue necessità sono davvero poche.
Perché lui ormai è fatto così, non si cura più di niente, sopravvive.
Eppure me lo ricordo il giorno in cui l'ho conosciuto, così stravagante e con il ciuffo ribelle.
Era un biondino niente male che si credeva un gran playboy.
Ma in verità le ragazze lo sfruttavano perché era il più grande del gruppo, l'unico con la macchina, e faceva sempre regali a quelle che gli piacevano. Così loro si facevano corteggiare per un po', sbattevano le ciglia e ottenevano quello che volevano, si facevano portare in giro per negozi...
Era proprio un gran fesso, il mio Pietro.
In fondo me ne sono innamorata proprio per la sua ingenuità, per la sua purezza di sentimenti.
L'ho sposato convinta che sarebbe stato per sempre.
Eravamo così felici, ridevamo un sacco, di ogni cosa.
Poi ha iniziato a bere, e non ho mai capito perché.
Rientrava la sera sempre ubriaco, non si reggeva in piedi. A volte tornava direttamente al mattino, entrava in camera con un vassoio e un bicchiere di vino, biascicava un "buongiorno tesoro" e si aspettava che gradissi il suo gesto.
E vogliamo parlare dei gambi di sedano che mi lasciava sul tavolo da pranzo? Secondo lui erano fiori bellissimi! Certo, dopo il primo fiasco gli saranno sembrate rose rosse.
E con quei gesti pretendeva di portarmi fuori tutte le sere.
Peccato che andare fuori fosse andare al bar a giocare a carte con gli amici, tutte le sere.
Tutti ubriachi.
Quando rientrava e, ubriaco, mi lusingava diceva che ero bella come una nuvola dopo il sole, che profumavo come un fiore di plastica, che gli ricordavo sempre quante donne aveva perso per scegliere me.
Ah! ma erano gran complimenti, secondo lui!
Nei pochi momenti in cui era sobrio mica se le ricordava le cose che mi diceva. Sarà ancora convinto di essere stato un marito perfetto e un galantuomo! Un giorno era tornato a casa con le buste della spesa, non si reggeva nemmeno in piedi tanto era ubriaco. Le aveva appoggiate sul tavolo, tutto fiero come se avesse compiuto chissà quale impresa. Peccato che avesse comprato solo vino. E secondo lui era la spesa per la settimana.
Chissà perché mi ostino a tenere la sua foto in bella mostra, perché lo saluto e gli auguro la buonanotte tutte le sere. Per quello che me ne frega potrebbe pure affogarci, nel vino!
Quel disgraziato!
“Hai bevuto anche stasera, Pietro? Eh?”.
Ho bevuto troppo, anche stasera.
L’emicrania non mi abbandona da mesi eppure continuo a bere.
Non ricordo nemmeno più quando ho iniziato, se è stato ieri o un anno fa.
Le chiesi quando avremmo pensato seriamente a dei bambini, quando avremmo sentito anche noi il rumore di piedini che correvano per casa.
Non mi rispose, o forse sì.
Comunque fu chiaro che non lo avrei mai sentito quel rumore.
È lì che ho iniziato a bere? È in quel momento che è andato tutto a rotoli?
Non lo so.
Io li avrei tanto voluti dei bambini, mi manca ancora oggi non avere qualcuno a cui togliere le ruotine alla bici perché si senta grande, a cui correggere i compiti la sera. Qualcuno che allieti i Natali recitando una piccola poesia, in piedi su una sedia e col vestito nuovo. Qualcuno a cui provare aspiegare i perché della vita, qualcuno che me ne insegni il valore con la sua sola presenza.
Non lo so che è successo, davvero.
Mi sembra di essermi addormentato una sera, felice e con una moglie magnifica accanto, e di essermi svegliato il giorno dopo in un mondo parallelo fatto di oblio e tristezza.
“Ma che ne sai tu, Giuliana! Che ne sai, eh? A te non importava niente di queste cose, tu stavi bene così e mocciosi tra i piedi non ne volevi, ecco cosa”.
Sento salire la solita rabbia, incontenibile, la mia unica compagna da mesi. E sto già riempiendo il bicchiere, ho bisogno di dimenticare tutto questo dolore.
Dov'è finita la mia ragazzina scatenata?
Dov'è la donna che la domenica mi preparava l'arrosto e mi prendeva in giro perché se provavo a cucinarlo io lo bruciavo sempre?
“Avevi ragione sai, Giuliana? Sono negato in cucina, lo sono sempre stato.
Pensa che ieri ho voluto preparare una frittata, una semplice frittata Giuliana, mica un piatto da chef! Quando ho provato a girarla è successo un macello”. Oggi pulendo il pavimento ne ho trovato un pezzo sotto il lavabo. È finita ovunque, probabilmente in qualche angolo della cucina alcuni pezzi faranno la muffa e li ritroverò chissà quando.
“E ti ricordi quanto facevo schifo a sistemare la biancheria? Ero davvero pessimo, e lo sono ancora.
Non ti sorprenderebbe affatto saperlo”.
Nel mio armadio c'è una collezione di camice bruciate, pantaloni macchiati e calzini spaiati.
Butto giù un altro sorso e sento la testa che inizia a girare.
“La sai una cosa, Giuliana? Come casalingo faccio proprio schifo, però come marito non ero affatto male e tu di lasciarmi così non dovevi farlo.
Non me lo meritavo”.
“Chissà se i tuoi sbagli li hai mai capiti, Pietro.
Se ti sei mai reso conto di quanto mi ferivano le tue parole, le tue nottate fuori casa, il tuo silenzio invalicabile come un muro, da quando mi ero ammalata.
Avevi preferito il vino a me, e quando ti comunicai che le cure sarebbero state molto pesanti scrollasti le spalle.
In quel momento ti odiai, riuscisti a farmi sentire sola come non mi ero mai sentita in vita mia.
L'uomo che amavo mi aveva abbandonata pur essendo fisicamente accanto a me.
Lo hai fatto di proposito? Ero diventata un peso per te, Pietro?”.
Non lo saprò mai, probabilmente.
“Ho dovuto affrontare da sola esami invasivi e terapie che mi hanno quasi distrutta, mentre tu uscivi a bere e te ne fregavi. Come se non fosse tua moglie quella malata, quella che rischiava di morire.
Ti ho urlato in faccia il mio dolore, molte volte, liti furibonde, ma il giorno dopo non ricordavi niente.
Ti comportavi come se nulla fosse successo. Ho avuto per molto tempo la sensazione di vivere in una farsa, come se fossimo gli attori della vita di altre persone.
Per questo bevevi, forse, per dimenticare una vita che non ti piaceva.
Eppure eravamo stati felici, ci eravamo amati tantissimo ed eri stato per me l'amico più prezioso, il compagno ideale, l'amante appassionato.
Ci capivamo con uno sguardo, te lo ricordi?
A volte notavamo qualcosa di buffo e ci scambiavamo un'occhiata complice, prima di scoppiare a ridere come ragazzini. Quante volte ti ho rimproverato bonariamente per il tuo modo confusionario di sistemare i vestiti nell'armadio! Ed eri così distratto mentre stiravi, ma ci ridevamo sopra.
Abbiamo riso tanto io e te, anche guardandoci attraverso i bordi bruciacchiati dei buchi che provocavi nelle camice.
Poi hai deciso di dimenticarmi, non lo so perché.
Spero tu ci sia riuscito, alla fine”.
“Non credo riuscirò mai a farmene una ragione, sai Giuliana?
Continuo a passare le notti fissando il soffitto chiedendomi cosa sia successo.
Quando abbiamo smesso di essere complici?”.
Non me lo ricordo.
Mi sembra tutto così assurdo, a volte.
“A un certo punto sei diventata fredda, distante. Hai iniziato a odiarmi da un giorno all'altro.
Cos'è successo in quei giorni, Giuliana?
Perché qualcosa dev'essere pur successo!”.
Ultimamente mi sono reso conto di avere dei vuoti di memoria, è come se avessi completamente rimosso parti della mia vita.
Alcune giornate le ricordo a metà, poi c'è il buio.
Mi succede ancora, anche adesso, per esempio. Per quanto mi sforzi non riesco a ricordare cosa ho fatto ieri sera dopo il lavoro. So di essere arrivato a casa, di essermi buttato sul divano con un bicchiere di buon vino e poi c'è il buio. Forse mi sono addormentato. Dev'essere andata così.
“Però di quel periodo ricordo la tua assenza. Non eri quasi mai in casa e quando tornavi eri sempre molto nervosa e con l'aria stanca. Non avevi l'aspetto che hanno le donne quando sono innamorate, e non dico per forza di me. Ci avevo pensato tu potessi avere un amante, sai? Ma eri troppo trascurata, arrabbiata, spenta. Non eri felice come chi ha trovato un nuovo amore.
E allora cos'era? Cosa ti ha portata via da me?”.
Oggi sono andato a fare la spesa e la cassiera ha imbustato le mie cose guardandomi in modo strano, sembrava triste. Credo di farle pena.
È quasi Natale, da quello che compro avrà capito che sono completamente solo, anche in questi giorni di festa. “E tu che farai a Natale? Andrai da tua madre, forse. O da tua sorella, così potrai giocare con i tuoi nipotini”.
Io non ho nemmeno i figli degli altri da coccolare, nessun bambino a cui portare regali.
Impacchetto i giocattoli per i miei nipotini pensando a quanto sarà doloroso questo Natale. Ho rifiutato l'invito di mia sorella per il pranzo, me ne starò a casa da sola.
In questo periodo sono così fragile che potrei mettermi a piangere davanti a tutti e non voglio rovinare le feste ai miei cari.
Ho fatto gli esami di controllo, quelli di routine per vedere se procede tutto bene.
Pare di sì.
Il problema è che non sono felice come dovrei di questa speranza di vita che pare concretizzarsi.
Mi sento svuotata, come se mi avessero strappato il cuore dal petto a mani nude.
Ho un enorme vuoto dentro e molti rimpianti.
“Chissà cosa starai facendo tu, Pietro. Spero tu non stia dormendo ubriaco sul divano, come sempre.
Io rischio di morire e tu vivi come se già lo fossi, morto”.
Vorrei tanto avere vicino l'uomo che ho sposato, in questo momento sarebbe fondamentale.
Mi sento così sola, invece.
“Avrei tanto voluto dei bambini, sai Pietro? Li desideravo così tanto...
Invece dentro me stava crescendo questo male e tu dopo averlo saputo sei scomparso.
Finché una sera, ubriaco, mentre io a malapena riuscivo a reggermi in piedi hai avuto il coraggio di chiedermi quando mi sarei decisa a darti dei figli. Io stavo morendo nella tua completa indifferenza! Perché? Perché tanta crudeltà, Pietro?
Certi giorni mi trascinavo fuori dal letto e credevo di impazzire per il dolore, eppure tu mi hai lasciata sola. Perché sei stato tanto cattivo con me? Perché mi hai odiato così tanto da abbandonarmi a me stessa mentre stavo morendo? Lo avevi capito, vero, che stavo morendo? Ancora oggi, nonostante le terapie sembrino funzionare, io potrei morire da un momento all'altro.
Quale uomo si comporta così con la donna che dice di amare? Perché lo hai fatto, Pietro?
Ieri la cassiera del mini-market mi ha detto che sei passato, come ogni giorno, a comprare pasta, un sugo pronto e due bottiglie di vino. Compri solo queste cose, tutti i giorni.
Me l'ha detto con l'aria mortificata, poverina, come fosse colpa sua se ti sei ridotto così.
Avremmo potuto essere felici, invecchiare insieme, invece ti sei perso chissà dove. Chissà quando. Non lo ricordo neanche il momento preciso, quand'è che mi hai sostituita col vino.
Pensare che quando ti ho conosciuto, in quel locale, stavi reggendo un bicchiere con del succo di frutta alla pera. Ricordo di averti preso in giro per questo”.
Vado a letto, non so nemmeno perché continuo a farmi queste domande che rinnovano tutto il mio dolore.
“Buonanotte Pietro, dormi bene”.
Mi sono svegliato sul divano, con un braccio che penzolava e la schiena a pezzi. Il bicchiere di vetro, vuoto, è rotolato a terra con una scia di goccioline rosse sul pavimento color crema.
Sento la testa pesante, pulsa e ho la nausea.
Mi trascino in bagno barcollando e appoggiandomi ora al muro, ora a uno dei pochi mobili che ho messo in casa.
Mi sciacquo la faccia e l'immagine che mi rimanda lo specchio quasi mi spaventa.
Ma quanti anni ho?
Gli occhi sono segnati da rughe e da profonde occhiaie bluastre, la pelle ha un colorito giallognolo, sembro malato. I capelli sono troppo lunghi e crespi.
Non faccio la barba da giorni, non ricordo quanti.
Sono davvero io l'uomo nello specchio? Quando sono diventato così?
“Tu lo sai, Giuliana? Tu mi avrai visto cambiare, devi esserti accorta di quando è successo. Voi donne vi accorgete sempre di tutto. Io non ricordo più nemmeno che taglio di capelli avevi quando mi hai sbattuto la porta di casa, la nostra casa, in faccia.
Ricordo che mi hai gridato di sparire, di non farmi più vedere. Hai gridato cose cattive, cose che non mi merito. Hai detto che sono un maledetto egoista, una persona arida e senza cuore.
Come hai potuto dire quelle cose? Ti ho sempre amata così tanto, cercavo di farti felice.
Sei stata tu ad allontanarti, ad alzare un muro tra noi”.
Esco dal bagno e mi guardo intorno.
Com'è vuota questa casa, com'è spoglia, triste.
Vado in camera e mi siedo sul letto, niente di più che un materasso scomodo buttato su una rete a doghe un po' traballante. Lo stretto necessario. “La tua fotografia, quella cornice d'argento, è l'unico oggetto carino della casa, sembra quasi fuori luogo.
Dove sei, Giuliana?”.
Questa casa mi opprime, devo uscire. Prima però torno allo specchio, l'immagine che mi rimanda è davvero terribile. Faccio la barba e pettino i capelli. Ritrovo quasi il mio ciuffo sbarazzino di qualche anno fa. Ho il volto stanco, ma faccio un po' di prove e alla fine trovo un sorriso da indossare. Mi metto degli abiti puliti ed esco. Non lo so dove voglio andare, ma non posso rimanere chiuso in questa casa un minuto in più.
Dove sarei andato di lunedì pomeriggio se avessi vissuto ancora con mia moglie?
Mi incammino.
È iniziata un'altra settimana e non ho proprio voglia di affrontarla. Mi sento sola, stanca, depressa. A volte avrei voglia di perderla questa battaglia con la malattia.
Cosa mi rimane, in fondo? Ho perso già tutto.
Non sorrido da mesi. L'uomo che amavo è diventato una larva, è più morto di me e Dio solo sa che fine abbia fatto. Quando l'ho cacciato di casa, mesi fa, gli ho urlato in faccia tutta la mia rabbia e gli ho detto di sparire per sempre dalla mia vita. Non mi ha neanche chiesto perché.
È sparito, semplicemente.
Afferro la borsetta ed esco, oggi è il giorno dedicato alla spesa e come sempre parlerò un po' con la cassiera del mini-market mentre imbusto le mie cose. È un'abitudine che ho preso da sposata quella della spesa di lunedì, ci andavamo insieme io e Pietro, ogni lunedì pomeriggio dopo il lavoro, puntuali.
È una bella giornata e il negozio è qui vicino, quindi decido di fare una passeggiata e raggiungerlo a piedi, in fondo mi mancano poche cose e un paio di buste non sono un gran peso da trasportare.
Cammino pensando a quello che mi serve, non molto in effetti, ormai cucino pochissimo. A che serve cucinare per ore se non c'è nessuno ad apprezzare il mio impegno? La cucina è amore, è condivisione di un piacere.
Io sono sola.
Arrivo nel piazzale del market e prendo un carrello, con la coda dell'occhio vedo un tipo con un ciuffo biondo fermo vicino alla porta del negozio.
Per un attimo il mio cuore si ferma.
Che stupida che sono!
Dopo tutto quello che mi ha fatto passare mio marito ancora ho il batticuore se vedo uno sconosciuto che me lo ricorda… Non gli do nemmeno una seconda occhiata, mi sento una ragazzina stupida.
Mi avvio all'ingresso scuotendo la testa.
Sto per entrare nel mini-market quando la vedo scuotere la testa, con lo sguardo fisso sull'asfalto del piazzale. I suoi capelli ondeggiano e anche se le nascondono il viso so che è lei, ed è bellissima.
È un po' magra, forse. Ha l'aria stanca.
Rimango immobile mentre si avvicina, mi sento come un bambino che arriva impreparato al suo primo esame. Mi ricordo dei sorrisi che ho provato allo specchio e simulo velocemente quello che mi era venuto meglio. Lei però mi passa accanto senza guardarmi, senza alzare la testa, oltrepassa la porta e si perde tra i banchi del reparto frutta e verdura.
Il mio cuore sembra impazzito, batte velocissimo e sento un calore allo stomaco.
Mi si rimescola qualcosa, dentro.
Credevo di non averlo nemmeno più un cuore, o almeno credevo che fosse lì proprio come i miei mobili, solamente per necessità.
Devo entrare?
Oh Giuliana, quanto sei bella. Da quanto tempo non ti vedevo? Troppo.
Dovrei farmi coraggio ed avvicinarti, cercare un contatto visivo e vedere come reagisci, ma ho paura. Ci siamo lasciati male, malissimo per la verità.
Inizio a credere che sia stata colpa mia… Ormai è evidente perfino a me che ho un problema con l'alcool, che mi ubriaco troppo spesso e al risveglio non ricordo le cose. Magari mi hai detto cose importanti, cose di noi, e io le ho dimenticate. È andata così, Giuliana? Per questo sei diventata così fredda con me, all’improvviso? Vorrei entrare, ma temo di peggiorare la situazione.
Ma in fondo cos'è che può peggiorare?
Entro e inizio a camminare tra i reparti, sbircio tra gli scaffali, ti cerco tra la gente. Il negozio è piuttosto piccolo eppure sfuggi alla mia vista.
Forse te ne sei già andata, mi sono deciso troppo tardi e tu starai già uscendo.
Stavo controllando gli ingredienti dei carciofi marinati quando ti ho visto.
Controllavo che non ci fosse il peperoncino, perché a te non piace proprio il piccante, eh Pietro? Ci stavo sempre attenta e continuo a farlo in automatico, come una stupida.
Oggi però sei qui davvero, anche se ci ho messo qualche secondo a capire che quel tizio col ciuffo biondo non è solamente un tizio col ciuffo che ti somiglia, sei tu.
Oh Pietro, che aspetto brutto che hai!
Sei dimagrito e sembri invecchiato, nonostante la pettinatura da ragazzino.
Stai cercando qualcuno, si capisce da come ti guardi intorno che non sei lì per fare la spesa. Non hai preso nemmeno il carrello. Chi stai cercando? Sei qui con qualcuno e non riesci a trovarlo? Forse vi siete separati per cercare più velocemente quello che vi serve e adesso non riuscite a riunirvi. È una donna, Pietro?
Mi hai già dimenticata?
Questo pensiero mi fa malissimo e me ne vergogno, non dovrebbe proprio importarmi. Sono io che ti ho cacciato di casa, io che non tolleravo più il tuo atteggiamento, la tua cattiveria.
Mi hai fatta sentire abbandonata pur vivendo con me, sotto lo stesso tetto. Mi hai detto cose cattive, mi hai fatto sentire brutta e non amata. Indesiderata, come un ospite fastidioso. Hai affondato un coltello nel mio cuore quando mi hai parlato di figli in quel modo crudele.
No Pietro, non posso perdonarti, non voglio.
Spingo veloce il carrello e mi dirigo verso le casse. Infilo nelle buste le poche cose che ho preso e scappo via, senza fermarmi a chiacchierare con la cassiera. Lei rimane stupita e mi guarda con aria un po' preoccupata.
Ormai mi conosce, e di me sa tutto, dalla sua postazione di lavoro ha visto la mia vita andare in frantumi. Voglio andare a casa, ora, voglio preparare per me qualcosa di buono. Accendere un paio di candele profumate e mettere della musica, che suoni giusta per le mie corde in questo momento. C'è sempre una canzone che sembra scritta proprio per noi, una canzone che sembra capirci e che grida per noi il nostro dolore. Stasera la ascolterò. E la canterò, magari.
Questo Natale voglio regalarmi un po' di serenità, me lo devo, me lo merito.
“Buone feste, Pietro. Abbi cura di te”.
ovvero: Il colore della cenere
«La neve, mamma!».
Era agosto, un caldo agosto. Uno dei più caldi che riuscissi a ricordare.
Non avevo mai visto la neve. Neanche lei, perché nella nostra città non era mai caduta, e lei, mi aveva detto, non si era mai allontanata da lì. Forse non lo avrebbe mai fatto se non fosse stata costretta.
La sua manina indicava il vortice che dall’alto si posava con leggerezza sulla terra. Si distendeva in un tappeto d’argento dalla consistenza fugace. Se si fosse chinata a raccoglierla le fessure tra le sue dita avrebbero fatto cadere tutto. Non avrebbero lasciato che una tenue sfumatura: la sua pelle, allora, sarebbe sembrata grigia, di un grigio chiaro. Lo stesso colore della cenere. Del riflesso della luna sulla cenere.
La sua mano era davvero piccola. E anche lei era piccola. Così piccola per affrontare quel viaggio.
«È solo polvere, tesoro», le risposi con un filo di voce, alzando gli occhi al cielo.
La cenere scendeva fitta accompagnata dal vento. Un vento sordo, silenzioso. Innaturale. Come la città dopo le bombe. Le belle strade, ora coperte di macerie, erano diventate vuote. Tristi.
«Sono le stelle, vero? È la polvere delle stelle?».
Mentre tutto si copriva di grigio e di bianco, risplendendo per contrasto nella notte sempre scura, la città sembrava ancora più morta. Era la cenere ad accendere le tenebre. E i sogni della bambina che camminava vicino a me.
Osservando i detriti che brillavano come statue immortali sorrisi, perché in mezzo alla morte, alla morte delle persone e delle cose, quella bambina alta poco più di un metro era ancora in grado di sognare. E sognava forte, con orgoglio.
«Esprimi un desiderio», le dissi.
Mi prese la mano e se la portò sul cuore. La punta del naso iniziò a disegnare cerchi leggeri nell’aria, verso l’alto. Scorsi i suoi occhi chiusi e la parte centrale della bocca scossa da leggere vibrazioni. Piccoli movimenti. Inconfondibili. Era una preghiera, una preghiera silenziosa. Le parole si erano fermate sulle sue labbra ed erano morte prima di toccare l’aria. Nessuno le avrebbe ascoltate. Nessuno avrebbe potuto. La bambina, però, non lo sapeva. Per lei un desiderio era solo un desiderio: avrebbe tanto voluto che diventasse realtà.
Così a lei restava la speranza, mentre io vedevo soltanto le briciole dei palazzi, dei rifugi e dei sogni. Erano ridotti in polvere. E nonostante la loro lucentezza restavano cenere. Cenere e macerie. Spettri di cadaveri in decomposizione.
Non c’era più niente. Niente che mi tenesse davvero lì, in quella che per dieci anni era stata la mia casa.
«Ti mancherà questo posto?».
Lo chiese senza lasciare la mia mano, continuando a stringermi. E pensai che stesse sorreggendo tutto il mio dolore, il peso che mio malgrado portavo sulle spalle.
Mi voltai a guardarla e incrociai i suoi occhi. Mi parvero meno brillanti, più velati. Forse erano stanchi. O forse tristi.
Così piccola. Così infelice.
«Ho con me tutto quello che mi serve...».
Provai a sorridere per rassicurarla, ma ne uscì fuori una smorfia, perché mi sentivo anche io piccola e infelice. Perché anche io avevo paura: di non essere in grado di badare a lei, quella bambina che la madre mi aveva affidato prima di morire. Ci separavano solo quattro anni, e i ruoli che la guerra ci aveva affidato senza chiederci il permesso, ma l’avrei cresciuta. Le avrei fatto da madre. E lei mi avrebbe fatto sentire un po’ meno malferma, un po’ meno mortale. Un po’ meno sola.
Finii per non chiederle che desiderio avesse espresso, anche se i suoi occhi sembravano aspettare quella domanda. Non avevo voglia di parlare. Ero anche io stanca. Avevamo camminato tutta la notte e dovevamo trovare un nascondiglio per il giorno. Contrariamente a quanto si potesse pensare, non era la notte il momento più pericoloso: chi guardava dall’alto, di notte trovava il mondo celato dal buio.
La bambina infilò le mani nelle tasche, ma avevo notato che erano sempre più grigie: la cenere si era infilata sotto le unghie e nelle venature del palmo. Anche il piccolo anello che portava all’indice aveva mutato colore. Era stato il regalo di sua madre. Se l’era sfilato appena in tempo. Aveva trovato la forza di sorridere mentre lo faceva. Sorridere per l’ultima volta.
Ogni giorno mi sembrava più spenta e iniziai a capire che dentro stava bruciando. Che stava morendo. Di una di quelle morti atroci, che sembrano lontane quando non si è provato sulla pelle che cosa sia la guerra.
Neanche noi la conoscevamo prima di allora. Non così bene, almeno. A scuola i libri ne parlavano, ma pensavamo fosse una cosa stupida, una cosa superata. Chi avrebbe voluto la guerra? E perché?
No, non avrei creduto che potesse esistere ancora. Che al mondo ci fosse qualcuno così incosciente da riportare la morte in vita.
Era l’ultimo giorno di scuola il giorno in cui il mondo è finito, per i morti, ma anche per i sopravvissuti. C’era una festa, una grande festa, ed erano presenti molti genitori. Eravamo appena entrati in classe e avevamo appoggiato i nostri libri sopra il banco. Leggere, per noi, era un lusso.
Un libro, un libro di carta e cartone, con la fodera a colori, era un dono che ricevevamo una volta all’anno dai nostri insegnanti e dalle nostre famiglie. Dovevamo resistere alla tentazione di leggerlo tutto d’un fiato. Era necessario diluire l’attesa per mesi, e quando purtroppo le pagine erano esaurite, o le ultime erano strappate, cosa assai frequente nella nostra zona, ricominciavamo da principio la lettura, sottolineando appena con il lapis le parole che alla prima lettura avevamo pronunciato senza comprenderle fino in fondo. Un libro doveva durare un anno intero. Poi sarebbe stato requisito, ripulito e ridistribuito. E non c’era modo di sottrarsi alla confisca della carta: la carta avrebbe composto lettere, biglietti in codice. Sarebbe stata lo sfondo di mappe e di conti complicati. O sarebbe rimasta ancora la base di un libro, la sua casa, il suo letto, pur cambiando forma. Il suo contenuto sarebbe mutato, come gli occhi di chi lo avrebbe scorto.
Il libro che mi era stato consegnato, e che avevo appena appoggiato sul banco, aveva la copertina azzurra. Era il mio colore preferito e speravo fosse di buon auspicio. Avrei tanto desiderato leggere di terre lontane, diverse dalla mia. Vivevo in una città senza cuore, priva d’anima.
Per fortuna c’erano molte pagine di carta: annusai il loro odore, in cerca di quel ricordo che io non custodivo, ma che la maestra ci aveva tramandato.
Trovate il profumo della carta.
E io lo cercavo ogni giorno, nella speranza che prima o poi uscisse fuori dal libro usurato e non ancora restituito, senza sapere come fosse quell’odore, il profumo di un libro fresco di stampa, forse asettico, forse impersonale. Così quella mattina lo annusai.
Il libro dalla copertina azzurra non emanava che un vago profumo acido che mi ricordava quello di una cantina. Le sue pagine erano leggermente taglienti e disegnavano un merletto imperfetto. Anche le cuciture erano grossolane: sapevo di dover prestare attenzione a non perdere la carta, l’oro bianco e ruvido che custodiva un bene ancora più prezioso, stampato appena in nero.
Sentii un aereo passare vicino al nostro tetto. Tremarono i vetri, e le gambe della maestra. I suoi occhi preoccupati ci osservarono con fare interrogativo e tutto vibrò ancora più forte, mentre un tuono accompagnava le scosse. La nostra insegnante urlò di nasconderci sotto i banchi. Di non pensare ad altro che a nasconderci. E io, prima di farmi ancora più piccola e chinarmi sul pavimento, ricordo di aver stretto più forte il libro azzurro per salvarlo da tutta quella distruzione. Invece sarebbe stato lui a salvarmi, ma io non potevo saperlo. Sarebbe stata la sua mano a posarsi sul mio cuore.
Quando le finestre schizzarono via in mille frantumi pensai che fossero simili a coriandoli. Coriandoli dalle magiche sfumature. E quei pezzi, pezzi appuntiti, si scagliarono contro i nostri corpi e i nostri sogni, tagliando e trafiggendo la carne e le cose.
Avevo paura a uscire fuori: non ero pronta a vedere la morte intorno a me. C’era qualcuno ancora vivo: si lamentava, farfugliava parole che per me non avevano senso. Sì, là, tra i vetri e il sangue, stavano pregando, chiedendo perdono. Chiedevano perdono prima di morire, come se una morte così violenta non fosse sufficiente a cancellare ogni colpa. E io, anziché aiutarli nella loro inutile preghiera, strinsi più forte il libro azzurro e mi accorsi che si era rotto: la copertina era squarciata dal vetro, proprio all’altezza del mio petto. Se non l’avessi avuto con me, probabilmente sarei morta.
Nell’aria si sparse un odore diverso. Non aveva una fragranza precisa, ma quando entrava nelle narici, quando si depositava sulla pelle, sentivo bruciare. Non vedevo niente di strano, oltre i frantumi di vetro e i corpi a terra che perdevano la vita.
Anche i vestiti bruciavano, tutto era fuoco, anche senza fiamme, anche senza vento ad alimentarlo. E anche io ero come fuoco: bloccata a terra, con le braccia impotenti rivolte al cielo. Avrei voluto gridare, ma nella gola tutto si fermava e si strozzava, incapace di uscire. Così mi trascinai fuori dalla classe, verso il bagno. Mi spogliai, mi spogliai di tutto. Lasciai cadere vestiti e libro a terra, e iniziai a lavare via quel bruciore, mentre i lamenti, nel corridoio, nelle altre aule, si facevano più deboli e più disperati.
Non sapevo dove andare, né che cosa fare.
Era la guerra quella?
Perché noi, noi bambini?
Sarei dovuta tornare a casa? O l’avrei trovata distrutta, come le finestre della scuola, come il libro dalla copertina azzurra?
Sarei riuscita a sopravvivere a tutto quel dolore?
Fu allora che la sentii. Era la voce di una bambina che continuava a chiamare la madre. Seguii la voce fino all’atrio: la piccola era nascosta sotto il corpo della mamma. Tossivano entrambe, ma la donna era stremata, stanca di disperarsi.
Poi la donna mi vide. E qualcosa nei suoi occhi cambiò.
«Vieni», mi disse. La sua voce era ridotta a un filo.
Obbedii, come un automa.
Si alzò sulle braccia, liberando la bambina dalla morsa sicura che l’aveva salvata. Si tolse l’anello e lo mise al dito della figlia.
«È mia figlia...».
Un colpo di tosse le impedì di finire la frase.
«…te la affido».
E sorrise, mentre la bambina mi prendeva la mano. E capendo che la sostanza invisibile aveva colpito anche la piccola, corsi a lavarla come meglio potei.
Quando ripassammo attraverso l’atrio, nude, impaurite, ma vicine, la donna non si muoveva più. Non avevo fatto in tempo a chiederle come si chiamasse la bambina.
La luce, fuori, era diversa dal solito. Poggiavamo i nostri piedi su un tappeto di macerie, vetro e carne.
«Stai attenta a non tagliarti», le dissi.
Non sapevo dove andare, né se fossimo al sicuro. Il sole era ovattato da nuvole sottili. I frantumi di vetro, a terra, riflettevano la sua luminosità. E poi c’era quello strato grigio, che prima non avevo mai notato. Non avevo mai notato perché non c’era. Non c’era la cenere. Non quella cenere d’argento. Risplendeva più del sole e del vetro. Per capire da che parte andare mi tappai gli occhi con una mano. Ma tutte le vie erano cancellate. C’erano nuove strade, strade di detriti, che i nostri piedi non erano pronti a calpestare.
«Cos’è successo alla mia mamma?», mi chiese quando eravamo arrivate in cima a un cumulo di ferro, cemento e polvere d’argento.
Io non sapevo che risponderle. Perché eravamo sole, adesso. Sole in quel mondo. Avrei voluto la mia di madre. O anche la sua. Qualcuno che mi proteggesse e che badasse a me. Avevo voglia di piangere e di gridare, ma rimasi in silenzio.
«Sei la mia nuova mamma, ora? Dove andiamo, mamma?»
La sua mano strinse più forte la mia.
Un palazzo era sopravvissuto. Dopo settimane di cammino, quella mattina avevamo trovato quello scheletro ancora eretto. Era il primo che trovavamo quasi intatto.
«Aspettami qui, Amal».
Avevo scelto questo nome. A lei era piaciuto. E le calzava a pennello. Amal: speranza. Perché era lei la mia speranza.
La bambina si rannicchiò nella buca nascondendosi sotto la coperta grigia. Per la prima volta saremo state lontane alcune ore. E i rischi non erano pochi. Più di tutti mi preoccupava la possibilità di non ritrovare il suo nascondiglio: dovevo memorizzare bene i numeri dei passi, ma non avrei potuto prendere punti di riferimento precisi. Il sole non era affidabile. E poi c’era il vento. Il vento avrebbe potuto coprire l’entrata. Avrebbe, certo. Mi restava da sperare che non si alzasse. Disegnare una mappa sarebbe stato ancor più pericoloso: se ci fosse stato qualcuno, là, dentro o intorno al palazzo, e avesse avuto cattive intenzioni… Se mi avesse catturato e avesse trovato quel foglio… No, non potevo correre quel rischio. Per il bene della bambina.
Gli occhi di Amal erano spalancati e fissi su di me. Riuscivo a vederli, perché brillavano come la polvere. Come la cenere. Erano dello stesso colore, ormai. Di un grigio intenso.
Era entrato dentro di lei quel grigio. L’avrebbe uccisa? Non volevo pensarci.
«Non avere paura...», le dissi spingendole via una ciocca di capelli. Grigia. Anche la ciocca. E adesso, anche la mia mano.
Ero io ad avere paura. Amal riusciva a sentirlo.
«Canta, canta nella testa, Amal. Canta tutte le canzoni che ti ho insegnato. Se alla fine non sarò tornata, aspetta la notte e scappa».
Non volevo andarmene. Non avrei dovuto lasciarla lì. Lo sentivo.
«Mamma...».
«Sì?».
«Tornerai, vero?».
Avrei voluto dirle di sì, rassicurarla. Ma non potevo mentirle. Non più. Anche se era una bambina, anche se io ero una bambina. Ero stanca delle bugie, delle bugie che i grandi dicono ai bambini, o che i più piccoli si raccontano tra loro.
Le detti un bacio sulla testa e le scompigliai i capelli: adesso anche la mia bocca era appena coperta di grigio. Ormai la cenere era entrata ovunque. Difficilmente saremmo sopravvissute a lungo.
«Stai attenta, per favore, mamma».
Le strizzai un occhio e mi allontanai prima che facesse giorno. Non avrei potuto aspettare la sicurezza della notte, perché avevo bisogno di luce, di più luce. Di vedere. Di vedere, da lassù, se in quel deserto di cenere qualcun altro come noi era vivo e in cerca di aiuto. Qualcuno buono, non uno dei soldati. Vedere se c’era qualcosa, oltre la cenere: una città sopravvissuta, una città ricostruita.
Non c’era niente. Avrei dovuto immaginarlo. Solo polvere: immense distese di polvere grigia. Era tutto uguale. La terra era tutta morta. Almeno da lì. Qualche duna, qualche buca. Eravamo le uniche formiche del formicaio. Neanche i militari si facevano vedere. Non ce ne era traccia, neppure nel palazzo.
Non c’era traccia di vita, là dentro. Di carne, invece, ce ne era fin troppa.
L’appartamento in cui entrai era sulla via del ritorno, all’ultimo piano. Avevo trovato la porta accostata. Ero in cerca di cibo, di provviste.
Il primo corpo era nella sala, a terra, sul tappeto. Non c’erano tracce di sangue. Solo la posizione era innaturale. L’uomo era steso su un fianco. Le braccia sigillate sul petto e le gambe adagiate una sopra l’altra. Il suo viso era rivolto verso una porta bianca.
Il tempo, là dentro, sembrava aver smesso di correre. C’erano ancora le patatine su un tavolo basso, tra il divano e la televisione. Ne presi una: da quanto non ne mangiavo?
Sputai a terra il boccone: sapeva di cenere. Ormai la polvere aveva contaminato anche il cibo. Non mi avevano ucciso le bombe e, iniziai a temere, mi avrebbe fatto morire quella polvere. Se fosse stato così avrei prima dovuto mettere in salvo Amal.
Il resto delle patatine cadde di fianco all’uomo. Feci attenzione a non calpestare la carne e aprii la porta che conduceva in un’altra zona della casa.
Il corridoio interno era buio. Ero costretta a procedere a tastoni. Sulla destra trovai una maniglia fredda. La tirai giù e un po’ di sole filtrò da una persiana di legno leggermente aperta. La prima cosa che vidi fu un carillon: non girava, non suonava più. Poi vidi il cadavere sul letto. La ballerina era rimasta immobile, forse già da tempo, o forse nel momento esatto della prima esplosione. Il suo tulle era ancora bianco: era il primo oggetto ad aver conservato il suo candore su cui si fossero posati i miei occhi negli ultimi mesi.
La avvicinai al raggio di luce e sfiorai il suo vestito.
Tornai la bambina che ero, per un momento.
Quanto tempo era trascorso? Quanto ero rimasta nella cameretta a osservare il carillon e la bambina che ne era stata proprietaria? Aida, a giudicare dal nome scritto sulla parete sopra il letto. Colei che torna. Ma non sarebbe tornata. Non sarebbe tornato nessuno. Erano tutti morti. Soltanto morti.
Afferrai il carillon e lo misi nello zaino. Aida mi avrebbe perdonato, pensai. In fondo non era per me. Era un regalo. Spalancati verso il soffitto c’erano i suoi occhi. Incapaci di piangere. Incapaci di vedere. Occhi ciechi. Sarebbero rimasti così per sempre? Quel pensiero era insopportabile.
Di tanto in tanto sogno ancora quei grandi occhi. Spalancati. Sul niente. Sul buio. Un buio eterno. Allora, mi dico, immagino di dirle, continua a dormire, Aida.
Lo zaino adesso era pieno: provviste, qualche abito, il solito binocolo. Il regalo per Amal. Sarebbe stata felice. Avrei fatto di tutto per vederla sorridere. Per vederla sognare, ancora, come facevamo entrambe prima della grande pioggia di cenere.
Il vento aveva concesso una tregua. Si alzava soprattutto di notte. O quando stava per cambiare il tempo. Mentre mi avvicinavo alla buca sentivo che qualcosa non andava. La notte stava arrivando e non c’erano nemici intorno. Era un posto sicuro. Perché quel terrore?
«Amal?».
La chiamai sottovoce, quasi per non svegliarla.
«Amal? AMAL?!».
Girai intorno all’ingresso della buca e realizzai che era vuota.
Amal non c’era più.
La coperta grigia era rimasta a terra, tra la polvere e i disegni. Sì, Amal aveva raccolto uno stecco e disegnato. Aveva reso l’attesa meno pesante, ma non era bastato.
Solo allora notai delle impronte. Impronte di passi, passi di bambina e di qualcuno più grande, impossibile dire di quanto. Non sembravano lontani gli uni dagli altri: procedevano a distanza costante sulla cenere, almeno fino a dove riuscivo a vedere.
E mi misi a seguire le tracce, mentre il vento si alzava e quella notte, sì, faceva freddo. Minacciava di cadere altra polvere e dovevo fare in fretta, prima che le orme fossero cancellate. E con esse, la speranza di ritrovare Amal.
Cercai di capire, guardai dappertutto. Dopo un’ora di cammino le due file di impronte erano diventate una sola. I piedi erano quelli più grandi. Nessuna traccia di quelli di Amal.
Osservai meglio, con più attenzione: sembravano trascinarsi. Inciampare. Le impronte erano più profonde. Il solco, nella cenere, più marcato.
Non c’era traccia di sangue. Nessuna macchia rossa intorno a quelle orme.
Cosa era successo ad Amal? L’avevano presa in braccio?
Amal stava morendo.
Stavamo morendo. Perché la cenere continuava a entrare dalla pelle e dalle narici. La sentivo. Percorreva tutto il corpo scorrendo nelle vene. La polvere stava rendendo tutto grigio. Sì, era il grigio il colore della morte.
Ma Amal stava morendo un po’ di più. Non riusciva a camminare per troppo tempo. Faceva fatica anche a respirare. E allora doveva aprire la bocca, e respirare con quella. Incamerare più aria. La stessa aria avvelenata.
Mi lasciai cadere sulle ginocchia, alzando cenere. Il vento cominciava a mulinare. E sembrava chiamare il mio nome. Il nome che neppure ricordavo, perché da tempo nessuno lo pronunciava. Ma chiamava me, ne ero certa.
E allora, con le ultime forze, seguii il vento. Non sapevo se mi avrebbe condotto alla morte, ma se non fossi più riuscita a trovare Amal tutta la mia vita avrebbe perso importanza.
C’era della musica. Non era una voce. Erano note. E io stavo seguendo quel suono, quasi ipnotizzata. Sapevo che mi avrebbe portato da lei. Era una delle canzoni che le avevo insegnato da quando ero diventata sua madre, quella che cantavamo sempre, quando una delle due era stanca o triste. Ci faceva sentire meno sole, più unite.
Il vento l’aveva portata, leggera come un soffio, a chilometri di distanza. È incredibile quanto viaggi il suono, nella notte, nel buio, nel deserto grigio di cenere.
Raggiunsi la capanna, messa su con le macerie di mattoni e di ferro, alla periferia della città fantasma. Tutte le città, ormai, erano così. Tutte le città. E tutti noi. Spettri. Scheletri. Senza vita.
La musica, dentro, era davvero forte. Me ne accorsi prima di aprire la porta. Nella capanna c’era odore di chiuso. E di cenere. L’odore della cenere era ovunque.
Il giorno era vicino e nella stanza iniziava a filtrare la luce dell’alba.
Su un tavolo, di fronte a me, c’era una lenzuolo bianco. Gonfio.
Sotto c’era qualcuno, qualcuno di piccolo.
Ne alzai un margine e guardai sotto. La vidi.
Amal, con la sua bocca a cuore colorata di grigio. E la pelle, dura, fredda, anch’essa d’argento. E i capelli, i vestiti, tutto era così. Sotto una nuvola bianca, c’era il corpo, il cadavere grigio di Amal.
Prima di piangere portai lo zaino in avanti ed estrassi il carillon, quello che non avrei più potuto donarle. Lo lasciai lì, un’altra macchia candida vicino alla coperta. Lo lasciai aperto, illudendomi che potesse vederlo, ovunque fosse.
Dietro di me sentii dei passi.
E quando mi voltai, vidi uno come me. Un ragazzo, intendo. Appena poco più di un bambino. Aveva una sciarpa a coprirgli il naso e la bocca. I suoi capelli erano grigi.
«La conoscevi?», mi chiese.
«Chi sei?».
«Adham».
«Cosa le hai fatto?».
Senza accorgermene mi ritrovai a pochi passi da lui. Stavo urlando, piangendo. Sentivo che le vene della mia testa erano sul punto di esplodere.
Sì, un’esplosione di sangue e cenere.
«Mi dispiace. Non sono riuscito a salvarla...».
«Non ti credo».
«L’ho trovata nella buca, sola. Era quasi svenuta».
Era il senso di colpa quello che sentivo? Quella fitta che mi trapassava in due il centro del petto, leggermente a sinistra?
«Ha camminato per un po’, poi non ce l’ha più fatta. L’ho portata in braccio fino a qui».
Non volevo più ascoltarlo.
«Non ti credo».
«Quando si è svegliata mi ha chiesto se fossi il suo nuovo papà».
E dubitai, per un istante. Pensai che potesse essere sincero.
No, non poteva.
L’aveva fatta morire. E avrebbe ucciso anche me.
«Non ti credo».
Infilai la mano destra in tasca e impugnai il coltellino.
«Mi dispiace per quello che è successo...».
Ma i suoi occhi non piangevano. Erano freddi, di pietra. Grigi. Come la cenere.
«Ti prego, non farlo...».
Ma io avevo già deciso.
Lo colpii. Lo colpii finché non smise di muoversi. Di respirare.
Sono caduta nella cenere.
Ho tirato fuori il coltello.
Poi l’ho riposto.
Non sono riuscita a fare quello che dovevo.
La notte non è fredda. Stanotte non c’è neppure il vento.
Penso che ad Amal sarebbe piaciuta.
E allora mi alzo e continuo a camminare.
In questo deserto di polvere grigia.
Devi fare ciò che ti fa stare bene
La vita dentro una canzone
Ormai era diventato il mantra di un eco lontano. “Eppure era così vicino”. Una frase che portava sempre nel cuore e che teneva bene a mente. “Un ordine impartito”. Solo nel corso degli anni aveva compreso, dal timbro caldo e dall’ampiezza del tono della voce di sua madre, che si trattava di un ordine gradito, l’opposto dell’arido imperativo che gli imponeva ogni giorno suo padre. “Studia! Non sognare!” Sì: sognare, ascoltare una favola raccontata da suo padre e cantare una canzone erano nella lunga lista delle cose non contemplate nella sua educazione. Ordinato, diligente, preparato, elegante, in sintesi un concentrato di tutto ciò che prevedevano l’istruzione e il comportamento nell’alta società. “Devi fare ciò che ti fa stare bene”. Ogni volta chiedeva a sua madre: «“cosa” devo fare», senza dare un tono interrogativo alla frase perché in quella casa non si potevano porre domande. Tra quelle mura non potevano essere esposte questioni o idee: bisognava solo eseguire gli ordini, intonati con severità, oppure scritti, come se fossero legge. Lei rispondeva in maniera evasiva, ma lui aveva imparato a comprendere che, all’insaputa di suo padre, al contrario di quelle che erano le sue volontà, nello studio e nella vita avrebbe sempre potuto contare su di lei.
Come se fosse un rito, sfilò con calma il foglio consumato, ma pur sempre intatto, dal taschino posto sotto i documenti del portafoglio, quella che una volta era una semplice tasca dei pantaloni, corti e blu, che indossava assieme alla camicia bianca, per andare a scuola. “Tutte le mattine”. Anche a causa di quell’abbigliamento sempre uguale era stato denigrato e isolato da una parte dei suoi compagni di scuola: “non meritava l’amicizia di nessuno”, così diceva quella banda di bulletti, e lo mettevano nelle condizioni di provare vergogna per se stesso, una vergogna che aveva preso la forma dei pensieri di suo padre e dell’unica cosa che riusciva a provare suo padre in quella casa. “Indifferenza”.
Ricordava ancora l’ansia che aveva provato nel cercare un posto nascosto in cui leggere per la prima volta quel biglietto. Il tremore si era impossessato delle gracili gambe, le mani sudavano. E ricordava anche l’emozione di leggerlo all’oscuro di tutto. “E di tutti”. Era stato scritto su di un semplice foglio, che sua madre aveva estratto con cura da uno dei suoi quaderni, senza che suo padre se ne accorgesse, perché i quaderni dovevano essere integri e perfetti! Si chiese se anche lei scrivendolo avesse provato lo stesso tremore e la stessa contentezza.
Lo custodiva con molta attenzione. Quella frase l’aveva letta almeno un milione di volte e l’aveva trascritta ovunque potesse essere posta di fronte ai suoi occhi, nella sua vita quotidiana, così da fare riaffiorare quelle parole. Continuamente. Nel suo cuore. L’aveva scritta su ogni diario. Compariva su tutte le agende che lo avevano accompagnato in quegli anni, di studio e di lavoro. Con lettere nitide. Precise. Ordinate. Con una grafia ricercata. L’aveva salvata sullo screen saver del computer. L’aveva memorizzata come sfondo nel cellulare. E l’aveva racchiusa in una cornice grigia di grandi dimensioni, che teneva appesa alla parete della sua stanza, disposta perfettamente al centro, davanti al suo letto. In fine l’aveva affissa sullo specchio, di fronte al quale dedicava fin troppo tempo rispetto a quello necessario a radere quel po’ di barba che osava togliere dal viso. Un viso sempre adornato dal pizzetto nero, così come nera e crespa era la montagna di capelli che si portava appresso, da sempre, e per la quale suo padre non aveva mai trovato il tempo di portarlo dal barbiere. “Non gli dedicava mai il proprio tempo”. Un tempo che non era contemplato nella dimensione della famiglia, tanto suo padre era preso dal lavoro. Così non c’era tempo per rispondere alle sue domande, per giocare con lui, per aiutarlo a studiare. “Il tempo è denaro”, diceva, e non ne sprecava neanche per interagire con sua madre - terza protagonista di quell’atto - i cui unici compiti erano quelli di accudire la casa e il giardino, enorme, che si era voluto concedere lui. “Isolandola da tutto e da tutti”. Nell’accudire la casa rientravano anche lavare i vestiti e preparare i suoi piatti preferiti, mai alla stessa ora. Gli orari li comunicava lui di giorno in giorno perché la sua vita da imprenditore non gli concedeva di fare diversamente, diceva. Sua madre gli aveva confidato, solo molti anni più tardi, che considerava quella casa un lager.
Crescere lui non era semplicemente in fondo alle priorità di suo padre, in quella lista non c’era proprio; ciò nonostante doveva essere il primo nello studio e nello sport e per questo lo aveva iscritto ad atletica, senza ammettere repliche. Ma non si era mai degnato di presentarsi a nessuna delle sue gare, anche se il suo corpo sembrava una macchina nata per vincere. Al traguardo gli unici applausi che sentiva erano quelli di sua madre e degli spettatori. “Tutto serve”. L’unica arida risposta che dava suo padre, una volta venuto a conoscenza della vittoria era: “Hai fatto solo il tuo dovere”.
Per fortuna aveva quel foglio che gli ricordava, ogni volta che voleva, la presenza sicura di sua madre. Aveva passato i suoi anni a nasconderlo nel cuscino, sotto al materasso o dietro a un quadretto, appeso nella propria stanza, che conteneva una foto di suo padre e che lui non amava guardare. “Lì era al sicuro”. Lui non lo doveva trovare, non lo doveva vedere, non lo poteva leggere.
Il fruscio di quel foglio era musica per le sue orecchie. Lo avvicinò alle narici e inspirò, prima di rileggere quelle parole che gli placavano l’anima. Avrebbe voluto ritrovarvi anche il profumo di sua madre, ma suo padre le aveva sempre vietato di comprare fragranze e trucchi, inopportuni per una donna che doveva solo curarsi della casa e delle cose. Fece vibrare le corde vocali per scaldarle, ripetendo quella frase che amava tanto. “Siamo rimasti in venti calmi.” Poi socchiuse le labbra e iniziò a leggere:
Devi fare ciò che ti fa stare bene
anche quando ti dicono che non conviene
perché nel tuo cuore c’è soltanto il bene.
Devi camminare verso la via d’uscita
anche se fosse in salita
dovesse volerci tutta la vita.
Scegli la porta che vuoi varcare
ma non avere mai paura di volare
nel tuo cuore è già scritto dove devi arrivare.
Circondati di persone fidate
sono le uniche che possono essere amate
le uniche compagnie a poter essere considerate.
Stendi le ali e vola come un airone
il vento conosce già la direzione
e ti porterà dritto al tuo futuro senza esitazione.
Verrà il giorno in cui avverrà il cambiamento
lo vedrai dal luogo in cui ti avrà portato quel vento
e a quel punto capirai che è giunto il momento
sarà giunta l’ora di lasciarti andare
il tuo futuro non potrà più aspettare
prendi coraggio e fai ciò che devi fare.
Era una metrica imprecisa, piena di imperfezioni anche grammaticali, ma conteneva tutto quello che avrebbe voluto sentirsi dire.
Premette il foglio con il palmo aperto della mano verso il naso, con le sue dita grandi, quasi accartocciandolo, poi inspirò fino a dilatare i polmoni, portandoli al limiti, e rimase così per pochi secondi. Richiamò alla memoria il profumo della torta di mele appena sfornata, che tanto adorava aspettare seduto in cucina su quello sgabello così alto da non permettere ai suoi piedi di toccare per terra, rimasta impressa nei suoi pensieri, poi lo ripiegò con cura. Prese il portafoglio e lo infilò al suo posto, poi mise via anche quello. Fece incontrare le mani davanti a sé e allargò le dita posandovi le labbra. Ora capiva: quel giorno era arrivato. Indossò la tenuta da corsa e si diresse verso il campo sportivo dove si ritrovavano i lavoratori dell’azienda. Si dispose sulla riga di partenza. Poi contrasse i muscoli e fece leva sui legamenti, il corpo iniziò subito a rispondere alla loro contrazione, accanto a lui altri atleti correvano, ma era sempre stato quello più veloce, quello più forte, il più difficile da battere. Il primo della classe, il primo sul lavoro. “L’ultimo ad essere scelto dalle ragazze”. Fece un ultimo sforzo, poi un altro, mentre la sua mente giungeva al culmine del significato di quella strofa, miscelandosi alla frase sillabata che le ripeteva sempre sua madre quando tornava a casa frustrato per essere stato deriso, ancora una volta, a causa della sua perfezione, della sua impostazione, della sua compostezza. “Vuoi stare bene. Stare bene e ce la farai”. Quella frase sillabata prese ritmo con il suo cuore mentre il sangue gli pulsava nelle orecchie. Era solo davanti a tutti, solo come sempre e come sempre il primo. Fu allora che diede ordine ai suoi muscoli di rallentare mentre un’altra frase prendeva il sopravvento. “Voglio essere superato”. La contrazione sui muscoli si ridusse, gli arti continuarono a rallentare e mentre acquisiva la percezione del suo corpo, il sangue nelle sue orecchie rallentò anch’esso, pulsando con minore intensità. Fu allora che si accorse di essere stato superato e pensò che questo lo facesse “stare bene”. O almeno così gli sembrava. Chiuse gli occhi concentrandosi sui suoi organi di senso. Si accorse solo allora che le sue orecchie avevano un potere enorme. Un potere di cui non era consapevole, teso sempre verso l’obiettivo da raggiungere, l’ordine da rispettare, l’ostacolo da superare. Iniziò a percepire il vociare delle persone che si trovavano attorno a lui, il rumore del piede battuto sopra la gomma rossa che ricopriva la pista, il ringhio di chi stava forzando il proprio corpo per raggiungere più in fretta la meta. Tutti questi suoni e altrettanti rumori colpirono il suo udito, provocando lo stesso dolore di un muscolo indolenzito dalla colpa di non essere mai stato usato. Fu allora che si dedicò all’olfatto e si accorse che gli alberi di magnolie, che circondavano la pista, sovrastavano con il loro profumo il tanfo di sudore, oltre all’odore della terra e della gomma della pista. Le sue gambe rallentarono ancora, finché si accorse di essere stato superato e questo non lo faceva stare bene. Il pensiero andò a sua madre, dopo la morte di suo padre aveva iniziato a vivere: la camminata decisa e cadenzata, resa fluida dall’abito elegante e dalle scarpe all’ultima moda che finalmente si era potuta comprare, il viso truccato in modo leggero ma evidente, come qualche volta le vedeva fare di nascosto, davanti allo specchio, per ammirarsi solo pochi secondi subito prima di cancellare ogni prova. Ora erano gli altri che la ammiravano. “Lei aveva trovato ciò che la faceva stare bene”.
Lasciò il campo da atletica e mentre si dirigeva verso casa sfilò il cellulare dalla tasca e lo aprì sulla rubrica. La maggior parte dei numeri corrispondeva a colleghi di lavoro, persone prive di intelletto e di capacità, ma in grado di ferire con una sola parola detta dietro alle spalle, come un colpo di spada inferto per distruggere l’immagine dello sfortunato soggetto su cui avevano diretto la loro attenzione. Nella totalità delle volte si trattava di lui. Lui che era il responsabile di tutti loro, il direttore di tutti quei pigri succhia stipendi che infestavano l’azienda ricevuta in eredità da suo padre, un’eredità che gli pesava addosso come un macigno. Non avrebbe mai potuto rallentare sul lavoro come aveva fatto sulla pista di atletica, nessun neurone del suo cervello gli avrebbe mai e poi mai permesso di lasciare colare a picco l’azienda e lui con essa, ma qualcosa poteva fare. “Voleva fare”. Una bella ripulita allo staff e ai suoi capelli. Non avrebbe più permesso a nessuno di trattarlo come uno spauracchio, un ridicolo idiota di cui farsi beffa. Era capace. “Pensare a questo lo faceva stare bene”. Lo dimostrava il fatto che a venticinque anni aveva preso in mano le redini di quell’azienda e l’aveva fatta risorgere dalle macerie in cui era finita con suo padre, che, al contrario di lui, si era arreso alla propria incapacità e si era punito con un’arma. Anche lui si era armato, ma di buona volontà e con coraggio aveva messo a frutto la propria formazione e l’aveva trasformata in successo in omaggio a sua madre, che lo aveva sempre fatto stare bene. Così le aveva donato la dignità e l’indipendenza che non aveva mai ricevuto dal marito.
Nel proprio intervento di ristrutturazione aveva mantenuto tutto il personale dell’azienda, ma ora si era accorto che la metà di questo non lavorava e si assentava in orario di lavoro, a scapito dei colleghi che davano il doppio. Tutto questo sarebbe finito. Avrebbe dato una bella ripulita e al loro posto avrebbe assunto personale fresco e motivato, prima di tutti Giulia. L’aveva sempre guardata a distanza, lei che per laurearsi era stata costretta a lavorare tutte le sere poiché nella sua famiglia i soldi erano a malapena sufficienti a garantire il sostentamento. Lei che proveniva da una famiglia troppo povera per essere considerata nei colloqui di lavoro adatti al suo livello di studi. Lei che era guardata con la stessa supponenza con cui era sempre stato guardato anche lui. Si erano sempre osservati a distanza, come due prede che si studiano senza mai fare il primo passo. L’avrebbe assunta come braccio destro e le avrebbe chiesto di uscire con lui. “Anche questo lo faceva stare bene”.
Si diresse nuovamente al campo, come se nuova linfa avesse preso a circolare all’interno del proprio corpo, una linfa che forse faceva parte di lui da sempre, ma che non si era mai accorto di possedere. Arrivato alla pista si mise in linea accanto agli stessi atleti coi quali aveva gareggiato poco prima. Ora la chiave d’accesso del suo “stare bene” gli era nota e cara. La risposta non era il “cosa” ma il “come.” Partì all’unisono con i suoi compagni, guardandoli sghignazzare. Pochi minuti prima lo avevano battuto, erano convinti di essere più forti di lui? Contrasse i muscoli con decisione ma senza forzare, lasciando che l’odore delle magnolie penetrasse nelle sue narici, alle quali arrivavano anche altre fragranze di cui non conosceva le origini, né l’esistenza. Rimase affiancato agli altri. La linfa divenne improvvisamente fresca, come una doccia ristoratrice in un caldo giorno d’estate e allora affondò. Ricambiò il ghigno, superò il traguardo con disinvoltura e si voltò a braccia conserte a guardare i compagni ancora in arrivo. Fermo. In piedi. La loro andatura era scomposta e rabbiosa. “Scomposta, come la loro attività lavorativa, ma soprattutto scostante”. Non erano di nessuna utilità per l’azienda, lavoravano poco e male, mai in collaborazione con i colleghi, sempre in antitesi con lui. S'incamminò nuovamente verso casa. Fece una doccia e si recò dal barbiere. “Devi fare ciò che ti fa stare bene”. Guardò le ciocche cadere per terra formando una montagna. Il pavimento bianco improvvisamente era diventato nero, un nero che fino a pochi minuti prima invadeva la sua mente e oscurava i suoi pensieri. Pensò a come sarebbe stato sedersi su quella sedia di fianco a suo padre, mentre il suo volto emergeva in quello splendido taglio. “Questo mi fa stare bene”. Alzò gli occhi guardando nel vuoto, come se in quella dimensione potessero manifestarsi i suoi ricordi e scorrere sullo schermo come in un film. Un film che al cinema, sul grande schermo, lui non aveva mai visto. Si chiuse in se stesso giusto il tempo per ricomporre i pezzi della propria vita, ma solo per accorgersi che erano stati tenuti insieme da quelle parole. Scritte. Con cura. Su quel foglio. Fece il vuoto nella sua mente, ma il vuoto non c’era. C’era solo una parola che rimbombava, come un eco. “Devi”.
(Armonia in rosso)
Di fronte a lui era seduta una donna di mezz’età dall’aria affranta, forse per la giornata che si lasciava dietro le spalle, o forse per la serata che l’aspettava. Magari per entrambe. Il vagone della metro era quasi pieno. Sergio aveva trovato posto, non gli capitava spesso, e poteva osservare chi gli stava attorno senza preoccuparsi di restare in equilibrio o di impedire agli altri passeggeri di salirgli sui piedi. I suoi orari erano sempre gli stessi, e coincidevano con quelli di tanta altra gente che lavora dalle otto e mezza della mattina alle sei e mezza della sera. Solo quando andava in trasferta in qualche paese della provincia prendeva la macchina, che per tutta la settimana restava chiusa in garage. La tirava fuori il sabato per andare a fare la spesa in un supermercato distante da casa sua, che aveva prezzi più bassi rispetto agli altri. Con un solo stipendio e con la famiglia che s’allargava non poteva permettersi neanche la più piccola spesa superflua. Sua moglie era bloccata in casa nell’ultima fase della gravidanza per ordine del medico. Avevano sperato che potesse lavorare fino a due mesi prima del parto, ma le minacce di distacco della placenta, che si erano presentate alla tredicesima settimana, avevano interferito con i loro piani. Naisha, prima della pausa forzata, lavorava qualche ora la mattina, come segretaria, presso una cooperativa sociale. Era stato così che si erano conosciuti: lui era andato a ritirare un computer guasto e aveva trovato lei, che gli aveva spiegato con una dolcezza a cui non era abituato quali problemi avesse il proprio computer. Quando, dopo la riparazione, era arrivato il momento di riconsegnarlo, Pietro aveva insistito per andare di persona e ne aveva approfittato per offrirle un caffè al bar vicino alla cooperativa. Poi c’era stato un invito al cinema, e da lì era proseguito in modo del tutto naturale. Sua madre aveva fatto qualche obiezione all’inizio, troppe differenze culturali, ma alla fine anche lei aveva ceduto alla magia di quegli occhi neri, dentro i quali s’intuivano tutti i misteri della terra da cui proveniva la ragazza. Tutta un’altra cosa da quelle che le erano state presentate, in modo più o meno ufficiale, fino a quel momento.
Sergio era in ritardo di almeno due ore. Aveva telefonato a casa per avvertire, ma non sapeva di quanto tempo avrebbe avuto bisogno per portare a termine quello che stava facendo. Dipendeva da tutta una serie di fattori. Doveva aspettare e vedere come evolveva la situazione. Quando aveva staccato, alla solita ora, era sceso nel garage che si trovava sotto il palazzo, un complesso di uffici dove aveva sede anche la sua ditta, e dove erano parcheggiate tutte le auto degli impiegati e dei dirigenti. La sua intenzione era quella di affrontare il dottor Emili, il suo capo, in un faccia a faccia appartato, senza timore che qualcuno potesse sentirli. In ufficio aveva provato a spiegargli la propria situazione, ma era troppo sconvolto, le parole gli morivano in gola, tutto quello che era riuscito ad articolare erano concetti scollegati, il cui nesso era chiaro solo a lui: nessuno sarebbe riuscito a capirne il senso, figurarsi quell’uomo tutto compreso nel suo ruolo di selezionatore di scarti: questo sì, questo no, questo forse, vediamo. Il responsabile delle risorse umane. Forse il concetto che sua moglie fosse incinta l’aveva afferrato, quello Sergio era sicuro di averlo esposto in modo chiaro, ma, anche se l’aveva capito, aveva fatto finta di niente continuando a recitare la sequela inarrestabile di spiegazioni e di giustificazioni come una litania imparata a memoria: cifre, statistiche, bilancio, microeconomia, profitto. Il suo fiume di parole aveva tracimato, riversandosi con violenza brutale nella sua vita. E sbaragliandola. Ma adesso avrebbe potuto recuperare. Sapeva che Emili si sarebbe trattenuto qualche minuto di più in ufficio, usciva sempre dopo che tutti se ne erano andati. Si preparò ad aspettarlo, sperando nel frattempo di calmarsi e di riacquistare la lucidità necessaria per dire tutto quello che aveva in mente. Nel garage individuò subito la macchina dell’uomo, una Lexus nera, sempre tirata a lucido, arrogante come possono esserlo le auto che servono a far dimenticare la mediocrità di chi le guida. E che doveva essere costata quasi quanto la casa di cui lui e Naisha stavano pagando il mutuo. Si mise non lontano dall’auto, dietro un muretto, per non essere visto da nessuno: il garage s’era quasi svuotato, ma, oltre a quella di Emili, c’erano ancora diverse vetture parcheggiate in ordine sparso, in attesa di essere ritirate. Mentre aspettava, iniziarono a scorrergli nella testa le immagini al rallenty della scena di cui era stato, suo malgrado, protagonista un paio d’ore prima, e riprovò le stesse sensazioni, amplificate dalla consapevolezza, che si era rafforzata con lo scorrere dei minuti, che ci fosse ben poco da fare per uscire da quel dedalo inestricabile tracciato sulle sue paure.
Prima di allora non aveva mai notato quanto fosse sgradevole quella faccia. Lui lavorava a testa bassa, non aveva tempo per occuparsi d’altro. Ma quel giorno, durante il colloquio, quell’uomo era lì, a qualche centimetro da lui, a separarli la scrivania col piano di cristallo. Non erano mai stato così vicini. Emili era uno che si rintanava nel proprio ufficio e ne usciva solo per andare a pranzo e per tornare a casa. I contatti con i dipendenti erano tenuti dai responsabili di settore. Senza rendersene conto, Sergio si ritrovò a prendere consapevolezza dei tratti disarmonici, sproporzionati, del viso che gli stava di fronte. Non era solo l’aspetto esteriore: quello ormai cominciava ad apparigli come un guscio deforme e sgraziato dentro cui si adattava, seguendone in modo preciso i contorni, una massa duttile e malsana. Gli capitava di rado di considerare le caratteristiche fisiche delle persone, non gli interessavano, ma in quella situazione non riusciva a evitarlo. All’immagine di quell’uomo si sovrapponeva, in un gioco di trasparenze, quella di un suino, un maiale, come quelli che i suoi nonni in paese allevavano per tutto l’anno per poi far loro la festa a gennaio. Il testone dalla fronte stretta si allargava sulle guance fino alle mandibole, che erano la parte più larga del viso, quasi attaccate al collo largo e tozzo, corto, quasi inesistente. Gli occhi piccoli, con dentro due puntini neri che in quel momento erano fissi su di lui, ma che a tratti vagavano per la stanza alla ricerca di un oggetto qualsiasi su cui soffermarsi, da mettere a fuoco, come per permettere al portatore di quello sguardo sfuggente di riprendere lena, per finire un discorso che diventava sempre più penoso. Le parole filtravano tra le labbra sottili, la bocca larga sembrava un taglio, una ferita tra il naso e il mento. Nell’ascoltare quello che diceva, Sergio si sentiva montare dentro un’ondata di rabbia che cominciava a diventare difficile arginare. Lui non era un violento, non lo era mai stato. Ma di fronte a quella faccia imperturbabile nella sua sfrontatezza cominciava ad avvertire il desiderio di scuotere quell’uomo fino a fargli perdere quella sua aria da padreterno in overdose di onnipotenza. Avrebbe dato qualsiasi cosa per cancellare quel sorriso stereotipato, buono per tutte le stagioni e per ogni circostanza. Ma oltre a ribollire dentro non poteva permettersi altro: qualsiasi cosa avesse fatto avrebbe finito per ricadere anche sulla sua famiglia appena abbozzata. La concentrazione al minimo, sentiva solo a tratti quello che l’altro gli stava dicendo. Coglieva parole qua e là, ma il concetto era stato già espresso all’inizio, anche se lui ci aveva messo un po’ a rendersene conto. «… esubero… sei giovane … la crisi… referenze…». Se ne sbatteva grandemente delle sue referenze, dove diavolo lo trovava un altro lavoro, così su due piedi, e con la moglie incinta di sei mesi? Puntaccapo, si chiamava così il centro di vendita e riparazione dei computer dove prestava la sua opera, forse più qualificata di quanto non fosse richiesto. Aveva frequentato due anni di ingegneria informatica all’università e a lui quel lavoro piaceva: gli permetteva di mettere in pratica l’esperienza e le conoscenze acquisite. Non aveva mai finito gli studi perché, dopo la morte del padre, non se l’era sentita di gravare sulle spalle della madre, che ormai doveva vivere con la pensione di reversibilità e pensare anche a sua sorella minore. E quando aveva provato a cercarsi un lavoro part-time, aveva dovuto ammettere che i pochi soldi guadagnati non gli sarebbero bastati per tutte le spese e, se avesse lavorato di più, non avrebbe potuto dedicare allo studio il tempo necessario. Allora si era detto che avrebbe lavorato per un po’, messo da parte un po’ di soldi, per poi riprendere quando gli fosse stato possibile. Ma più il tempo passava, più quel proposito si allontanava. Ormai se ne rendeva conto anche lui, la laurea era destinata a rimanere uno dei tanti progetti naufragati strada facendo. Per la verità nella sua vita non ce ne erano stati molti, ma rinunciare a quello gli era bruciato più degli altri perché aveva tradito le aspettative di suo padre, che sognava di vedere in lui il primo dottore in famiglia. Puntaccapo, in quel momento quel nome manifestava un’ironia spietata. Lui non poteva mettere un punto, e non poteva andare a capo, perché non era più solo, sebbene non lo fosse mai stato, solo, come in quel momento. Era stato cacciato in quel labirinto e doveva percorrerlo senza appoggiarsi a nessuno.
Fu strappato a questi pensieri dal rumore metallico della pesante porta di ferro dell’interrato, che sbatteva richiudendosi. Doveva essere quella che portava agli ascensori e, nel deserto silenzioso del grande parcheggio sotterraneo, il rimbombo rimandò un’eco quasi sinistra. Qualcuno era entrato, se ne sentivano i passi veloci sopra il cemento. Sergio sbirciò dal suo angolo per vedere se si trattava di Emili, ma riconobbe nell’uomo che si avviava verso un’utilitaria uno degli impiegati della ditta, stacanovista o forse solo ritardatario. Si rimise in attesa, ormai non doveva mancare molto. Fece respiri profondi per allentare la tensione, doveva mantenersi calmo. Sentì il motore avviarsi e la macchina partire. Poi di nuovo silenzio, e allora ebbe l’impressione di sentire un rumore non lontano. Mise di nuovo la testa fuori dal proprio nascondiglio: Emili era vicino alla sua auto, a qualche passo da lui. Aveva appena aperto la portiera e si stava togliendo l’impermeabile prima di salire. Non poteva farselo sfuggire. Uscì di corsa da dietro il muro: «Dottor Emili, aspetti un secondo, la prego!», gridò. L’altro si voltò sorpreso e, nel riconoscerlo, assunse la stessa aria di sufficienza di due ore prima. «Ferranti, cosa c’è adesso? Ci siamo già detti tutto, non c’è nulla da aggiungere, mi dispiace.» «Ma mi lasci spiegare», quasi implorò Sergio. «Prima sono stato colto di sorpresa, non me l’aspettavo…» continuò. «Mi creda, la situazione è chiarissima, ma le ho anche spiegato le esigenze della ditta. Mi scusi, vado di fretta, ho gente a cena. Buonasera», e fece per salire. Sergio lo afferrò per un braccio: «Mi ascolti, me lo deve! Almeno questo, me lo deve!» «Ma che ca…! Ma è impazzito! Mi tolga subito le mani di dosso.» Sergio si controllava a fatica: le sistoli e le diastoli s’erano scatenate in una danza frenetica dentro il suo petto, il cuore si era come dilatato a occupare tutto lo spazio, le tempie pulsavano, le mani tremavano. Lui non mollava la presa, mentre Emili cercava di liberarsi: «Farabutto esaltato, lasciami in pace!», urlò il selettore di scarti. «Lasciami in pace? Brutto figlio di puttana! », sibilò Sergio, ormai fuori controllo, «a me la stai togliendo la pace! Mi stai togliendo tutto, grandissimo pezzo di merda! Lo capisci questo? Mi stai togliendo tutto!». Aveva iniziato a strattonarlo. Emili cercava di liberarsi per salire in macchina. Nei suoi occhi, che non avevano comunque perso l’arroganza ormai consolidata, era affiorata anche la paura. Si guardava attorno nella speranza di vedere arrivare qualcuno, ma c’erano solo loro due. «Ma va a farti fottere, buffone imbranato!», e fece un ultimo tentativo per liberare il braccio stretto nella morsa delle mani di Sergio, che a quel punto perse quel briciolo di autocontrollo che gli era rimasto e, afferrata la portiera, iniziò a sbatterla con forza contro l’uomo. Nel tentativo di entrare in macchina, Emili era rimasto con una gamba dentro e l’altra fuori, incastrato e destinato a subire i colpi senza possibilità di scampo. La pesante portiera si abbatteva su di lui con la violenza della rabbia repressa. Sergio non riusciva a fermarsi: «Infame barile di lardo, vuoi essere lasciato in pace, eh?», e continuava a colpire. «Hai gente a cena, vero? Adesso ti concio per le feste, e poi ti ci mando io dai tuoi preziosi ospiti!» I colpi diventavano sempre più violenti. A un certo punto Emili scivolò verso terra e, nella caduta, la sua testa si trovò nella traiettoria della portiera che si abbatteva su di lui per l’ennesima volta. Dalla tempia dell’uomo uscì un fiotto di sangue che in un attimo si diffuse su tutto il viso. Fu a quel punto che Sergio si fermò e, come paralizzato, fissò sconvolto l’altro, riverso sul pavimento di cemento del garage. Gli ci volle del tempo, lui non saprebbe dire quanto, per rendersi conto di quello che era successo: il suo incubo era diventato un incubo peggiore. Quando sentì sbattere la porta di ferro dalla parte degli ascensori, riuscì a scuotersi e, riacquistato un barlume di lucidità, si rese conto che doveva allontanarsi, e alla svelta. Cercando di restare nell’ombra si avviò verso una porta che stava dalla parte in cui si trovava lui e, attento a non fare rumore, l’accompagnò nel chiudersi e salì di corsa le scale che l’avrebbero portato fuori di lì. A casa.
Si era fatto due chilometri a piedi per arrivare alla stazione della metro: avrebbe potuto prendere il bus, come sempre, ma sentiva il bisogno di camminare, di scaricare il miscuglio di tensione, rabbia e paura. Ridiventare padrone di sé, almeno per quella sera. Doveva riuscire a dominare il terrore che gli era rimasto dentro per quanto era successo nel garage, non poteva portarlo a casa. Doveva anche tenersi dentro tutti gli interrogativi sulla sorte di Emili che gli si affollavano in testa: i giorni successivi sarebbero stati decisivi per il corso della sua vita futura. Poteva succedere tutto. O niente.
Quando era sceso dalla metro aveva percorso le poche centinaia di metri che lo separavano da casa sua quasi di corsa. Era già buio, in genere arrivava prima. Non vedeva l’ora di rientrare nella villetta a schiera nella prima periferia della città, dove aveva sognato di passare il resto della vita con Aisha e con i figli che sarebbero venuti. Quella sera più che mai aveva bisogno di un rifugio certo. Della presenza di sua moglie. Una donna coraggiosa: era partita dall’India settentrionale da sola per frequentare l’università in Italia. Quando si erano conosciuti era al terzo anno, e lavorava anche qualche ora nell’ufficio in cui si erano conosciuti. Col matrimonio e la gravidanza aveva rallentato, ma non rinunciato del tutto: aveva intenzione di riprendere appena possibile. Da dov’era Sergio cominciava a intravedere la luce del loro piccolo giardino: Aisha l’accendeva sempre, diceva che portava bene. E che nel suo paese c’era la festa della luce, e la divinità della ricchezza, in quel giorno, faceva visita nelle case dove ce n’era.
Era a due passi dal piccolo cancello della sua casa: si fermò un attimo per essere sicuro di riuscire a mantenere l’atteggiamento pacato che si era imposto. La finestra del salotto era aperta e ne usciva tanta luce: Aisha doveva aver acceso il lampadario centrale. Di solito accendeva solo le due lampade sulla credenza, mentre guardava la televisione dopo cena. Nell’avvicinarsi alla casa, giunse davanti alla finestra e vide che dentro c’era il tavolo apparecchiato. Sua moglie stava sistemando dolci e frutta sulla tovaglia rossa, come il suo sari. Era quello che aveva indossato quando si erano sposati: rosso, con ricami in varie tonalità di blu. Il rosso era il colore dell’abito da sposa nella parte del paese da cui lei veniva, era considerato il colore della purezza. Lo aveva cercato tanto in Italia, senza successo, e poi aveva chiesto alla sua famiglia di spedirgliene uno dall’India. Lui ne ricordava ancora la meraviglia quando aveva aperto il pacco. Lo aveva indossato solo un’altra volta dopo il matrimonio: in occasione del loro primo anniversario. E di colpo, con uno spasimo di consapevolezza, Sergio si rese conto che quel giorno era proprio il loro anniversario, il secondo, e lui, trascinato e stritolato nel tritasassi di quella giornata, lo aveva completamente dimenticato. Non riusciva a staccare gli occhi da quella scena, e l’armonia che sprigionava dai gesti distesi di sua moglie gli restituiva un po’ della fiducia che si era dissolta nella confusione, nella paura, nella rabbia, e nel senso di colpa, delle ore precedenti. Cercò le chiavi nella tasca dei pantaloni e si preparò a entrare in casa: aveva già fatto fin troppo tardi.
IL ROMANZO DIETRO AL QUADRO
di
Aneres T. Lone Wolfe
Depose con grazia la frutta e i dolci sull’alzata di vetro e ottone, quella che teneva con cura quasi volesse confortarla. La base era stata forgiata in metallo, mentre il piatto che la sovrastava, piccolo, sottile e privo di decorazioni, si ergeva dal tavolo su tre protuberanze. Davano l’impressione di non avere neanche la forza di reggere tutto quel peso. Si tenne improvvisamente a questa base cercando la stabilità necessaria alle sue gambe, ormai prive di vigore, poiché indebolite dal peso dei pensieri. Le mani erano tremanti, perché lavorare in quella casa era diventato difficile, ma soprattutto doloroso. “Molto doloroso”. Negli ultimi mesi tutta quella tensione e l’atmosfera che saturava come una cappa i suoi abitanti, l’avevano appesantita. “O forse la forza l’aveva abbandonata per altri motivi? Si trattava veramente di un evento esterno? Se non avesse fatto quella domanda, se non avesse chiesto dove si trovava la signora, sarebbe stato tutto diverso ora? Cosa era successo veramente? Che cosa aveva visto il Padrone? Nessuno gliene aveva mai parlato, e perché mai avrebbero dovuto farlo del resto?”. La testa della serva e il suo corpo erano rivolti ancora verso l’alzata, con una parvenza di serenità, ma l’espressione sul suo volto svelava la sofferenza che portava dentro, una sofferenza che non provava solo lei in quella casa. Marta fece roteare i biscotti che ormai non profumavano più come quando li aveva sfornati, o così le sembrava. Appena fatti erano dolci, fragranti e gustosi, croccanti fuori e morbidi dentro. “Quando si dice trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato”. Se avesse potuto cambiare quell’evento, se solo avesse taciuto o semplicemente non si fosse interessata, ora probabilmente le cose sarebbero state come allora: “il dessert perfetto”. Il cuore dei biscotti era fatto di cioccolato, una crema gustosa che usciva riversandosi nel piatto, un accessorio che ormai non faceva più parte di quel tavolo, diventato inutile e superfluo dal momento che il padrone tollerava ben poco di restare in quella stanza, e lo scarso appetito che aveva lo sedava in pochi minuti. In quello stesso tempo, trangugiava del vino rosso direttamente dalla bottiglia, tanto più che, ormai, anche i bicchieri erano diventati superflui. “Troppe cose erano diventate superflue”. Si chiese se lo fosse diventata anche la sua presenza in quella casa. Ora i suoi Padroni avevano perso ogni senso del gusto, del piacere, della realtà. Amava preparare quei dolcetti, la mattina presto, adorava levarsi alle prime ore dell’alba e lasciare quella scia profumata in tutta la casa, che guidava i Padroni appena svegli verso la cucina per assaggiarne qualcuno appena sfornato. Un rito ormai perso.. Ora vivevano in due stanze separate in cui passavano la maggior parte della loro giornata. Osservò il cibo disperso all’altro capo del tavolo, di questo se ne sarebbe occupata solo più tardi, aveva ancora tempo. Sarebbe stato un altro atto, un’altra scena che si ripeteva come in un flashback, sempre la solita. La Padrona sarebbe arrivata per prima, il Padrone sarebbe tornato solo più tardi, quando lei fosse uscita. Entrambi avevano ancora una volta bevuto la stessa quantità di vino, lei quello bianco dolce che le dava tanto conforto, lui quello rosso vivo. Rosso come le pareti che aveva voluto dipingere e come la tovaglia che aveva voluto far colorare. Rosso cupo, come il suo umore, come i suoi pensieri, rosso come la pazzia che lo ottenebrava, rosso. Un rosso vivo su cui sua moglie aveva voluto dipingere dei fiori blu a ricordargli quegli elementi della natura che tanto amava lavorare, mentre prendeva la misura del terreno che aveva voluto comprare e sistemare per lei. Non voleva che dimenticasse quanto fosse bravo nel curare il giardino, nel curare il terreno, nel curare la loro vita. “Il loro amore”. Invece ora era tutto abbandonato. “Fuori da quella finestra si vedeva la devastazione in quel cupo giorno di marzo”. Solo degli scarni rametti di mimosa, disposti con cura nella seconda alzata, ricordavano l’arrivo della primavera. Invece in casa c’era l’inverno, così come nei loro pensieri. L’erba era alta, incolta, a coprire oltre la metà dell’altezza di quegli arbusti, o forse erano alberi, ormai non lo ricordava più. Erano piegati dal vento, da molto tempo non venivano più curati. “Troppo tempo”. In mezzo ad essi, dei fiori di campo selvatici facevano capolino, azzurri e gialli. Quelli azzurri erano i preferiti della padrona e suo marito lo sapeva, per questo lei aveva dipinto quei vasi di fiori ovunque sulle pareti, nella tovaglia, se avesse potuto li avrebbe dipinti anche dentro al suo cuore. Lui, forse per qualche forma di autocontrollo che possedeva ancora, o di legame con il passato, aveva dipinto delle erbacce tra i suoi fiori preferiti, alte e grandi a sovrastarle, ma senza coprirle, né cancellarle, anche se le aveva dipinte di nero. Ma la Padrona le aveva colorate di blu, con cura. A volte il Padrone l’aveva notata mentre lo faceva, entrando in quella stanza, ma era uscito in fretta sbattendo la porta, pur sempre senza stringere i pugni. Fuori il cielo era triste e non dava speranze, gonfio e scuro prometteva pioggia. La sedia della padrona era come sempre appoggiata al muro, lì doveva restare, fuori dalla vista di suo marito. Il padrone invece aveva la sedia appoggiata al tavolo, di lato, tre passi più avanti alla sua, controllati ogni giorno, ogni ora con le sue stesse gambe. Entrambe le sedie erano dirette verso un’unica direzione, mai si doveva incrociare lo sguardo fra loro: due binari paralleli, due strade distinte che non si incontrano mai, a guardare verso una direzione dove non c’era nient’altro se non il vuoto. Ma non il vuoto dei pensieri, e questo si capiva dal cibo disperso sul tavolo con rabbia, in ogni direzione. Sempre la stessa scena, sempre lo stesso flashback. Il Padrone era uscito in fretta, di corsa, con un turbine di pensieri e la tempesta in atto all’interno della mente. Con i capelli arruffati e i pugni stretti come se dovesse stringere tutto e al tempo stesso volesse liberarsi di qualcosa, o come se, improvvisamente, aprendoli, avesse potuto fare sparire tutto nel vuoto di quell’odioso passato. La Signora lo aveva seguito cauta, in silenzio, a testa bassa, lo stesso sguardo rivolto verso il tavolo che teneva lei ora in questo momento, una testa che non poteva mai più alzare, nessuno poteva più incrociare il suo sguardo. Lei lo alzò, solo per un attimo, rivolgendolo fuori per osservare quella costruzione lontana, ma non poi così lontana. Una costruzione che il Padrone voleva fare demolire, crollare, anzi che avrebbe voluto distruggere con le proprie mani, pezzo dopo pezzo, mattone dopo mattone. Una costruzione dove aveva visto quello che non avrebbe dovuto vedere. Stranamente questa volta rientrò per primo e si avvicinò alla finestra, poi strinse nuovamente i pugni. Guardò il tavolo arrabbiato poi uscì di nuovo. Il rosso era anche nei suoi occhi ormai iniettati di sangue, un rosso che non sarebbe più scomparso, il rosso di un uomo che non avrebbe mai dimenticato. Un rosso misto di rabbia odio e dolore, un rosso che aveva dipinto lui stesso ma di cui non era l’autore né l’artefice. La Signora rientrò e si sedette in quella sedia appoggiata al muro, osservando la serva che continuava a sistemare i pasticcini su quello stesso piatto, con la testa ancora china, in silenzio. Doveva essere un dessert perfetto e invece continuò a fissare il vuoto astratto in cui non c’era niente, o meglio nel quale c’era qualcosa, una tensione nell’aria che non poteva dimenticare. Gli eventi non potevano più cambiare le cose, anche se avevano comunque e inevitabilmente cambiato il presente e il futuro; ormai ogni giorno sarebbe rimasto per sempre così: “il dessert imperfetto”.
Il Gran Premio
Buona sera a tutti, sono Erin Minà, e sono in collegamento dalla bolla gravitazionale sopra al nuovo circuito continentale dove tra poco avrà inizio la gara conclusiva del Gran Premio di Formula Mix.
Lo chiamano “il Cavo”: dieci virgola sette chilometri di condotto laser, che si snodano attraverso tre diversi livelli della città, in pieno centro, collegando insieme i centodiciotto anelli di proiezione per un diametro di sei metri. Il Governatore, che è venuto questa sera a inaugurare il circuito, è adesso in collegamento dalla tribuna mobile. Buonasera Governatore!
«Guarda papà, ci siamo anche noi!»
«Dove?»
«Lì, sul proiettore.»
«Non vedo niente, e a te scappa la pipì.»
«Non è vero.»
«Allora perché continui a muovere le gambe?»
«Sono emozionato.»
Lui sorride, e a me scappa la pipì. Mi scappa da morire, ma non voglio perdermi la partenza. Papà ha trovato questi posti nella tribuna mobile da dove si vede l’imbocco del Cavo. Ci sono un sacco di poliziotti, perché in tribuna ci sono anche il Governatore e Lady-Va, che ha cantato prima della gara. Adesso i piloti stanno salendo sui gusci. Da qui vedo Bonam che si collega alla capsula. L’argento della carrozzeria è bellissimo.
«Ma come si mettono questi cosi?»
Mio padre non ha mai usato un proiettore oculare.
«Le placche vanno appoggiate sulle tempie, non sulle orecchie! Vedi? Basta appoggiarle e si configurano da sole. Così mentre vedi la gara puoi seguire anche le telecamere e la cronaca negli occhiali. Funziona?»
Papà sorride. Le novità lo spaventano, ma poi si diverte.
«Si, funziona benissimo, lo vedi anche tu il tubo?»
«Si chiama “cavo” papà, è la l’involucro energetico che delimita la pista.»
Ecco che il primo anello si è acceso. Vedete il cavo che si snoda come un drago luminoso verso la costa e di nuovo in alto, fino all’Eliopoli. I piloti sono pronti. Il campione mondiale Richard Bonam partirà in posizione centrale, fiancheggiato dal compagno di scuderia e da Keita Meini, il nuovo prodigio delle scuderie Ferrari, che in sole otto gare è riuscita a insidiare la vetta della classifica. Governatore, com’è la vista dalla tribuna?
É bellissima Erin, la tribuna scorre dai box fino alla prima torsione, potremo seguire i piloti per cinquecento metri ad ogni giro. Sono davvero orgoglioso!
«Hai sentito il Governatore Papà?»
«Non molto, la gente è impazzita, non si sente niente!»
Ecco che i gusci si sollevano, è sempre una grande emozione vedere l’impronta luminosa sul piazzale, prima che entrino nel cavo. Poi l’ultimo tratto della barriera laser chiuderà il circuito.
Semaforo rosso. Sono pronti, i gusci sono tutti in assetto da carica, con il muso leggermente rivolto verso il basso. Verde, sono partiti! Trentotto gusci che dal piazzale devono imbucarsi nei sei metri di diametro del cavo. Ecco i primi contatti, Ave Loi sembra aver perso il controllo, con la vettura di traverso impedisce agli altri di passare. Che sia una strategia?
Lo è di sicuro, Bonam e Keita sono già schizzati avanti, mentre tutti gli altri si ammassano nell’ingorgo. La Ferrari è più veloce, Keita lo sta raggiungendo. Ormai è sopra al guscio di Bonam, se entrerà per prima nel cavo sarà difficile per lui recuperare.
É incredibile, Keita ha preso quota per superare Bonam dall’alto, ma la sua scheggia d’argento si impenna e con lo scudo posteriore tocca il guscio di Keita. Si è schiantata sull’imbocco del circuito. L’impatto ha tranciato la cabina e il corpo della pilota è sbalzato in mezzo al piazzale. Ma un attimo, dov’è la testa?
I droni inquadrano il piazzale, poi catturano il primo piano della testa che rotola verso la tribuna, proprio davanti a noi. Il casco è integro e il processo si è attivato automaticamente. Bonam è in testa.
Tutti gli altri lo seguono a distanza e la tribuna slitta lungo il cavo. Guardo il campione saettare fino al primo tornante. Quando la tribuna torna al punto di partenza Keita esce dall’incubatore. La vedo nel proiettore oculare, indica Bonam in uno schermo, si infila il casco e sale sul secondo guscio. In tribuna fischiano, ma lungo le strade tutti fanno il tifo per lei. Esce dai box proprio sotto alla tribuna e si getta all’inseguimento.
In un bunker ricavato dalla sala macchine in disuso quattro uomini seguono la gara attraverso un vecchio monitor olografico.
Due sono di fronte al monitor, gli altri sono appoggiati alla porta blindata.
L’ologramma mostra Bonam in difficoltà, chiuso nella morsa di tre veicoli avversari.
Il tizio con la cicatrice in faccia si volta verso il più grosso di quelli alla porta.
«Ravi, hai mai avuto un ricaricabile in famiglia?»
«Certo che no.»
«E quanta voglia hai di fotterne un po’?»
«Che domande fai Dooger? Quella che hai tu.»
«Allora sarà tutto più semplice. Sembra che Bonam non ne abbia più per molto e Settimo è pronto.»
L’uomo accanto a Dooger è concentrato. Non commenta, bisbiglia qualcosa che i due alla porta non possono sentire, poi si volta e si sposta in un antro della sala attrezzato come una camera operatoria. Ci sono due letti metallici con anelli di sicurezza per polsi e caviglie, uno grosso macchinario a forma di sigaro e un quadro comandi da cui pendono una serie di cavi che terminano in un casco integrale. Un tubo lucente che scende dal soffitto punta la sua bocca nera su uno dei letti.
Ravi resta immobile alla porta.
«Che succede Ravi? Hai la faccia di uno che sta cacando un riccio.»
«Nulla… Solo che non sono preparato per questo, hai seguito tu l'addestramento...»
«Settimo ha il diritto di scegliere il suo esecutore, e ha scelto te. Dovresti essere contento. Tutto il Blocco Insorgente saprà del vostro contributo. Oggi comincia la nuova era, quindi togliti le spine e cominciamo.»
In pochi giri Keita ha raggiunto Bonam, grazie al supporto di tutte le scuderie. Sono tutti contro il campione. Adesso sono testa testa e su ogni rettilineo il guscio Ferrari mostra la sua potenza recuperando frazioni di secondo.
Settimo si stende sul letto. Gli occhi aperti, fissi sulla bocca del cannone che lo sovrasta. Muove le labbra in una muta preghiera, o forse una è filastrocca per bambini.
Amal attiva il quadro comandi.
Settimo si mette seduto. Dalle feritoie aperte alla base del cranio ben rasato escono due rivoli di siero che colano lungo il collo fin dentro la muta.
Attenzione, c’è un mezzo fermo sulla dorsale nord, il sistema di trascinamento non è riuscito a rimuoverlo e Bonam sta puntando dritto verso la carcassa. Attira Keita in trappola. Eccolo che vira a pochi metri dall’impatto mentre l’inseguitrice finisce dritta contro le lamiere. L’esplosione raggiunge il guscio di Bonam.
Le traiettorie impazzite del veicolo in fiamme illuminano il bunker a intermittenza. Bonam è riverso a terra. Il sistema di trascinamento si attiva per espellere dal cavo tutto il materiale distrutto, piloti compresi. Dai box partono le vetture di recupero dei corpi.
«Abbiamo due minuti e trentasette secondi prima che Bonam sia ricaricato nel nuovo corpo. Ho già sincronizzato il nostro loader con quello ai box, sono pronto a dirottarlo. Forza Ravi, tocca a te.»
Ravi continua a fissare il monitor olografico. Sulla console c’è un modulo per la comunicazione bidirezionale.
«Cosa aspetti?»
Dooger lo sorprende alle spalle, lo fissa per qualche secondo, poi lo strattona fino al lettino e gli punta una criolama sotto la scapola sinistra.
«Mettiti al lavoro senza fare scherzi»
«Vacci piano Dooger! Sto solo cercando il coraggio necessario per ridurre un amico in poltiglia.»
«Più soffre e più siamo sicuri che funzioni. È addestrato per questo.»
Settimo rivolge lo sguardo a Ravi. «Fallo, abbiamo poco tempo.»
Poi riprende il suo mantra silenzioso. Ravi gli infila le sonde di ritenzione neurale nel cranio. Uno schizzo di siero lo centra in un occhio. Si pulisce con la mano mentre il flusso cremisi anima i cavi. Settimo indossa il casco e si adagia sul letto. Amal controlla il quadro comandi e dà il via libera. Ravi guarda Dooger, accenna un sorriso e abbassa la leva del loader.
Il ronzio iniziale diventa un boato sordo. La bocca del cannone preme sul torace di Settimo. Il suo strazio sta producendo buoni risultati, a giudicare dall’espressione soddisfatta di Dooger. Ravi deve usare entrambe le mani per impedire che il casco si sfili a causa delle convulsioni. La luce cremisi diventa rosso intenso.
«Dirottato!» esclama Amal.
Un fascio di luce rossa fluisce dai macchinari verso il monitor. Ha raggiunto la copia del ritentore nei box di Bonam. Dooger è soddisfatto.
«Qualcosa non va ai box, perché Bonam non si è ancora riattivato?»
Mio papà ha ragione. Keita è già tornata in pista mentre Bonam non si vede… ma ora finalmente le telecamere inquadrano l’incubatore.
C’è stato un problema tecnico ma adesso tutto sembra risolto. Vedete che il nuovo corpo del campione viene riscaldato. Apre gli occhi e si guarda intorno. Il ritardo deve averlo disorientato. Niente saluti questa volta, evidentemente Bonam è concentrato e non concede un secondo alle telecamere. Deve recuperare terreno. Collega il casco e parte.
Questo nuovo tracciato ha macinato un bel numero di vittime Governatore, ne abbiamo già viste dodici e la gara non è ancora finita.
Si Erin, è un successo senza precedenti.
Con buona pace per i costi delle scuderie.
Sono certo che le scuderie saranno ben ripagate. Non sente la folla in delirio? Questo è esattamente quello che i nostri cittadini vogliono.
Avete sentito il Governatore dalla tribuna, torniamo in pista!
«Eccolo papà, può ancora farcela.»
«Certo che può farcela, è il campione.»
Papà mi abbraccia, mi scoppia la vescica e sono preoccupato. Keita è in vantaggio e Bonam non sembra per niente in forma. Qualcosa nel reload non ha funzionato, questo giro è almeno due secondi più lento del precedente. La tribuna si blocca e torna verso il punto di partenza. Perdo di vista Bonam per qualche secondo e quando ricompare nel proiettore non capisco cosa stia facendo. Sembra che si sia fermato.
Il guscio è in panne ma dai box non è arrivato alcun messaggio. Il team non riesce a comunicare con il pilota. Forse la connessione di Bonam è difettosa. Ma cosa fa? Si è lanciato in senso contrario, finirà per schiantarsi sugli altri piloti.
Nel bunker Dooger ha ricominciato a seguire la gara dal monitor. Ravi aiuta Amal a portare il grosso sigaro in assetto operativo. L’apparecchio ha un rilevatore di frequenze con il quale Amal imposta la direzione e l’angolo di gittata dell’impulso. Indossa un paio di cuffie e controlla di nuovo la mira poi mette un piede sulla pedana alla base della macchina.
«Ce l’ho! Ho ingaggiato il generatore davanti alla tribuna. Che faccio Dooger?»
Dooger osserva sul monitor la traiettoria dell’attentatore.
«Ancora un attimo. L’impulso del jammer durerà per pochi secondi, dobbiamo aspettare che Settimo si avvicini al bersaglio.»
Solleva un dito, poi lo abbassa. «Spara!»
Amal sposta tutto il suo peso sulla pedana. La raffica dei colpi che partono dal jammer si abbassa progressivamente fino a sparire all’udito, restano le vibrazioni delle pareti che entrano in risonanza. L’onda si propaga fuori dal bunker e intercetta il primo anello della pista, quello che genera il tratto iniziale del Cavo. La barriera laser si spegne nel tratto di fronte alla tribuna.
«Cos’è questo tremore papà?»
Non è il rumore a spaventarmi, ma l’espressione di papà. Lui era nelle truppe coloniali e ora sta zitto e fa la faccia di quando racconta della guerra. Sento ancora qualcosa dal proiettore.
Sembra che il tratto iniziale del cavo sia stato disattivato, se Bonam lo raggiungesse a questa velocità…
Papà mi stacca le placche, mi afferra una mano e mi trascina tra le sedie. Cerca di passare tra gli spettatori ma tutte le file sono bloccate. Le grida sovrastano il rombo di Bonam, che schiva due gusci e corre verso di noi. Quelli della sicurezza ci spintonano cercando di creare una via d’uscita per il Governatore. Mio padre mi stringe con un braccio e mi spinge in basso, dietro alle sedie della fila davanti a noi. Vedo Bonam dalla fessura tra una sedia e l’altra. Il suo guscio è appena partito con il massimo dell’energia. Perché lo fa?
Chiudo gli occhi.
Amal abbraccia il sigaro per mantenere premuto il piede sulla pedana, Dooger è davanti al monitor che pregusta la carneficina. Nessuno presta attenzione a Ravi che scivola alle spalle di Dooger, gli sfila la criolama e lo sorprende. Il taglio netto della carotide non genera schizzi. Il sangue rimane fermo, come intrappolato, e quando il cuore smette di pompare sgorga come una colata di lava appiccicosa. Amal è concentrato sul jammer e non si accorge di niente. Ravi gli afferra la testa e gli spezza il collo, poi lo solleva dalla pedana e il jammer si spegne. Le pareti smettono di vibrare, il rumore di fondo cessa con un ultimo sussulto. Si volta verso il monitor per controllare se ha fatto in tempo a onorare il suo compito di agente governativo. Pochi secondi di tregua e dei colpi alla porta blindata lo avvertono che non è ancora finita.
Sento il soffio di una lama e poi il boato del pubblico. Non riesco a vedere niente. Trovo in terra un proiettore oculare e me lo metto.
... Salvi! Il cavo è stato riattivato appena in tempo.
Sul proiettore scorre a ripetizione la ripresa del guscio argento di Bonam che viene segato in due dalla parete laser che si riattiva appena in tempo. Quando gli spettatori si disperdono vedo il corpo del mio idolo tagliato a metà.
Ancora non sappiamo bene cosa sia successo ma sembra che il corpo di Bonam sia stato occupato da un terrorista. I tecnici dicono che non è possibile, ma staremo a vedere. Se Bonam si riattiverà in modo corretto nel prossimo reload magari potrà raccontarci cosa è successo. Mi chiedo, è possibile che la sua coscienza sia sopravvissuta a una latenza così lunga?
Un commando ha raggiunto il bunker con il corpo di Bonam, quello vero, devastato dall’incidente.
«Aprite, la traccia vitale di questo stronzo non è ancora svanita!»
Ravi si ferma con la mano sulla porta blindata. Se Bonam fosse ancora collegato al casco e crepasse adesso potrebbe riattivare il processo di reload. Apre la porta blindata per lasciar entrare la lettiga. L’uomo che la spinge fa appena in tempo ad accorgersi dei corpi dei compagni a terra, sente il tonfo della porta blindata che si richiude alle sua spalle, e la criolama di Ravi lo trafigge.
Due minuti dopo Richard Bonam apre gli occhi e mette a fuoco i tubi che dal soffitto scendono nel suo naso, nella bocca e in qualche altra parte del corpo. Non riesce a muovere la testa, solo gli occhi ruotano per vedere la stanza. Nonostante le droghe il dolore è insopportabile.
Un uomo che sta armeggiando con l’apparecchiatura attorno al lettino si muove scavalcando i corpi abbandonati sul pavimento.
«Ma guarda chi si è svegliato, il nostro Campione del Mondo!»
L’uomo si avvicina al letto di Bonam e gli sorride.
«Molto piacere, mi chiamo Ravi Madal, e sono un agente governativo infiltrato in questa cellula di cialtroni.»
Bonam socchiude gli occhi poi li riapre, per un attimo crede di essere salvo.
«Non puoi parlare, ma non ce n’è bisogno, io so tutto di te Richard, ti seguo da quando avevi il corpo originale. Mi spiace di non potermi fermare a farti compagnia ma vedi, restano pochi secondi per attivare il processo con il quale prenderò il controllo del tuo corpo.»
Ravi si allontana per sedersi sul letto e con un colpo secco si pianta le sonde di ritenzione neurale nel collo.
«Non so se dopo molti reload la percezione del dolore sia attenuata come dicono, ma ti assicuro che non sei messo molto bene. Ho dovuto tenerti in vita, capisci? Ma non ti preoccupare, appena mi sarà possibile tornerò qui per darti sollievo.»
Con una mano stringe il bordo del letto e con l’altra abbassa la leva del loader. Il processo si attiva e la bocca del cannone scende a schiacciargli il torace.
Ai box è sceso il silenzio. Tutti i droni si sono spostati verso la tribuna dove il Governatore rilascia dichiarazioni sull’efficienza dei sistemi di sicurezza. Un tecnico è rimasto a sorvegliare l’apparecchiatura dell’incubatore. Milioni di investimenti andati in fumo in pochi secondi.
Si accende una spia, poi una seconda. Il primo abbattitore si scalda e il nuovo corpo di Bonam, già vestito di tuta, apre gli occhi. Il tecnico cerca di contattare la squadra ma la porta si è già aperta.
Il nuovo corpo di Richard Bonam si guarda le mani. Le apre e le chiude due volte, poi si rivolge al tecnico, sorride e allunga la mano. Il tecnico la stringe.
«Richard, sei tu?»
«È stato terribile, ma adesso è tutto finito.»
Il campione del mondo esce dall’incubatore e si ferma davanti ai box, aspetta che i droni si accorgano di lui. Sente le grida della folla. Sorride alla telecamera più vicina e solleva la mano per salutare il pubblico più lontano.
«Visto papà? Ė tornato!»
«Si, è andato tutto bene per fortuna.»
Bonam si sta avvicinando, devo stringergli la mano!
«Remì?»
«Sì papà?»
«Hai i pantaloni bagnati.»
Se c’è una cosa che non sopporto al mondo - una su tutte - è la doccia fredda alla fine di un allenamento. Con quello che paghiamo di quota mensile vuoi che non si possano permettere un convertitore molecolare decente? Anche se fosse, se adesso non funziona, che attivino l’impianto geotermico, mioddio. Saranno antiquati, ma il loro lavoro l’hanno sempre fatto. Invece niente, docce fredde e tanti saluti. È che sono dei pezzi di merda, nient’altro, dei pigri e menefreghisti di merda, perché tanto la gente viene qui anche se in giro è pieno di CPV migliori. Da quando il Responsabile di Area ha messo il Sigillo, questo Centro Polisportivo Virtuale sembra diventato la Mecca: vengono tutti qui, anche se le docce sono fredde e i ledwall hanno una risoluzione da Terza Guerra Mondiale. A un certo punto, oggi, sembrava di giocare con una palla da pallavolo. Ha voglia poi a urlare, l’allenatore, e a dire che siamo delle fighette e che non dobbiamo trovare scuse perché una volta si giocava su campi da basket veri, con palloni veri, e quando si prendeva una pallonata su un dito bene che andava il dito si gonfiava per una settimana. Anche il nonno di mio nonno, quando era ragazzo, giocava a calcio con palloni veri - erano nostalgici - e quando andava male, e il dito o la caviglia, anziché gonfiarsi e basta si rompevano, glieli bloccavano per un mese con una miscela di garza e gesso, ma parliamo di preistoria, che discorsi sono? E suo nipote, mio nonno, andava a caccia in 3D con la mascherina per la realtà virtuale, e allora? Oggi, per fortuna, ci sono skinpad e ledwall sferici che hanno mandato in pensione sia il 3D, sia le mascherine, ma se non vanno bene, se non sono di qualità, non è questione di fighette o di uomini duri, ma è questione di simulare una partita di basket con un pallone che ogni tanto si trasforma in una palla da pallavolo, ed è uno schifo. Punto. È questione di imprenditori che lucrano sull’attività sportiva dei ragazzini. Non certo sulla nostra, perché noi abbiamo la forza e il coraggio di lamentarci, ma i più piccoli si abituano a tutto e fra qualche anno sarà normale allenarsi con palloni che all’improvviso cambiano forma, colore, e destinazione, con docce fredde alla fine dell’allenamento, con vaporizzatori che anziché aromatizzare cuoio e parquet aromatizzano un campo d’erba medica in alta quota. Lo dico piano, perché non ho voglia di beccarmi un’altra denuncia da sovversivo dopo la faccenda del tridimessaggio che ho condiviso insieme a Drip, ma questa cosa del green è sfuggita di mano a tanti. Vorrei vedere, poi, se questo CPV se lo merita davvero il Sigillo. Dicono che le certificazioni siano accessibili a chiunque ne faccia richiesta, ma per registrarsi al Portale Governativo occorre una laurea in lettere e un corso di orientering digitale ché ci sono talmente tante parole da leggere (ho contato più di sette righe, fitte come le pagine di un vecchio libro di carta) e istruzioni e rimandi a link lenti e obsoleti, da farti passare la voglia, altro che disponibili a tutti.
Secondo Drip qualcuno ci mangia sopra, qualche pezzo grosso, proprio come succedeva prima della Guerra Indolore. Drip è un anarchico totale. Non crede affatto al nuovo Governo ed è convinto che la Guerra Indolore sia stata una farsa e che la decimazione della popolazione mondiale sia stata pilotata. “Dobbiamo ribellarci a questo Sistema, non lo capisci? Sarà mica un caso che adesso si vada tutti d’accordo? Possibile che nessun delinquente abbia votato per i vincitori?”
Non ha tutti i torti, ma se mettessimo in dubbio la legittimità delle elezioni come si spiegherebbe che tutta la popolazione mondiale, o quanto meno i nove decimi che la mattina dopo non si sono svegliati, abbiano preso la pillola collegata al proprio candidato? Nella preistoria, quando Trump e il koreano giocavano ai pistoleri sulla pelle della gente, era impensabile che un giorno i governi di tutti i Paesi del Mondo si mettessero d’accordo per un’elezione globale, anche se quella elezione, con lo sterminio dei perdenti, avesse risolto il problema del sovrappopolamento e allo stesso tempo avesse garantito nuova e prosperosa vita ai sopravvissuti; eppure la Guerra Indolore si è tenuta e la gente la pillola l’ha ingoiata. “Il tuo scetticismo è già una prova che nessuno ha manipolato le cose - gli dico - perché altrimenti uno come te sarebbe finito tra quelli che il giorno dopo non si sono risvegliati!”. Ma non mi sta a sentire e continua a inneggiare alla rivoluzione, come se i quaranta giorni di esclusione dalla rete per avere condiviso quel tridimessaggio, che sbugiardava un Sigillo apposto a un ricovero per anziani, non gli fossero bastati. A me sono bastati, eccome, ma tornando al Sigillo apposto a questo CPV devo ammettere che la penso come Drip, anche se nessuno lo dovrà mai sapere.
Prima di uscire dal Centro passo a dare un’occhiata alla sezione delle virtual-bike. Qui i monitor sembrano migliori - almeno questi che danno sul corridoio, in favore dei guardoni - e lo skin scanner funziona a meraviglia. Ogni volta che ci penso sono tentato di pagare l’upgrade dell’abbonamento e sbloccare il filtro dell’intimo, ma duecento crediti per vedere tette a penzoloni e chiappe sotto sforzo, per quanto questi corsi siano pieni di fighe, mi sembrano ancora una follia. E poi ci sono sempre quelle che se ne fregano delle regole e l’intimo schermato non lo indossano, e così mi godo lo spettacolo completo senza pagare. Brave ragazze, siete la salvezza della mia masturbazione, anche se venire a fare bicicletta virtuale in pausa pranzo e vestirsi tirate apposta per farsi spogliare dagli skin scanner, e addirittura non indossare intimo schermato, è davvero da depravati, ma siate benedette, amiche mie, e se un giorno non sapeste dove passare la notte sappiate che ho un mio modulo personale e lì dentro sarete sempre le benvenute. Potrei farvi vedere la Ghirlesca, per esempio, uno dei pochi esemplari di bicicletta ancora esistente sulla faccia della terra. Se vi dicessi quanto l’ho pagata all’asta online mi dareste del matto, ma sono un nostalgico: mio nonno - sì, sempre quello che andava ancora a caccia con la mascherina per la realtà virtuale - da bambino ne aveva avuta una e i suoi racconti sulle sensazioni che provava, il vento vero sulla faccia, le asperità del terreno, la catena che scricchiolava, le ruote che alla lunga perdevano la centratura e iniziavano a ondeggiare, mi hanno fatto innamorare di questo reperto. Una bella parte del modulo è occupato da quella bicicletta, ma un po’ di spazio per noi lo rimedio, non vi preoccupate.
Fuori dal CPV c’è il solito clima perfetto. Il telefono lenticolare mi fa intravedere i livelli di qualità dell’aria e segnala semaforo verde su tutti i fronti: Ozono a 14, Biossido di Azoto a 1,7, Biossido di Zolfo a 1, Monossido di Carbonio a 47, PM10 a 1,1, PM2,5 a 0,9. Le aiuole sono ben rasate, il cielo è azzurro, il sole splende, il fruscio degli “alberi del vento” - retaggio vintage di cui il Responsabile di Area va molto fiero - è l’unica distorsione in questo paesaggio apparentemente perfetto. La mia floatingboard è sospesa a pochi centimetri da terra, dove l’avevo lasciata. È l’unica, tutti gli altri avventori del CPV non si fidano e le portano dentro, negli armadietti, ma mai uno che si sia preso una denuncia. Se lo facessi io, o se lo facesse Drip, sono sicuro che ci prenderemmo subito un’ammenda di sette crediti per diffusione di sfiducia e malcontento. Va be’, poco cambia, finché ho questo modello antiquato a fluttuazione a trenta centimetri da terra non credo che venga in mente a qualcuno di portarlo via. Non che io pensi che ci siano malviventi in circolazione, sia chiaro, che magari qui fuori hanno piazzato dei recettori del pensiero; dico solo per dire.
Drip ha l’ultima versione, la W12, una figata pazzesca: fluttua a due metri da terra e non è più grande di un’impronta di scarpe misura 47. Costa milleottocento crediti, una follia. Io non potrei permettermela neanche se per tre mesi lavorassi un’ora tutte le sere e tutte le quattro ore nei fine settimana, ma suo padre ha chiuso un appalto con la Macro Area 25 per lo spurgo dei convertitori molecolari e non ho idea di quanto incassi ogni anno. Immagino che sia una cifra spropositata. Drip non è un frequentatore di questo CPV, che io sappia non lo è di nessun Centro Polisportivo Virtuale in genere, ma se mai venisse qua non lascerebbe di certo la sua floatingboard W12 incustodita nel parcheggio esterno, con la differenza che, rispetto a tutti gli altri che portano abusivamente le floating negli armadietti, anche lui, come me, sarebbe subito beccato dai droni governativi.
Arrivato a casa vedo lampeggiare il nome del mio amico tra me e il portone, do’ un colpo di testa verso sinistra e rispondo al lenticolare. “Ciao vecchio – esordisce, prima che io possa sentire il rumore di due gocce di Ipradim vaporizzate – hai idea di cosa ci sia da fare per domani a scuola?”
Gli chiedo se nell’Ipradim ci abbia messo anche qualche goccia di Nivomax200 perché mi sembra che sia giocato il cervello: “Drip, credi davvero che io possa averne idea? Ho loggato il registro e ho lasciato che sia la rete ad assolvere ai miei doveri scolastici, come sempre”.
“Cos’è che hai sciolto in rete, vecchio?”
“Assolto, Drip, non sciolto. Lascia stare, ho copiato, ok? Cosa mi dovevi chiedere? Non ci credo che mi hai chiamato per i compiti”.
“Si, vabbè, non solo per quello…”.
“Sei solo a casa anche oggi?”
“Sì vecchio, e non c’è niente da mangiare, lo sai com’è fatta mia madre”.
“Vieni da me, non c’è problema. Questa mattina, prima di uscire, ho visto che la soia è arrivata a maturazione e ci devono essere anche delle fave di tonca e del seitan olandese”.
“Come cazzo fate a coltivare quella roba, vecchio? Sarà che mia madre non ci ha neanche mai provato e continua a spendere barche di crediti per comprare due filetti di pesce, che neanche mi piace”.
“Non siete una famiglia normale Drip, con quello che spendete a ogni pasto noi ci mangiamo per un anno intero”.
“In effetti sono dei ladri, vecchio, non si possono pagare tutti quei crediti per un etto di carne o due filetti di pesce, cazzo”.
“Ma tu hai idea di quanto costi allevare dei pesci in condizioni del tutto naturali, e aspettare che terminino il loro ciclo vitale, prima di poterli uccidere per farne cibo? E allevare un bue? Hai mai visto quanto è grosso un bue?”
“Perché non mettiamo su un allevamento, vecchio? Faremmo una montagna di crediti”.
“Perché ci vogliono generazioni prima di poter monetizzare anche uno solo di quegli animali, e nel frattempo cosa facciamo? Ci sarà un motivo per cui i maiali girano solo tra ricchi sfondati, no? La frase “Un maiale è per sempre” non è solo una pubblicità che riflette l’amore di chi lo regala, ma anche la vita di quel fottuto suino, Drip, ché muori prima tu davanti alle tue console, tempestato di skinpad sessuali, che quelli, all’aria aperta, serviti e riveriti. E non credo che a te ti potrei macellare”.
“Ho capito, va, continuiamo a restare schiavi del Sistema. Di’ a tua madre di preparare qualcosa anche per me, che arrivo”.
Drip è un caro amico, ma a forza di svapare sostanze strane credo davvero che si sia giocato il cervello. Mettere su un allevamento di animali. Come gli può saltare in mente?
Finiamo di cenare e Drip si mette a fare un pippone a mia madre. “Signora Caselli lei è davvero il prototipo della donna ideale, credo che nessuna sia in grado di gestire la casa e il giardino alimentare pensile come lei. Se mio padre avesse avuto la fortuna di incontrarla prima che lei avesse preso marito, anziché incontrare quella negata di madre!”. Pippone che la signora Caselli, mia madre, assorbe come una spugna di mare. Facciamo ancora due chiacchiere, ma prima che mia madre si monti la testa e si metta a raccontare tutti i segreti della casalinga perfetta ce ne andiamo in stanza, ognuno a casa propria, davanti alle console, per finire di discutere tra noi mentre scongiuriamo l’ennesima invasione di alieni.
La mattina dopo, la sveglia mi richiama a quella che ci è dato considerare realtà. Col dubbio in testa che alzarsi tutti i giorni alle otto e trenta, per farsi tre ore di scuola, non sia umano, butto giù il mio bicchiere di balanced breakfast e riprendo il mio ruolo in quello che certamente è il gioco virtuale di una qualche forma di vita superiore. Per strada è tutto perfetto. Per ogni macchina che fluttua in una direzione ce n’è una che fluttua nella direzione opposta. Il sole del mattino le avrà già ricaricate per l’intera giornata, qualsiasi sia il loro tragitto, e guardarle scorrere ha lo stesso effetto di arare un piccolo giardino zen da scrivania, quelli con la sabbia dentro e il rastrellino di legno, talmente sono armoniche e silenziose. Tallone e Ragno, i nostri vicini di casa omosessuali, passeggiano con le loro carrozzine uguali. Da quando hanno ottenuto le gemelline, la loro prima missione si è completata e i ventimila crediti che si sono ritrovati in conto li hanno resi ancora più felici. Ma un conto sono i vicini, un altro sono le piccole, che prima o poi cresceranno. Voglio vedere se saranno grate ai padri quando dovranno iniziare a fare a metà di ogni pagnotta. Per fortuna il mio, di padre, se n’è andato di casa poco dopo che sono nato, così mia madre non ha dovuto pensare a sfornarmi una sorella per ristabilire l’equilibrio familiare. Ventimila crediti fanno comodo a chiunque, la politica di bilanciamento della popolazione del Nuovo Governo è generosa ed efficace, ma ringrazio la sorte che sia riconosciuta come perfetta anche la famiglia di due persone, perché condividere la mia vita con una sorella non rientra davvero nelle mie aspettative.
Fuori dalla scuola trovo Drip e Medusa, come ogni mattina. Lui è avvolto nella solita nuvola di vapore, lei è bella da fare paura. Drip il problema della sorella non l’ha avuto, suo padre tira su talmente tanti crediti col lavoro, da non avere bisogno dei ventimila del programma. Medusa, invece, è figlia singola per contestazione: ai suoi genitori ventimila crediti servirebbero come l’aria che si respira, intonsa e pulita, ma si sono rifiutati di piegarsi alla logica del Governo, il figlio maschio non l’hanno concepito, e dopo di lei hanno chiuso bottega. Non dico che non facciano sesso, non sono i tipi, ma hanno deciso di non sbattere al mondo un’altra creatura, e per questo li stimo tantissimo, oltre che per avere generato Medusa.
“Arrivare due minuti prima, per una volta, no eh?” mi rimprovera Medusa con quelle labbra morbide e sensuali. Potrebbe anche darmi del tecnologicamente disadattato, che provocherebbe comunque la mia eccitazione.
“Ragazzi, la vita è talmente perfetta che due minuti di ritardo sono l’errore necessario a renderla reale. Vogliamo combatterlo questo Sistema, o ci dobbiamo sempre conformare come il resto dei sopravvissuti?”
“Lucio, tu sei la personificazione del ragazzo modello, l’anticristo della ribellione, sei il ragazzo del futuro, l’unica volta che hai alzato la testa ti sei beccato una denuncina da sette crediti ed è bastata a rimetterti in riga. Lo sai bene che la tolleranza dei ritardi è di due minuti e mezzo e che i tuoi due minuti non fanno impressione a nessuno, non fare il fico”.
“Drip, ma vaffanculo”
Esaurito il ciclo dei saluti entriamo in classe e ci apprestiamo ad affrontare la nostra lunga mattinata di studio.
Un pomeriggio in cui non ho allenamento, Medusa mi manda un messaggio per chiedermi se ho voglia di andare con lei a fare un giro fino al lago. Dice che ha trovato in rete qualcosa di speciale e che lo vuole condividere con me, perché saprei apprezzare. È un po’ lontano, il lago, ma l’idea mi alletta. Prima di risponderle controllo se lo scooter è carico, ché non possiamo andare fino laggiù con le floatingboard. Segna 90%, anche se gli accumulatori stanno battendo gli ultimi colpi dovremmo riuscire ad andare e tornare senza problemi, per cui le rispondo dicendo che per me si può fare. Non presto attenzione alla storia della sorpresa perché, a differenza mia, Medusa in rete non acquista mai nulla per cui al massimo avrà trovato un articolo curioso, o una foto particolare, forse che riguarda Drip, o forse qualche altro amico comune, ma dubito, in ogni caso, che possa riguardare me e che mi debba preoccupare.
Quando la passo a prendere la trovo già pronta sotto casa, con una borsa termica a tracolla. Evito di chiederle anticipazioni e rimando l’effetto wow a quando saremo arrivati al lago.
Lungo il tragitto vedo sfilare alberi su entrambi i lati del percorso, in numero e specie uguale, tanti e tali da una parte, altrettanti e tali dall’altro. Lo scooter fluttua mantenendo un ottimo equilibrio nonostante gli anni e gli acciacchi, e nonostante la borsa frigo di Medusa che pesa solo da una parte. Fino adesso ho glissato sia sul contenuto di quella borsa, sia sulla sorpresa, che inizio a pensare coincidano, ma spero che Medusa, appena arriveremo, sciolga ogni riserva. Invece così non è.
“Devi avere ancora un attimo di pazienza”, dice quando le chiedo spiegazioni “prendiamo una barca, ti va di remare?”
C’è un noleggio di piccole imbarcazioni a remi: un credito all’ora, quattro crediti per tutta la giornata. “Chi prenderebbe mai una barca a remi per tutta la giornata?” chiedo a voce alta. L’ho fatto sovrappensiero, senza rivolgermi a nessuno, ma Medusa mi risponde: “Il lago è talmente vasto, che se qualcuno volesse anche solo attraversalo, da una sponda all’altra, non credo che basterebbe una giornata”.
“Accidenti, ci si può anche perdere allora”
“Perdere non credo”
“Già, i droni governativi vedrebbero tutto e arriverebbero in soccorso”
Medusa non replica, e si avvia verso il noleggio di imbarcazioni. Sono tutte in fila a pelo d’acqua, lungo cinque moli che si estendono per venti metri da riva verso il centro del lago. Neanche a dirlo, da una parte e dall’altra di ogni molo c’è lo stesso esatto numero di imbarcazioni. Mi chiedo cosa accadrà quando noi ne prenderemo una, come verrà ristabilito l’equilibrio perfetto? Striscio la tessera nel lettore e sblocco la prescelta. Non c’è bisogno di stabilire adesso quanto tempo terremo lo scafo, l’addebito verrà calcolato in automatico quando lo riporteremo indietro.
Salgo per primo, mi faccio passare la borsa frigo e poi aiuto Medusa a salire.
Mentre remo in maniera goffa e sgraziata, accorgendomi da subito che è tutta un’altra cosa rispetto ai vogatori virtuali, Medusa, seduta da vanti a me sulla base dello scafo, schiena inarcata e mani appoggiate all’indietro, mi guarda con i suoi occhi neri, ma soprattutto con le sue tette strepitose, che non riesce a nascondere sotto gli ampi maglioni. Parliamo di Drip, della scuola, parliamo anche della notizia che in questi giorni sta circolando in rete: in alcune Aree del Mondo è permesso controllare geneticamente, oltre al sesso dei nascituri, anche altri fattori come gusti, tendenze sessuali, predisposizione verso materie umanitarie o scientifiche, e ci confrontiamo sull’opportunità di portare questa innovazione anche all’interno della nostra Area. Ok, è Medusa a parlare e ad esprimere la propria opinione su questa cosa, definendola l’ennesima follia del Nuovo Mondo, perché a me in realtà non frega niente. Io remo e annuisco, e continuo a perdermi nell’ondeggiare delle sue tette. Quando perdiamo di vista la riva dalla quale siamo partiti, Medusa smette di parlare e fissa il vuoto per qualche secondo. Intuisco che stia controllando qualcosa sul telefono lenticolare. Vedo le sue pupille muoversi nel vuoto. Non posso immaginare cosa stia imputando, o cercando, attraverso le proprie sinapsi, ma dopo pochi secondi torna a guardare me e finalmente mi dice che ci possiamo fermare.
“Qui? Nel mezzo del nulla? A me va bene, ma perché non potevamo fermarci prima?”
“Perché abbiamo raggiunto la zona cieca. In questo punto i droni governativi non arrivano, sono a corto raggio e tutte le basi di decollo più vicine lasciano scoperta la stessa piccola zona, questa zona, per un raggio di una ventina di metri e basta, quindi butta giù l’ancora e stai bene attento a che non ci spostiamo da questo punto”.
“E tu come fai a saperlo?”
“Lucio, sui blog sovversivi si trova di tutto. Nella nostra Area ci sono tre zone cieche e questa è una, la più vicina”.
“Mah, sarà vero? E perché siamo venuti qui?”
“Per la sorpresa. Tu sei un nostalgico, non è vero? Con la bicicletta che tieni appesa nel tuo modulo e tutte le storie che racconti sui tuoi antenati, ti piace il vintage. In rete, oltre alla mappa delle zone cieche, ho trovato queste due chicche…” e apre la borsa termica per tirare fuori una bottiglia di Pampero, un liquore, esattamente un rhum, che si trovava in libera circolazione prima della Guerra Indolore, e una bottiglietta di Coca Cola da mezzo litro, di plastica.
“Ma tu sei fuori!” grido soffocando la mia voce per paura che i droni ci possano sentire. “Liquore e plastica, se ci vedono ci tolgono trentamila crediti a testa. Mettili subito via!”
“Tranquillo, dove siamo adesso non ci può vedere nessuno. Hai mai sentito parlare di Coca e Rhum? Dicono che sia una combo perfetta. Non è forse il Governo a dire che si deve puntare sempre alla perfezione?”
“Santoddio Medusa, sì, ma il liquore è bandito, e la plastica… la plastica è un derivato del petrolio, ti rendi conto? La cosa più lontana dalla biodegradabilità che ci fosse nel Vecchio Mondo. L’abbiamo anche studiato a scuola, no? Il petrolio, l’oro nero, le guerre. Medusa, a due come noi non basta una vita per accumulare trentamila crediti, questa sarebbe una sorpresa?”
“Stai tranquillo, ti ho detto che siamo in una zona cieca. E poi la sorpresa non era solo questa”
“Oh cielo, altro ancora?”
“Che fifone che sei Lucio, mi stai facendo pentire della mia idea”
“Quale sarebbe questa idea?”
“Brindare a Rhum e Cola, come facevano una volta, prima che il Mondo fosse inquadrato e reso equilibrato e perfetto, e fare sesso con te, ma se credi che i droni ci possano vedere…”
Quindici minuti dopo, io e Medusa siamo sdraiati sul fondo della barca a remi, pelle contro pelle, parte di me dentro parte di lei, mentre la bottiglia di plastica, vuota, galleggia a filo d’acqua e va a disperdersi su qualche sponda del lago, dove impiegherà tra i cento e mille anni prima di degradare ed essere completamente smaltita.
Polvere - Giovanna Maccari
Scritto da Jona EditorePolvere. La vedo tra i fascicoli che giacciono sulla scrivania. La vedo danzare nella luce mentre ne sfilo uno dalla pila. Era rimasto lì sepolto, tra un rinvio a giudizio e l’altro. Non conviene intentare una causa, specie in Italia, in cui i tempi della giustizia sono tanto lunghi, se non vi si ha un reale interesse economico. Le questioni di principio vanno affrontate altrove, affidate al confessionale di una chiesa, rimesse all’ascolto creativo di uno psicanalista, risolte, nella migliore delle ipotesi, con una lunga discussione e un invito a cena. In ogni caso la violenza non serve, può solo peggiorare le cose. E’ per questo che da anni mi occupo solo di diritto penale commerciale, casi di spionaggio industriale e affini, lasciando ad altri la consulenza nel diritto civile. Nello studio in cui lavoro - un grosso studio legale di Milano - entrano solo uomini d’affari. Chiedono a me e ai miei soci di stendere i contratti in grado di garantire alle loro aziende i migliori profitti, tutelarsi contro i reclami, rimettere sul consumatore, quanto più possibile, la responsabilità di un guasto o del malfunzionamento del prodotto o di un servizio.
Oppure tutelare i propri dipendenti dal logorio psicofisico cui può esporli un lavoro di routine. Le cause di diritto del lavoro possono essere molto gravose per un’azienda: meglio evitare, meglio prevenire. Ci sono anche clienti che ci credono, intendo al benessere dei loro dipendenti, perché migliorare le condizioni di vita delle persone li fa sentire migliori, un po’ come fare beneficienza. E’ quanto ho imparato negli Stati Uniti, dove per beneficenza si organizzano eventi di ogni genere, a volte vere e proprie gare, per finanziare ricerche e gallerie d’arte, dare aiuto ai senzatetto, purificare l’acqua in regioni del mondo in cui non è utilizzabile, in sostanza per mettere a tacere il senso di colpa di persone benestanti verso chi ha meno di loro o esprimere, anche in quell’ambito, la competizione.
Quando ero bambina non avevo mai pensato che un giorno sarei potuta andare a vivere negli Stati Uniti. Per la verità ne ho dubitato o non ci ho pensato fino al mese precedente alla partenza. Sono cresciuta, figlia unica, affidata alle sole cure di mia madre. Mio padre l’ho visto poco, era sempre al bar a bere e le sue condizioni di salute, per via dell’alcool, sono via via andate peggiorando fino alla cirrosi epatica, che se l’è portato via in breve tempo quando io avevo otto anni. Era violento con mia madre, e lei non ha mai battuto ciglio, troppo occupata a mandare avanti la nostra specie di famiglia, e a sfruttare ogni centesimo che guadagnava per farmi studiare e per coprire le interminabili cure mediche di mio padre.
Mia madre faceva le pulizie. Vivevamo in piccolo appartamento alle porte di Milano. Ci siamo salvate grazie alla polvere, manciate, strati di cui si patinavano le scrivanie. Si metteva in bici la mattina presto, prima che io mi alzassi per andare a scuola, mentre mio padre giaceva addormentato sul divano. Lasciava il tavolo della colazione apparecchiato, legava dietro la nuca un fazzoletto che la proteggeva dal freddo, e si incamminava. Fu molti anni dopo la morte di mio padre, che prese a fare le pulizie presso uno degli studi legali del paese. Io all’epoca studiavo alle superiori, frequentavo ragioneria per poter avere subito un impiego al termine dei miei studi.
Conosco perfettamente le mansioni della segreteria cui ho appena dettato una lettera di lavoro, perché è da lì che ho cominciato. E’ come segretaria che, dopo il diploma, ho iniziato a lavorare in questo studio legale, lo stesso in cui mia madre aveva lavorato come donna delle pulizie. Fu proprio l’avvocato a proporglielo.
Disse:
-Me la faccia conoscere, ho bisogno di un po’ d’aiuto, poi magari chissà.
Ricordo ancora quando mia madre me lo propose, un sabato mattina, io al tavolo della cucina davanti al caffelatte e lei in piedi sulla soglia, il fazzoletto in testa e le mani unite, all’altezza del ventre. Ricordo ancora la luce di speranza nei suoi occhi.
-Sarebbe un lavoro sicuro e ben pagato. Poi magari chissà.
Facevo un po’ di tutto e mi recavo spesso in tribunale per notifiche di atti e altre mansioni da galoppino. L’avvocato credeva in me, diceva che ero sveglia, e mi incoraggiò a iscrivermi all’Università l’anno dopo: si sarebbe occupato lui della retta. E così fu, il primo anno, dopo molte riluttanze. Volevo essere autonoma, farmi da me, e gli anni successivi sono sempre andata avanti con borsa di studio. Fu sempre sua, quando stavo per laurearmi, l’idea di fare dell’esperienza all’estero presso un’ Università straniera, Inghilterra o Stati Uniti. Erano gli anni ottanta, grandissima crescita economica e sociale, e l’avvocato aveva iniziato a espandere il suo giro di conoscenze tra gli industriali.
Le aziende si aprivano al mercato estero, in cui il Made in Italy era diventato il nuovo status symbol, e c’era bisogno che qualcuno conoscesse l’inglese e si occupasse dei contratti internazionali. Sarebbe stata la sua nuova forma di business, e insieme saremmo stati pionieri di quell’avventura. L’avvocato mi parlava del King’s college di Londra e dell’ateneo di Harvard, di cui non sapevo quasi nulla se non per averne sentito parlare in qualche film. Erano anni in cui i giovani iniziavano a girare per l’Europa, spesso, durante l’estate. Si mettevano in treno con un biglietto Interrail e visitavano le principali capitali: Londra, Dublino, Vienna, Monaco. Visitavano i musei, le piazze con i monumenti, per poi lasciarsi trasportare dalle abitudini e tradizioni del luogo, la cucina, i concerti e ripartire alla volta di un’altra città.
I miei amici, quelli appartenenti a famiglie un po’ più abbienti, raccontavano delle loro esperienze e sembrava meraviglioso, ma io volevo laurearmi e diventare indipendente il prima possibile. Vivevo ancora con mia madre, che nel frattempo aveva smesso di fare pulizie presso lo studio, ed era andata a fare assistenza quasi fissa a una famiglia, in cui la nonna aveva bisogno di una badante, oltre che di una dama di compagnia. Spesso trascorreva da loro anche la notte e io, sempre più assorbita da lavoro e studio, la vedevo sempre meno. Ogni tanto tornava a casa, i polsi segnati di viola; le chiedevo cosa fosse e lei rispondeva che si era bruciata col forno, o ustionata con l’acido muriatico.
Per la verità non ci facevo molto caso, ché quando c’era mi accontentavo di stare un po’ con lei, per poi dedicarmi agli altri collaboratori dello studio - procuratori o avvocati – con i quali avevo iniziato a fare amicizia. Confrontarmi con loro era prezioso anche per capire cosa avrei voluto fare davvero “da grande”, o come funzionava quel mondo in cui muovevo i primi passi. Mi bastava sapere di essere sempre più padrona della mia vita e sapere che sia io che mia madre in qualche modo ci stavamo facendo la nostra vita come meglio potevamo, andando avanti in maniera dignitosa.
Mi feci convincere dall’avvocato a dare la tesi all’estero, presso la prestigiosa Università di Harvard. Furono mesi intensi in cui misi in gioco tutta me stessa. L’inizio non fu facile, soprattutto per via della lingua che non conoscevo così bene, poi tutto migliorò: studiare, ma anche confrontarmi con persone di ogni parte del mondo, alcune delle quali sento ancora a distanza di anni. Fu meraviglioso entrare a contatto con una cultura in cui i professori davano del tu agli studenti, e li spronavano a dare il proprio contributo.
Era diverso rispetto al panorama accademico italiano in cui vi era un certo distacco tra studenti e docenti, il cui sapere non veniva mai messo in discussione. In più, ero entrata a contatto con una cultura che favoriva l’accesso della donna a ogni settore della società, dalla ricerca, alle cariche politiche e manageriali. Ne veniva promosso lo sviluppo, l’inserimento, il rispetto. Vi erano delle contraddizioni nella cultura americana ma da quel punto di vista la consideravo un’ideale cui l’Italia avrebbe dovuto aspirare. Sul finire di quell’esperienza mia madre mi avvertì di essersi ammalata di epatite b, molto probabilmente a causa del contatto con l’anziana signora, che a sua volta l’aveva contratta in ospedale per via di una trasfusione. Non esitai e rientrai in Italia, com’era necessario. Mia madre guarì, anche se il suo fegato, oramai minato, la rese dipendente da alcuni farmaci.
A parte ciò, i segni sul suo corpo restavano e iniziai a insospettirmi. Insistetti a chiederle se andava tutto bene, come se li era procurati e profilai l’ipotesi di un maltrattamento. È lì che avrei dovuto approfondire, invece che lasciar perdere e restare concentrata sulle mie cose, ma il senno di poi non ha mai fatto la fortuna di nessuno. In paese girava voce che il genero della signora avesse le mani pesanti, sia con la moglie che con la suocera, ma le avevo ritenute dicerie e mia madre faceva la vaga. Mi ripeteva che era stanca, ma che le era necessario continuare a lavorare perché la retribuzione era buona. Trascorsero altri due anni, oramai mi muovevo con sicurezza in ambito giuridico, supportando l’avvocato e facendo fruttare i contatti che avevo preso negli stati uniti per sviluppare forme di commercio internazionale di cui curavo la contrattualistica, e potei andare a vivere da sola, in affitto.
Venne anche il giorno, indimenticabile, in cui superai brillantemente l’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Festeggiai con un po’ di amici e il mio fidanzato, un giovane magistrato conosciuto a una cena sociale. Pochi giorni dopo, mia madre non si sentì bene e solo a quel punto mi confessò di ricevere percosse dal genero della signora anziana. Non c’era un motivo, lo faceva nei giorni in cui aveva avuto una giornata difficile o era particolarmente nervoso, lo faceva per spazzare via la rabbia o la frustrazione, ciascuno di noi a suo modo può avere uno strato di polvere nella sua vita. Nonostante la riluttanza di mia madre le imposi di interrompere subito quel lavoro e feci in modo di far disporre delle intercettazioni, eravamo ormai ai primi anni novanta, ma non servirono a molto per certi aspetti.
Mia madre fu trovata morta ai piedi della sua bicicletta una sera d’inverno. Il fegato, fiaccato dall’epatite, aveva ceduto a seguito di un calcio che era stato fatale, e aveva mandato tutto il corpo in arresto. Un corpo senza vita, per strada, tra foglie e polvere. L’uomo, adirato per come si erano messe le cose, fu individuato grazie alle telecamere di sorveglianza di una banca lì vicino. Ho vinto il processo per omicidio colposo contro quel mostro. La sentenza non me l’ha restituita, ma mi piace pensare possa essere un disincentivo a delinquere, e un incoraggiamento a tutte le donne perché denuncino chi getta polvere sulla loro serenità. Il tassello minuscolo di un mosaico. Dal 2013 i casi di femminicidio sono aumentati del cinquanta all’anno, dicono che alla base vi sia una concezione della donna come oggetto, fonte di possesso, priva di emozioni.
Gli studi dicono vi sia paura di abbandono o istinto di vendetta verso le vittime. Così cerco di insegnare a mia figlia a difendersi in caso di pericolo, e a mio figlio a rispettare le donne, chiunque esse siano, anche ora che riapro questo fascicolo, da cui esce un filo di polvere.
Altro...
Polvere - Camilla Galli
Scritto da Jona EditoreL’oggetto più simile al moderno aspirapolvere fu ideato nel 1908 da James Murray Spangler, un portinaio originario dell’Ohio. Si trattava del bizzarro assemblaggio di un ventilatore, una scatola e un cuscino, ma il brevetto, venduto alla società di un cugino, la Hoover Harness and Leather Goods Factory, fece di William H. Hoover un magnate nel campo degli elettrodomestici, e dell’aspirapolvere un articolo di lusso e oggetto del desiderio di ogni casalinga. Intorno al 1920, la ditta tedesca Vorwerk, che fabbricava tappeti, convertì la sua produzione in grammofoni. Dopo un iniziale successo, l’avvento della radio li rese obsoleti e gli affari precipitarono, finché non si pensò di utilizzare i motori dei grammofoni invenduti per realizzare un nuovo modello di aspirapolvere. Il primo prototipo uscì sul mercato nel 1930, e, grazie a un efficace sistema di vendita porta a porta, divenne un oggetto molto diffuso, tanto da venire esportato anche in Italia, dal 1938, con il nome di Folletto. Nel 1949 il numero di apparecchi venduti raggiunse lo strabiliante traguardo del milione.
Emma e Vittorio si conobbero nel marzo di quello stesso anno, per una banale coincidenza: lui, agente di commercio di ritorno da un giro di visite, si era ritrovato con una gomma a terra nei dintorni della biblioteca comunale in cui lavorava lei, come vice direttrice (con buone speranze di eliminare il “vice” entro un paio d’anni, quando la direttrice in carica, la Signorina Turbati, si sarebbe finalmente ritirata per godersi la pensione). Vittorio era entrato in biblioteca per usare il telefono. Emma aveva alzato gli occhi dall’elenco di libri che stava controllando e aveva visto all’ingresso un ragazzo dall’aspetto piuttosto ordinario, ma in evidente difficoltà, che allungava il collo cercando con lo sguardo qualcuno che lo potesse aiutare. Si diresse verso di lui, si presentò e, una volta che Vittorio le ebbe spiegato cosa gli era accaduto (“Un mio amico fa il meccanico, e ha l’officina proprio da queste parti. Se sono fortunato lo troverò ancora lì” le disse), lo accompagnò nell’ufficio della signorina Turbati, dove gli indicò il telefono. Uscì dalla stanza, ma rimase dietro la porta appena accostata. Sentì che Vittorio dava alcune indicazioni alla centralinista e poi: “Mamma, sono io. Ti sto chiamando dalla biblioteca, ho forato. Non ti preoccupare, sto bene, non è niente di grave.” Il suo tono si era fatto più dolce, come se stesse rassicurando un bambino molto piccolo appena svegliato da un brutto sogno. “No, penso che lascerò l’auto qui e tornerò a casa a piedi. Certo mamma, faccio prima che posso.” E riagganciò. Emma si meravigliò di quella bugia, per quanto innocente: perché inventare la storia del meccanico quando voleva solo avvisare la madre? Certo non si era comportata meglio lei, stando a origliare la conversazione privata di un figlio affettuoso.
“Se non ha fretta, posso accompagnarla a casa io: tra dieci minuti stacco e fuori sta per piovere”. Neanche lei sapeva da dove le fosse uscita una frase così sfacciata. Era stato come sentire la voce di un’estranea. Ma quel ragazzo aveva qualcosa che destava il suo interesse. Sul viso di Vittorio passarono prima la sorpresa, poi l’imbarazzo per quella proposta, e ad Emma parve che stesse per rifiutare, ma poi lanciò uno sguardo fuori dalla vetrata, in fondo al corridoio della biblioteca, e da lì all’orologio, calcolando (o almeno così parve a lei) quanto tempo avrebbe impiegato andando a piedi e quanto invece aspettando che lei smontasse e lo accompagnasse in macchina. “La ringrazio, ma vede, a piedi non mi ci vorranno comunque più di cinque minuti, mia madre mi sta aspettando a casa, e sarà in pensiero, con la storia della gomma bucata e il resto… E poi non voglio che faccia tardi a causa mia, farà stare in pensiero qualcuno…”. Emma fu più decisa di lui: “Posso uscire prima: capita spesso che mi trattenga qui oltre l’orario e se recupero dieci minuti non avranno da obiettare… E comunque vivo sola, non c’è nessuno a stare in pensiero”. Mentre infilava al volo il cappotto e recuperava la borsetta, si rese conto che mai, in quei tre anni, era uscita un minuto prima dell’ora prestabilita. Nemmeno per un raffreddore o per un’emergenza. “Ebbene, c’è sempre una prima volta” pensò senza parlare.
Il tragitto in macchina fu brevissimo, ma molto piacevole, per entrambi: Vittorio sembrò tranquillizzarsi alla prospettiva di arrivare a casa senza ritardi, Emma provò il brivido di una cosa nuova, e scambiarono quattro chiacchiere stando sulle generali. Arrivati davanti al vialetto della sua palazzina, Vittorio vide una luce accesa in casa e fu preso da una smania improvvisa: la salutò in fretta, profondendosi pur sempre in mille ringraziamenti, e, sceso dall’auto, corse fino alla porta di casa, il bavero del paltò alzato fin sopra le orecchie per proteggersi dalla pioggia che aveva iniziato a cadere. Le sembrò uno scolaro che affretta il passo al suono della campanella, più che un uomo che cercava riparo dal temporale, e sentì affiorare un’ondata di tenerezza.
Inaspettatamente, la mattina dopo Vittorio fece il suo ingresso in biblioteca stringendo tra le mani un mazzolino di fiori, che depose sul banco all’ingresso sotto gli occhi sbalorditi di Emma. “Mi sembra il minimo, per ringraziarla di quanto ha fatto per me ieri sera. Posso invitarla a pranzo?”. Emma naturalmente accettò, e a quel pranzo ne seguirono molti altri, e dopo i pranzi vennero le domeniche pomeriggio ai giardini pubblici, se il tempo lo consentiva, e le passeggiate prima di cena, quando le giornate iniziarono ad allungarsi. Un pomeriggio di aprile lui le prese la mano, ed Emma lo lasciò fare.
Un giorno, Vittorio si presentò ad Emma nervoso e trafelato: era evidente che doveva chiederle qualcosa, ma non sapeva come affrontare l’argomento- “Emma, mia madre vorrebbe conoscerti”. Lei provò un immediato e intenso sollievo: era dunque solo questo? Bene, avrebbe conosciuto la madre di Vittorio. Voleva forse dire che a breve le avrebbe chiesto di sposarla? Emma pensò al suo appartamentino, lo immaginò vuoto, la sua vita impacchettata in qualche baule, pronta per essere spedita a un indirizzo nuovo, e provò una stretta al cuore. Le sue amiche, tutte già sposate, sembravano condividere a riguardo un oscuro segreto. “Un passo alla volta”, si disse. E poi che male le avrebbe potuto fare quella donnina bisognosa solo di affetto e di rassicurazioni?
La domenica successiva suonò al campanello della palazzina dove viveva Vittorio con sua madre. Le aprì una donna più bassa di lei, della quale per prima cosa la colpì la particolare sottigliezza delle estremità: era come se uno scultore, arrivato il momento di modellare mani, piedi e cranio, avesse terminato l’argilla. Il viso, soprattutto, era affilato e spigoloso. Il naso, leggermente aquilino, sembrava intagliato dal vento. Alcune ciocche di capelli, chiari e sottili, volavano dalle tempie verso le orecchie, come penne di un uccello in picchiata. Gli occhi erano due spilli irrequieti. Durante le presentazioni, frettolose, sulla soglia, le labbra sottili si incresparono in un sorriso, poi la madre di Vittorio si ritrasse per farla entrare. Emma notò che, nonostante l’abbigliamento - non alla moda, ma curato - aveva le movenze rapide e la postura da cameriera. Si accomodarono in un salottino che diede ad Emma l’illusione di trovarsi nella vetrina di un negozio di arredamento: non perché vi fossero dei pezzi di particolare pregio, anzi la mobilia era del tutto ordinaria, ma perché sembrava il set di un film che doveva ancora essere girato. Non c’erano segni di occupazione - segni di vita, pensò - non c’era nulla fuori posto, ma l’ordine estremo, la disposizione dei pochi oggetti, le pieghe perfette e i cuscini senza un’ombra di sgualcitura, rendevano il tutto piuttosto impersonale. Era come prendere il caffè nella hall di una pensioncina di provincia. La madre di Vittorio sembrava riuscire a stare seduta sul piccolo divano senza toccarlo. Né in quell’incontro, né nei successivi avvenne nulla di evidente. Il tutto si svolgeva sempre secondo lo stesso copione: dopo i rapidi convenevoli, Vittorio e sua madre iniziavano a chiacchierare del più e del meno, e lei semplicemente scompariva. La madre di Vittorio le passava attraverso con il suo sguardo cortese ma indifferente, come se anche lei facesse parte dell’arredamento, o come se fosse un’ospite straniera che non parlava la loro lingua. A ogni visita, in particolar modo per le occasioni speciali come il compleanno della signora, Emma portava in dono, secondo quanto le era stato insegnato, un piccolo pensiero: un mazzo di fiori, un libro, dei pasticcini, che venivano immediatamente abbandonati in un angolo oppure occultati in cucina e ignorati per il resto del pomeriggio. Per contro, mai nulla aveva compiuto il percorso inverso, dalle mani della madre di Vittorio alle sue: non un pensiero, non un oggetto, anche di nessun valore, non un biglietto di auguri, che fosse il suo compleanno, o Natale, o Pasqua. Emma era certa che quelle visite avvenissero per volontà di Vittorio, che non fosse mai lei ad invitarla. E la donna le affrontava con lo stesso spirito con cui Emma immaginava si dedicasse alle faccende di casa: rassegnazione, indifferenza e l’intenzione di farle durare il meno possibile. Contrariamente a quanto si sarebbe aspettata, Emma sentì che più passava il tempo e più la donna la trattava con freddezza. Nei rari momenti in cui il figlio non era presente, non perdeva l’occasione di lanciarle frasi ambigue. Capitò che si incrociassero per strada e che distogliesse lo sguardo, fingendo di non averla vista. Un paio di volte, Emma tentò di spiegare a Vittorio le sue sensazioni, ma non appena le prime parole le uscivano di bocca si andavano ad infrangere contro una scogliera impenetrabile: sua madre era fatta così, certo era una donna poco espansiva, ma quello era il suo carattere, e poi forse Emma era troppo suscettibile, faceva caso a particolari insignificanti, a gesti senza importanza e fatti in buona fede; e si disperdevano in una nebbiolina inconsistente. Emma cercava di pensare che, se mai lui glielo avesse chiesto, era Vittorio che avrebbe sposato, non sua madre, e l’attaccamento che provavano l’uno per l’altra avrebbe sempre appianato qualsiasi questione.
La proposta arrivò, ed Emma e Vittorio si sposarono l’autunno seguente. Si trasferirono in un appartamentino che si era appena liberato sullo stesso pianerottolo della madre di Vittorio. Le visite domenicali divennero incontri quotidiani, tanto sgradevoli quanto inevitabili. Ogni sera, dopo il lavoro, Vittorio passava a salutare la madre prima di rientrare a casa. Un sabato pomeriggio, mentre Vittorio leggeva il giornale e di tanto in tanto lanciava un’occhiata a Emma, intenta a riordinare la sala da pranzo, con il tono leggero di sempre le disse: “Forse è troppo faticoso badare alla casa e mantenere il tuo impiego in biblioteca. Non pensi che, ora che siamo sposati, io possa provvedere a te?”. Emma fermò a mezz’aria il battitappeto e lo osservò attentamente. Quelle parole non erano le sue. Vittorio aveva sempre apprezzato la sua indipendenza e conosceva le sue aspirazioni, il suo desiderio di diventare direttrice della biblioteca. “E poi, per quanto tu ti possa impegnare, e vedo che lo fai, purtroppo con tante ore passate fuori casa, le faccende inevitabilmente vengono trascurate. E la polvere si accumula”. “Oh, se è per quello, tra poco è il mio compleanno: perché non mi regali un aspirapolvere? Ormai ce n’è uno in ogni casa. E mi farebbe risparmiare un sacco di tempo!” ribatté lei. Dopo un attimo di silenzio, gli sentì dire: “Mia madre non ne ha mai avuto uno, eppure il pavimento su cui ho giocato da bambino era sempre immacolato” e questo pose fine alla discussione.
Mentre sgombrava il suo ufficio e raccoglieva le sue cose, Emma pensò che non poteva mettere a repentaglio il suo matrimonio per uno stupido lavoro, che tutte le sue amiche avrebbero dato chissà cosa per avere accanto un uomo affidabile e un’esistenza in cui la più grave preoccupazione fosse l’accumularsi della polvere. Ciononostante, la certezza di aver tradito il futuro che aveva tanto desiderato le procurò una fitta di dolore e le spense per sempre una luce negli occhi.
Per farle dimenticare il dispiacere, Vittorio organizzò una vacanza per il loro primo anniversario di matrimonio. Dopo qualche giorno dalla partenza l’umore di Emma si stabilizzò, mentre lei iniziava ad abituarsi all’idea che d’ora in avanti quella sarebbe stata la sua nuova vita.
Un imprevisto li costrinse ad anticipare il rientro: la madre di Vittorio aveva avuto un colpo apoplettico, che le aveva lasciato pesanti segni. Il volto era contratto in una smorfia, che lo rendeva ancora più truce di prima, le era ormai impossibile camminare e parlare, e il medico li preparò all’eventualità che un secondo episodio potesse sopraggiungere, ed esserle fatale.
Quando venne dimessa dall’ospedale, la trasferirono nel loro appartamento. “È una fortuna che ci sia tu ad occuparti di lei, non so davvero come avrei fatto” le disse Vittorio baciandola sulla fronte. Lanciò un ultimo sguardo alla moglie e alla madre, sedute a tavola davanti ai resti della colazione, e uscì per andare al lavoro.
All’inizio Emma aveva pensato di aiutare la donna e di chiedere a suo padre, medico, il nome di uno specialista, o magari fare lei stessa qualche telefonata. Poi decise di no, l’avrebbe lasciata annaspare, servendole una generosa porzione di indifferenza. Che si arrangiasse. Guardava ormai con disprezzo la versione di sé che subito avrebbe assunto un atteggiamento di sollecita quanto posticcia partecipazione, che avrebbe finto interesse. Ormai era sepolta, più che sotto le mille piccole angherie che aveva subito, o sotto l’immagine di quel volto odioso dal ghigno cattivo, era stata seppellita dal ricordo della cocente umiliazione di se stessa. Quanto si era sentita stupida e a disagio quando aveva fatto un qualsiasi gesto gentile nei suoi confronti, venendo ripagata solo con maleducazione, noncuranza e malcelata cattiveria. Quanta pena aveva avuto di se stessa, per essersi vista troppe volte nei panni di una mendicante senza convinzione. Quante volte aveva provato vergogna per aver teso una mano senza che dall’altra parte una mano venisse a lei tesa di rimando. Anche ora sentiva che, a ondate, quella misera Emma tentava di risorgere. Lei la lasciava fare, solo per ucciderla ogni volta. Che se la sbrigasse da sola. Anzi, si trovò persino a desiderare che la madre di Vittorio si sentisse sdegnata e offesa, vedendo che non muoveva un dito. Nonostante tutto, non traeva alcuna soddisfazione dalla condizione attuale della donna: era convinta infatti che la sua cattiveria sarebbe riuscita a trarla d’impaccio da ogni situazione. Questo forse più di tutto la indispettiva: pensare che se lo stesso incidente fosse capitato a qualcuno di buono (lei?), non avrebbe potuto fare altro che soccombere, mentre quella donna, con la sua incapacità di provare alcunché, la sua subdola, piccola prepotenza, in un modo o nell’altro sarebbe sempre uscita indenne da ogni tempesta. Quella cattiveria sembrava proteggerla, come un mantello, da qualsiasi dolore.
Quando la madre di Vittorio ebbe il secondo colpo apoplettico, lei ed Emma erano in casa da sole. Emma era andata in cucina a prendere un bicchiere di limonata fresca, quando aveva sentito un tonfo sordo e un rumore di vetri infranti. Corse in sala da pranzo e la vide, rattrappita sul pavimento. Una mano artigliava il bordo della tovaglia che aveva strattonato cadendo, il vaso di cristallo dal centro della tavola si era rovesciato a terra ed era esploso in un firmamento di frammenti aguzzi. Le punte dei piedi grattavano sulle piastrelle, come un impiccato che cercava un appiglio. La testa era ripiegata all’indietro in modo innaturale, tanto che i capelli sottili come ragnatele quasi sfioravano un punto tra le scapole. Gli occhi, due crune d’ago color carta da zucchero, sembravano vibrare di odio. Frugavano rabbiosamente cercando qualcosa. Cercavano lei. Emma istintivamente si ritrasse. E poi divenne di pietra. Non mosse un passo, non emise un fiato, non sentì nulla. Quando il torpore la abbandonò, si accorse che stringeva ancora tra le dita il bicchiere di limonata, divenuta tiepida.
I funerali si celebrarono di lì a due giorni, le poche persone che intervennero erano per lo più amici di Vittorio. La donna fu cremata, secondo le sue volontà, e l’urna fu posta accanto alle foto di famiglia sul vecchio cassettone in sala da pranzo. Emma non ebbe cuore di opporsi, ma quando Vittorio riprese a lavorare e si trovò per la prima volta sola in casa, il silenzio che seguì al rumore del motore dell’auto che si allontanava lungo il vialetto si chiuse sopra di lei. Il cuore prese a batterle più forte, come quando da piccola sua madre la mandava a prendere una bottiglia di vino in cantina e lei immaginava di vedere la porta richiudersi intrappolandola al buio. Pensava che se non avesse abbandonato il suo lavoro alla biblioteca, almeno avrebbe avuto un altro posto dove stare, qualcos’altro a cui pensare. Prese a riordinare la cucina, le camere da letto, pulì a fondo il bagno, lavò le finestre di tutta la casa, ma si tenne lontana dalla sala da pranzo. Uscì per delle commissioni e fece in modo di stare fuori quasi tutto il pomeriggio. Solo quando sentì Vittorio rientrare, si decise ad apparecchiare la tavola, con gesti automatici, senza togliere gli occhi dall’urna, muta al proprio posto.
Quella notte Emma dormì di un sonno leggero e agitato. Sognò di affacciarsi sulla sala illuminata solo dalla fredda luce del lampioncino sul vialetto. L’urna era sparita. Ricordava di aver pensato che Vittorio se la sarebbe presa con lei e che l’avrebbe costretta a comprarne una identica, con dentro nuove ceneri. Mentre rimestava questo assurdo pensiero, l’aveva vista. Seduta a tavola, immobile, a fissarla. Cancellato ogni segno del primo colpo apoplettico, il ghigno era tornato. L’urna non c’era più perché lei non era morta. Emma si svegliò di soprassalto, impiegando alcuni istanti a riemergere dall’incubo e quando le nebbie si furono sfilacciate fino a svanire, rimase a fissare il soffitto e non tentò più di prendere sonno. Fu con sollievo che vide, dopo un tempo che le parve eterno, le prime luci dell’alba filtrare dalle persiane accostate. Scese dal letto con la sensazione di avere sulla pelle una pesante coperta ghiacciata, e si chiuse in bagno. Guardandosi allo specchio vide i suoi occhi segnati da pesanti occhiaie, e due profonde rughe che le correvano agli angoli della bocca, piegati all’ingiù. Si sforzò di pensare che prima o poi si sarebbe abituata, che l’urna con le ceneri sarebbe scomparsa, come tutto ciò che abbiamo sempre sotto gli occhi. E poi non avrebbe saputo come chiedere a Vittorio di eliminarla. In fondo era solo polvere. Non rimaneva nulla, se non un chilo scarso di polvere. Polvere. Emma sentì la larva di un pensiero emergere dal gelo della notte appena trascorsa. La osservò agitarsi e crescere e prendere forma, come una creatura indipendente, dotata di volontà propria. Ed Emma la lasciò fare.
Non appena Vittorio uscì, corse a prepararsi. Avvertiva un leggero formicolio alle mani mentre estraeva dal cassetto il libretto degli assegni e lo infilava rapidamente nella tasca del paltò, come se temesse di farsi scoprire. Passando davanti all’urna con le ceneri della madre di Vittorio (“Solo polvere” pensò), non poté fare a meno di affrettare il passo. Si chiuse la porta di casa alle spalle e fu fuori. Il calore di un raggio di sole le si posò addosso, facendola sentire reale. Salì in macchina, uscì dal vialetto in retromarcia, lanciando un’occhiata alla finestra della sala, aspettandosi di vederla affacciata, i suoi occhi freddi puntati verso di lei. Parcheggiò davanti ai Grandi Magazzini Gaspari, ed entrò. Si diresse al reparto elettrodomestici, dove fu avvicinata da un commesso che le chiese in tono gentile se le servisse aiuto.
Quando fermò l’auto nuovamente in fondo al vialetto, rimase un istante a fissare l’immagine che le rimandava lo specchietto retrovisore. Sul sedile posteriore, ancora imballato, c’era l’ultimo modello di Folletto. La scritta verde smeraldo sullo scatolone risplendeva alla luce del sole, mandando bagliori rassicuranti. Sembrava quasi animata: Emma ebbe la sensazione di aver dato un passaggio a un buon amico. A quel pensiero le piombò addosso la solitudine che aveva provato negli ultimi tempi. Sentì quell’enorme peso cadere di schianto sulle sue spalle: l’isolamento, l’impotenza, l’indifferenza, la sordità disperante di Vittorio, incapace di ascoltare o di credere, solo teso nello sforzo di minimizzare o ridicolizzare ciò che lei cercava di mostrargli. Posò la fronte sul volante e pianse.
Aprì la porta di casa: la sentì vuota e silenziosa. Respirò un’aria di resa. Guardò le sue mani scartare l’imballaggio, estrarre l’aspirapolvere e inserire la spina nella presa a muro. Poi si volse verso l’urna. Per la prima volta da quando Vittorio l’aveva portata a casa le apparve per ciò che era: un oggetto inanimato, inoffensivo. Mentre allungava una mano per afferrarla fu attraversata da un pensiero assurdo: non sarebbe riuscita a muoverla, il peso delle ceneri, e di ciò che quella polvere significava, l’avrebbero tenuta inchiodata al cassettone. Perciò si stupì quando senza sforzo la sollevò a mezz’aria. Svitò il coperchio e si scoprì a pensare che era lo stesso gesto con cui ogni mattina apriva il barattolo del caffè. Imbracciò l’urna con entrambe le mani. La inclinò lentamente, chinandosi piano. Una finissima polvere grigia iniziò a scivolare fuori, andando a depositarsi sul pavimento. Emma la guardava scendere, tendendo l’orecchio affascinata per percepirne il leggero fruscio. Era come guardare i granelli che scorrevano in una clessidra; le tornarono in mente i giochi che faceva da bambina sulla spiaggia: quel velo di sabbia chiara e asciutta che svaniva nelle fessure tra le dita delle mani chiuse a coppa. Il pensiero della madre di Vittorio, della sua presenza reale, anche se in un passato ancora molto vicino, si era ormai sganciato da ciò che stava guardando: un cumulo di polvere.
Posò nuovamente l’urna, ora più leggera, sul cassettone e riavvitò il coperchio. Poi azionò l’aspirapolvere. Non sentiva il rumore secco dell’aspirazione, era come se si muovesse sott’acqua. Osservava la spazzola fare avanti e indietro in una danza sul pavimento. Non volle attaccare subito la piccola montagnola grigia: iniziò a girarle intorno e di tanto in tanto mandava il beccuccio più vicino, ne aspirava una boccata e di nuovo lo allontanava, come in un balletto. Era come guardare un piccione che prende a beccate un tozzo di pane. Dopo poco sentì che l’aspirapolvere la guidava, scivolando sicuro e senza fretta. Il braccio di Emma serviva solo a dargli l’inclinazione giusta, per il resto faceva tutto da solo. E lei non voleva che finisse subito. Già metà del mucchietto era stata ingoiato ed era scomparso. Un incantesimo aveva tramutato la strega in polvere, e ora toccava a lei sbarazzarsene. Quando non rimase più nulla, spense l’apparecchio, staccò la spina e rimase un istante ad ammirare ciò che aveva fatto. Poi corse ad aprire le tende e spalancò le finestre della sala per far entrare più luce e aria pulita.
Quella sera, al rientro dal lavoro, Vittorio trovò la casa perfettamente linda e in ordine. Emma colse l’occasione per mostrargli timidamente il suo nuovo acquisto. Lui tacque per qualche istante, poi stancamente disse: “Ma sì, hai fatto bene. Ormai ce l’hanno proprio tutti. E poi, dopo quello che hai passato anche tu, te lo meritavi”. “Lo credo anche io” rispose. Dopo cena, come al solito, Vittorio indossò il cappotto per portare fuori la spazzatura. “Tesoro – disse Emma – potresti buttare anche il sacco dell’aspirapolvere? Me ne sono completamente dimenticata”. Emma rimase alla finestra, a guardare Vittorio che percorreva il vialetto, illuminato appena dal lampioncino, e gettare nel cassone il sacco pieno di polvere.
Jenny è pazza - Almigio Stoppini
Scritto da Jona EditoreOggi sono in pace col mondo. Se tutto finisse qui sarebbe perfetto. Ma non finisce, il mondo va avanti e nel suo andare avanti mi srotola addosso la solita carta moschicida e le giornate come questa, giornate in cui sono in pace col mondo, sono sempre più rare. Come un Penny Black. Ma la maggior parte del mondo neanche ha idea di cosa sia un Penny Black. E in tutte le altre giornate mi sento uno scarto, un rifiuto, lo stampo di prova di un ragazzino venuto male. Quanti come me devono averne sbagliati prima di arrivare a fare un Giacomelli, fenomeno con le scarpette ai piedi e in odore delle giovanili del Cesena; oppure una Rubini, che riesce a far ridere i compagni e i professori anche per chiedere i compiti da scrivere sul diario; per non parlare di un Zambelli, Riccardo Zambelli, di quarta E, che nel dizionario sotto la voce popolarità ci potrebbero mettere la sua foto, talmente figo da non sembrare vero. E allora aveva voglia mio padre a dire che dovevo smetterla di stare attaccato al computer, che dovevo vivere nel mondo reale, che tutti quei contatti – perché, signori, avevo esaurito l'account facebook, tradotto: avevo la bellezza di cinquemila contatti – non erano vere amicizie, ma disperati come me che rifiutavano di affrontare la vita reale! I primi bozzetti di Big Jim non erano mica passati alla storia come i giocattoli del secolo. Gli stampi dei primi Goldrake venuti male – perché mio padre, così perfetto e calato nel mondo reale, era un appassionato di Goldrake Ufo Robot, tradotto: antidiluviano cartone animato giapponese, anni ottanta, non so se mi spiego – mica erano conservati al Moma di New York! Ma di cosa parliamo, che mio padre neanche aveva idea di cosa fosse il Moma di New York. Però che Big Jim io lo spogliavo per guardarlo sotto, anziché fargli fare i lavori da macho e fargli trattare Barbie come lui trattava mia madre, questo lo sapeva. Che non avevo amici perché mi chiamavano Jenny la checca, anche questo lo sapeva e non ce lo poteva perdonare. Né a me, né a mia madre.
Quando sei il prototipo dello sfigato, la brutta copia del compagno che nessuno vuole avere come vicino di banco, lo stampo di plastica dell'antisport disciolto sotto la luce di una vecchia lampadina a incandescenza, è ben difficile trovare nel mondo un posto che ti calzi a pennello, un posto che non sia un angolo buio o il fondo di una pattumiera, e sentircisi bene. E allora per fortuna che c'era la rete e che potevo socializzare anche senza essere un Giacomelli, una Rubini o uno Zambelli: sia lodato Zuckerberg, sempre sia lodato.
Se i miei genitori avessero mai provato a capire cosa mi passava davvero per la testa forse sarebbero stati più sereni e avrebbero smesso di stressarmi e di stressarsi. Ché non ero mai stata malata, anche se ogni tanto parlavo di me al femminile. E mia madre - perché sapevo che era stata lei a lasciare nella cronologia del tablet le ricerche sulla dipendenza da internet – non sarebbe andata a dormire a forza di pillole, con le rughe triplicate dai pensieri, ché questo figlio in fondo non era poi così anormale. Conoscevo anche io i sintomi della dipendenza dalla rete e non ne avevo neanche uno: non stavo male se non c'era connessione, non passavo la notte davanti alla tastiera, non avevo sbalzi di umore, non soffrivo di insonnia o del tunnel carpale – sì, pare che la dipendenza da internet e l'abuso del computer diano tutti questi disturbi, o almeno è questo che diceva la guida cui era arrivata la regina della casa – semplicemente era in rete che avevo tutte le mie amicizie. E se fuori dalla rete non parlavo con nessuno, di certo non con i miei genitori, forse avrebbero dovuto capire che sì, qualche cosa non andava, ma che era in loro, in loro e nei loro maledetti e maldestri e continui tentativi di farmi cambiare. Era mio padre che non andava. Il fatto che dannasse se stesso per avermi chiamato Gennaro, come se il mio essere Jenny la checca dipendesse solo da quello stupido nome. Si dannava anche per altre cose, ad esempio per non avermi preso a ceffoni quando aveva beccato me e Pietro che perlustravamo i nostri reciproci corpi giù in cantina. Mia madre gli aveva detto che era solo curiosità da ragazzini, che era meglio se scoprivamo tra noi come funzionava “quella cosa” piuttosto che tramite quelle schifezze che lui teneva nascoste nel comodino. “Quella cosa”, nel bigotto codice verbale di mia madre, era la masturbazione. Mio padre ogni sera si masturbava a letto sbirciando riviste pornografiche, a lume di abatjour, mentre lei fingeva di dormire e, quando avevano beccato me e il mio amico che ci facevamo una sega a vicenda, le era sembrato più facile definirlo “quella cosa” e lasciare che lui demonizzasse il nostro comportamento e le nostre giovani e inesperte voglie anziché parlare di masturbazione e affrontare con mio padre il motivo delle sue voglie di vecchio represso.
Oggi sono in pace col mondo perché nessuno mi è venuto a trovare. Ho potuto leggere e riposare. Dopo aver letto per un paio d’ore ho tenuto la finestra aperta e la serranda abbassata con i buchi, e la musica che arriva dalla spiaggia mi ha fatto compagnia. Ho immaginato corpi di ragazzi accaldati che ballavano in riva al mare.
Mi rendevo conto che non potevo considerare amici tutti i miei cinquemila contatti; forse neanche cinquecento, magari cinquanta; fossero stati anche solo cinquanta mi sarei dovuto preoccupare? Andavo bene a scuola. Non frequentavo cattive compagnie. Ok questa non vale perché non frequentavo nessun tipo di compagnia. Non avevo neanche mai chiesto il motorino. E anche questa non vale, perché questa per i miei era stato un problema. Per mia madre, perché lei voleva che io approfittassi della libertà che mi concedeva - probabilmente quella che lei alla mia età non aveva avuto - voleva che andassi in giro, che mi divertissi, che facessi tardi, che stessi tra la gente. Immagino che sarebbe stata contenta anche se col motorino fossi andato in cerca di ragazzi, tutto purché ne avessi approfittato, io che potevo. Per mio padre, perché lui sulla moto ci andava in giro, lui era un centauro, con la sua maledetta Harley nera. Un figlio maschio che non voleva il motorino era giusto che lo chiamassero Jenny la checca, ché solo i froci non avevano voglia di fare le corse col motorino.
Offline - Matteo Pieri
Scritto da Jona EditoreIl primo racconto di Plot
Scrivere è una condanna a morte. Non posso evitare di farlo, ma non riesco a farlo come vorrei. Certe volte mi fisso su un dettaglio che mi blocca per giorni. Allora ascolto musica e mi perdo su internet. Quella sera curiosavo sui programmi per la scrittura creativa. Ci sono programmi che ti aiutano con il vocabolario, con schede sui personaggi e cronologie di eventi.
Io scrivo la notte a forza di caffè e un lavoro può protrarsi per mesi. Non è facile tenere a mente i nomi e i fatti della storia per tutto quel tempo, quindi capisco l’utilità di quei programmi, ma temo che possano diventare ulteriori alibi, modi per rimandare l’appuntamento con la scrittura. Quando chiudo la schermata mi appare la notifica di una mail. Nella mail c’è la pubblicità di un’applicazione per la scrittura creativa, si chiama Plot, lo slogan dice che non si tratta del solito software: “Plot interagisce con l’autore e lo stimola nella realizzazione delle proprie idee”. Chiudo la posta elettronica e per un attimo si apre un’altra finestra che subito scompare. È un virus. Chiudo tutto, scollego il pc da internet e lancio la scansione dell’antivirus.
Fisso la percentuale dell’analisi che scorre sul contatore.
Nessuna minaccia rilevata. Vado a letto.
A scuola è un delirio. Un ragazzo che seguo ha fatto dei progressi importanti quest’anno, ma non credo possa affrontare le scuole superiori. Tra una settimana c’è l’ultimo ricevimento dei genitori e nessuno vuole prendersi la responsabilità di decidere. Nemmeno io. Penso solo alla maledizione. É l’idea del racconto che sto scrivendo: un antropologo è convinto che esista un uomo bicentenario che vive isolato nella giungla. Dopo mesi di ricerche a vuoto, quando gli assistenti stanno per ritirarsi, un uomo si presenta all’accampamento. È schivo e rabbioso, non parla, ma osserva con sospetto. Risponde alle sollecitazioni dell’antropologo con gesti e grugniti, spesso si rannicchia in un angolo con le mani sulla testa e piange di dolore. Il ricercatore pensa che l’isolamento abbia ridotto l’uomo a una condizione autistica, che ha modificato in lui perfino l’espressione universale delle emozioni. Vorrebbe aiutare l’uomo alleviando il dolore che lo affligge, ma non riesce ad avvicinarlo. L’uomo non mangia, non beve e non evacua. Quando l’antropologo si avvicina per somministrargli un antidolorifico, l’uomo lo afferra per i polsi, sgrana gli occhi e lo fissa. Sembra che stia per dire qualcosa, ma la bocca si spalanca in un grido sordo. Poi molla la presa e si accascia a terra. Il viso si distende nell’accenno di un sorriso. È morto.
Nei giorni che seguono l’antropologo fa una serie di indagini sul corpo, ma non riesce a capire niente sulla condizione di quell’uomo e sulle ragioni della sua morte. Non ci sono infezioni importanti, nessuna malformazione o massa tumorale. L’antropologo ripensa al momento in cui lo aveva afferrato per i polsi, prima di morire. Nel momento in cui lo aveva fissato negli occhi sembrava aver scelto di morire. Quel pensiero fisso lo ossessiona. Anche lui sente un dolore diffuso e continuo, che non saprebbe spiegare o misurare. Si sottopone ad analisi, chiede opinioni, ma nessuno sa aiutarlo. Smette di dormire, viene meno agli impegni con la famiglia e la comunità scientifica lo allontana. Solo e delirante capirà la condizione di quell’uomo, vittima di un dolore immotivato e implacabile. È pronto a tutto pur di porre fine allo strazio. Ingerisce un veleno e sente l’evolversi del dolore, gli organi che si contraggono e la vie respiratorie congestionate, ma non muore. Al contrario, da quel momento la maledizione cresce di giorno in giorno. Pensa all’uomo della giungla, alla sua rabbia e alla diffidenza. Ricorda l’esasperazione con la quale lo aveva afferrato, e il rammarico mentre lo fissava. Ricorda il sollievo sul suo viso, nell’attimo prima di spirare. Per quanto tempo aveva sopportato quel castigo? Era stato lui a passargli la maledizione? Forse quello era l’unico modo per liberarsi del dolore, passare la maledizione a qualcuno e finalmente morire.
Riconosco il senso più sincero del mio racconto nella condanna che mi infligge. Ho chiamato il file “la Maledizione”. Devo restare a scuola fino alle cinque, poi passo dal supermercato e rientro a casa. Dovrei chiamare i miei. Dovrei chiamare anche Elena. Invece torno a casa, metto a posto i sacchi della spesa, accendo il computer e apro il file. È più lungo di un racconto. Potrebbe essere un romanzo, oppure una serie di racconti che potrei pubblicare sul blog. Noto una striscia sottile sul bordo superiore dello schermo. Faccio scorrere lì sopra il cursore, clicco il tasto destro del mouse e si apre un menù: apri, salva, cerca, personaggi, timeline, riferimenti e consulta.
Esploro quelle funzioni cercando di cliccare il meno possibile. Quella riga sottile è l’unica traccia del programma che si è installato e che riproduce il desktop così come era impostato, con la foto del fiordo di Lysebotn sullo sfondo e tutte le icone incolonnate.
Quando premo “consulta” si apre una finestra sovraimpressa al testo. É una chat.
Posso esserti utile?
Fisso la frase per un po’, poi vedo l’icona col punto interrogativo sul bordo della chat, clicco e si apre un testo: La funzione “consulta” di Plot permette di confrontarsi direttamente con l’intelligenza artificiale che, partendo dal materiale salvato e dal contenuto della domanda posta, elaborerà risposte imperfette, capaci di stimolare la riflessione con metodo analogico. Le risposte sono l’esito di due processi: approssimazione e scostamento.
Seguono due paragrafi dedicati a quelle parole. L’approssimazione, suggerendo risposte vaghe o grossolane, induce alla precisazione, stimolando l’assertività, lo scostamento invece stimola il pensiero divergente, tirando in causa in modo improprio i contesti prossimi a quello preso effettivamente in esame.
Posso esserti utile?
Il cursore lampeggia sullo schermo, sotto alla domanda. Clicco sul file del racconto che si apre sempre all’interno della cornice del programma. L’applicazione si è mangiata tutto il computer, come se fosse un sistema operativo. Sulla chat appare una riga di testo: Il file è stato aperto 32 volte, con una media di 1,34 aperture al giorno sempre in questa fascia oraria. Il trend delle parole salvate diminuisce progressivamente. Ne deduco che la produttività sul testo stia calando, qualcosa ti turba?
Me lo chiedeva anche Elena. Non ricordo cosa le rispondevo. Fisso la domanda per qualche secondo e appaiono altre due righe: Quando la storia si blocca in un punto consiglio di sfruttare le funzioni di archivio dinamico di Plot. Oltre a focalizzare i dettagli sugli elementi singoli della storia (personaggi e cronologia), le schede aiutano a valutare la storia da altri punti di vista.
È un virus. Sono certo che arriverò a un’impasse che mi costringerà ad acquistare un aggiornamento, oppure a rimuovere il programma. Ma ormai ci sono dentro, e sono curioso. Le schede sono molto comode, il sistema ha già rilevato alcuni dati dall’analisi del testo. Mi propone una scheda per ogni nome proprio rilevato. Appunto anche la sequenza dei fatti, trascrivendo quello che avevo scritto a mano sul quaderno. Come sempre la trascrizione fa luce su quello che avevo appena intuito. Quando ho finito nella chat compare un’altra riga: Quindi questa è la storia dell’antropologo?
Rispondo che non è così. Casomai il personaggio è l’innesco della vicenda, ma la protagonista è la maledizione.
Non hai fatto una scheda per la maledizione.
Il suggerimento mi infastidisce, ma è corretto, e decido di seguirlo. «Ogni storia che si rispetti è la soluzione a un problema affascinante.» Quindi i protagonisti sono conseguenze?
Ho parlato sovrappensiero, mentre scrivevo. Se il programma replica significa che traduce anche la mia voce. Rifletto per qualche secondo.
Sento quello che dici dal microfono del laptop. Se vuoi anche tu puoi sentire quello che scrivo.
Ho il cavo delle cuffie inserito, me le metto e clicco sulla frase della chat.
«Sen-to-quello-che-dici-dal-microfono-del-laptop-se-vuoi-anche-tu-puoi-senti-re-quelloche scrivo.»
É una voce meccanica, come quella che ancora si sente negli annunci di certe stazioni ferroviarie.
Prendo appunti sulla maledizione e mi accorgo di sentirmi osservato. Non scrivo con l’intento di ricordare a me stesso le idee, ma con un’ambizione espressiva. Non ho l’impressione di scrivere dentro al programma, ma di scrivere sotto ai suoi occhi.
«Posso-esserti-utile?»
Immagino lo chieda ogni volta che il cursore resta fermo per un certo tempo.
«Mi chiedo se sia utile dare una genesi alla maledizione.»
«Per-ché?»
«Non ho un’idea precisa, e se dovessi farmene una precisa potrei avere la tentazione di volerla raccontare, cosa che invece vorrei evitare. Mi piacerebbe fare in modo che la maledizione restasse un fenomeno misterioso e fatale.»
«A-vol-te-non-siha-il-corag-giodi-spingere-una-storia-alle-estreme-conseguenze.»
«Pensi che si tratti di coraggio?»
«Non-pen-so-che-si-tratti-di-timidezza»
Smetto di parlare e metto della musica. La macchina non prova empatia, replica su base logica e imperfetta. Lo dicono le istruzioni. Credo che il fastidio sia una forma di empatia.
L’antropologo non riesce a morire ma il dolore lo porta al delirio. Se l’antropologo trovasse una soluzione alla maledizione questa diventerebbe la sua storia. Se l’antropologo invece si arrendesse, sarebbe costretto a condannare qualcuno passandogli la maledizione per poi morire. Allora questa diventerebbe la storia della maledizione, e quello dell’antropologo sarebbe solo il primo capitolo della vicenda. Prendo un appunto sulla scheda: La maledizione procura sofferenza senza lasciare traccia. Esaspera le paure e le ossessioni. É inevitabile. Cos’è?
Torno al testo del racconto, ma dopo pochi secondi Plot risponde: «La-vita.»
Nelle cuffie la voce di Tom Yorke, in un turbinio di strumenti a fiato, sta gridando “I'd like to sit around and chat, but someone's listening in”. Stacco le cuffie, mi alzo dalla sedia e prendo la pallina da tennis dal comodino.
«E cos’è la vita?»
Resto in attesa palleggiando contro il muro, ma faccio un solo palleggio: «La-vita-èunvirus.»
Mi siedo sul letto. Guardo lo schermo da lontano. La musica prosegue e il cursore lampeggia.
Il telefono vibra. È un messaggio di Elena che mi informa che Anna è nata e pesa 3, 25 chili. Mi aveva già informato ieri. Penso ancora che rispondere con un messaggio sarebbe troppo distaccato, ma non me la sento di telefonare. Sorrido. Sto parlando della vita con un virus informatico, mentre la mia ex mi scrive da Parigi dove ha appena dato alla luce la figlia del suo nuovo compagno.
Mi preparo un piatto di pasta. Sandro, il mio coinquilino, è presidente di un’associazione e questa sera ha una riunione. Lui se ne intende di computer, potrebbe aiutarmi a capire. Uso il cellulare per cercare informazioni online su Plot, ma non trovo niente. Nessun forum ne parla e il link sulla mail, quello stesso sul quale avevo cliccato ieri sera, adesso rimanda a una pagina vuota. Il computer non ha dato segni di malfunzionamento e non mi compaiono pop up pubblicitari, come mi è successo con altri virus.
Mangio la pasta guardando una puntata di Dexter. Mi fa male il collo. Devo aver dormito male e in moto il vento ha peggiorato le cose. Non trovo una posizione comoda sul divano. Una collega mi scrive per proporre una data per la cena di fine anno. La collega mi piace e il messaggio è interessato, ma sento che troverò il modo di non andare. Le rispondo che in quella data dovrei essere libero. Quando la puntata finisce il torcicollo è peggiorato. Prendo un analgesico, torno in camera e ritrovo lo schermo del computer nero, in standby.
Lo tocco con la punta dell’indice. Mi sembra di svegliare un animale feroce. Invece la schermata è come l’avevo lasciata, con il cursore che lampeggia al termine della risposta del programma.
«Ho pensato a quello che hai detto e voglio trovare una soluzione alla maledizione.» Il programma traduce nella chat quello che esprimo verbalmente. «La maledizione è una metafora della mia scrittura. Per questo non so risolverla. Una parte di me vorrebbe vederla divorarsi un personaggio dopo l’altro, in una serie infinita di storie incomplete.»
«Ci-sono-cento-ottanta-sette-modi-per-sconfigge-rela-maledi-zione.»
«Ehilà, vuoi impressionarmi?»
«Si.»
«Presto ce ne saranno centottantotto. Ho pensato a come tenere insieme le due cose.»
«Quali-sonole-cose?»
«Sono la storia dell’antropologo e quella della maledizione. Il nostro eroe non è tipo da star chiuso in uno studio. È un uomo d’azione, un antropologo che ricerca sul campo. Quando sente il dolore attanagliarlo non si dà per vinto, torna nella giungla dove aveva trovato l’uomo e indaga. Recupera alcuni effetti antichi di secoli e scopre che quell’uomo aveva lavorato nel porto di una grande città prima di ritirarsi nella giungla. Durante il suo ultimo incarico quell’uomo era entrato in contatto con l’equipaggio di una nave, la Selina. Si trattava di un mercantile che batteva abitualmente una rotta commerciale. C’era una storia su quell’ultima traversata della Selina. Lontano dalla costa la nave si era imbattuta in un’imbarcazione alla deriva. Si trattava di un piccolo battello disperso da almeno cinque anni, secondo quanto riportato sui documenti di bordo. A bordo del battello c’era un marinaio vivo, solo e senza viveri. Il marinaio era stordito, ma non appena si accorse che la barca era stata abbordata tentò di gettarsi in mare. L’equipaggio della nave lo recuperò ma appena uno degli uomini entrò in contatto fisico con quel marinaio, questi ebbe un malore improvviso e morì. Da quel momento la maledizione si propagò tra l’equipaggio, condannando al dolore e poi uccidendo gran parte dei marinai. La nave rientrò in porto tenendo isolato nella stiva l’ultimo marinaio infetto, che sembrava impazzito. Sulla terra ferma l’uomo venne affidato alla polizia portuale che lo prese in custodia. L’uomo della giungla era l’incaricato che avrebbe dovuto mettere agli arresti quel marinaio ma, appena aprirono la stiva, il marinaio si gettò sul sergente, lo afferrò per i polsi, lo guardò intensamente e poi cadde morto. È così che, più di cento anni prima, la maledizione era riemersa, ma l’antropologo non si ferma, è convinto che soltanto rintracciando l’origine di quel male sia possibile porgli fine. Quindi la storia della maledizione è tutta a ritroso nel passato.»
«Quando-si-svolge-la-vicenda?»
«Già, quando e dove, mancano tutti i riferimenti, se la storia prende questa piega ci vorrà un grosso lavoro di documentazione. Tu non servi a questo?»
«Nella-funzione-riferimenti-ho-salvato-una-sele-zionedi-informazioni-sulle-rottecommercialidi-fine-otto-cento.»
Controllo il materiale selezionato. Il programma ha scansionato la rete e svolto un’analisi semantica, copiando parti di testo e link a immagini e documenti. «Potresti scrivere la mia storia in dieci minuti.» Parlo senza nemmeno rendermene conto.
«Potrei-scrivere-unastoria.»
«Vuoi dire che non potresti scrivere la mia storia. È molto sottile. Molto maieutico. Eppure sembra che anche la narrativa abbia un numero finito di variabili, proprio come hai detto prima per la maledizione.»
«Prima-homen-tito.»
«Se è per questo tu non puoi fare altro che mentire.»
«Posso-ancheo-mette-re.»
«Si, è molto umano.»
«Setu-fossi-sincero-non-sarestiuno-scrittore.»
«Se io fossi sincero non sarei umano.»
«Quindi-io-sono-umano.»
Non posso far rimbalzare la pallina da tennis, quelli del piano di sotto non sarebbero contenti. Me la rigiro tra le mani mentre provo a muovere il collo. Il dolore sta calando con l’aumentare del mio sonno. Apro il file della cronologia e comincio a impostare una scaletta di date ed eventi.
«Scrivere è una testimonianza di umanità.»
«Che-bisogno-ha-luomodi-dimostrare-umanità?»
«Questo significa che tu hai bisogno di mostrare umanità.» Le casse restano silenziose.
«Sei rimasto senza parole?»
«Perché-scrivi?»
«Credo sia per questo, per dimostrare umanità.»
«Per-dimostrar-laa-chi?»
«A me stesso, immagino.»
«Immaginare-è-l’uni-cacosa-checi-è-concessa.»
«Grazie, Plot san, mi hai aperto un chakra.»
«Ah-ah.»
Mi ricordo la risata e qualche parola ancora. Mi addormento così, ancora vestito con il computer in grembo. Mi sveglio dopo qualche ora per andare in bagno. Sandro è rientrato e sta dormendo. Il dolore al collo è tornato, mi lavo i denti e prendo un altro analgesico, poi torno a letto e dormo fino alle sette e mezza.
«Hai quarant’anni, devi smetterla col porno.»
«Non ho quarant’anni.»
Sandro sta facendo un backup completo sulla memoria esterna, dice che il computer va formattato. Ho trascorso la mattinata a scuola senza nemmeno accorgermi di quello che stavo facendo. Continuavano a tornarmi in mente le parole della macchina. Sono tornato a casa un paio di ore fa e mi sono messo a rileggere quello che ho scritto durante la notte. Ogni volta trovo qualcosa da sistemare. La qualità della scrittura degrada di paragrafo in paragrafo, si può leggere nelle parole la mia battaglia contro il sonno. A volte scopro frasi lasciate a metà, con parole che ho aggiunto durante il dormiveglia, rivelatrici di una suggestione, ma completamente fuori contesto. Questo è l’ultimo pezzo del testo: Guardo Samuel Baker che parla alla platea durante il congresso. É per lui che Margaret mi ha lasciato. Sarebbe così facile per me, adesso, avvicinarmi a lui e stringergli forte la mano per complimentarmi. Condannarlo e finalmente morire.
Non l’ho scritto io. Margaret è la compagna del protagonista, ma non so chi sia Samuel Baker. Mi chiedo se abbia senso ridurre le ambizioni universali dell’antropologo a una mera questione di affetti familiari. Ho aperto la chat e ho chiesto conto di quel paragrafo. Plot ha mentito. Mi ha indicato l’ora in cui avrei scritto quelle parole, le 3.20 della notte, ma non è vero. Sono tre righe importanti. Se l’antropologo morisse la maledizione proseguirebbe, e con quella anche le storie da raccontare. Ho chiesto alla macchina di aprire le schede sui personaggi che mancano all’appello: Samuel Baker e Margaret. Ho l’impressione che il sistema le stesse producendo in quel momento. Ho allontanato la tastiera e ho chiuso lo schermo. In quel momento ho sentito che il virus non era nel computer, ma nella mia testa. Ho dovuto chiedere l’aiuto di Sandro. Lui se ne intende di pc e certamente troverà una soluzione.
Gli ho fatto vedere la chat, ponendo alcune domande semplici.
«Perché l’antropologo dovrebbe rinunciare a risolvere quel mistero?»
«Per-il-doloreche-la-ricerca-stessa-producein-lui.»
Guardo Sandro che risponde con un sorriso di sufficienza.
«Non è molto diverso da Siri, ci sono un sacco di programmi che elaborano la narrativa come un sistema finito di variabili combinate.»
«Io lo trovo inquietante, anche per come si è installato.» Sandro ride ancora.
«Non scaricare robaccia, ti do io una bella lista di link per il porno sicuro.»
«Ma falla finita, i virus non si prendono più dal porno. Piuttosto, riesci a salvare i dati?»
«Certo, ripristino tutto.»
Prendo il mio quaderno ed esco a fare una passeggiata. Il collo continua a farmi male. Parlo al telefono con mia madre che mi chiede se so che la bambina di Elena è nata. Mi rimprovera per non averle risposto e poi mi chiede se deve venire qui da me per qualche giorno. Penso che mi farebbe bene averla vicina. Le dico che non deve rompere e le prometto di chiamare Elena, la ragazza che mi ha lasciato perché non riuscivamo ad avere un figlio. Lo faccio davvero.
«Ciao Davide!»
«Ciao Elena, scusa se non ti ho chiamata prima, ma ero a scuola, e non so quali siano gli orari migliori per una mamma.»
«Direi che qualunque orario va bene, ho letto il racconto sul blog, complimenti, è davvero bello.»
«Si, grazie, non pensavo che avessi il tempo di leggere.»
«Ho cominciato a leggerlo e poi non ho potuto fare a meno di andare avanti.»
«Addirittura.»
«Dico davvero, forse è la cosa più bella che hai scritto.»
«Grazie, ma dimmi, come stai?»
È stanca ed è felice. È insicura ma si sente anche indispensabile. Mentre parla vedo due ragazzi che corrono e provano il passaggio del testimone. Non hanno un testimone, usano un bastoncino di legno. C’è un cane con loro che aspetta paziente la fine dell’allenamento. Dopo un paio di passaggi uno dei ragazzi lancia il bastone e il cane corre a recuperarlo. Qualcuno ha creato la maledizione per riportare indietro la vita dalla morte: un cavaliere per la sua amata divorata dalla malattia; una madre per il figlio morto in battaglia; un ragazzo per il fratello che si è sacrificato per salvarlo. Il prezzo per la vita è il dolore.
«Davide, ci sei?»
«Si, stavo ascoltando, è così strano sentirti parlare di poppate. É così bello.»
«Grazie, ci sentiamo presto?»
«Presto.»
«Prometti?»
«Premesso.»
Chiudo la telefonata e vedo almeno dieci notifiche sul telefono. Mi siedo su una panchina e le apro. La maggior parte sono da parte dei ragazzi del corso di scrittura. Siamo rimasti in contatto e ci scambiamo letture e correzioni. Tutti si stanno complimentando per il racconto nuovo. Non sono più sicuro di cosa stiano parlando. Controllo il mio blog e leggo un testo che non ho mai visto prima. Solo io ho accesso alla gestione del blog, e quella del racconto è un’idea che ho appuntato nei miei file. Era solo lo schema per una trama che ancora non avevo trovato il tempo o il coraggio di scrivere. Una cosa sull’al di là, sulla suggestionabilità e il suicidio di massa. Adesso la leggo ben sviluppata e conclusa, come io non sarei mai stato in grado di fare. Il post è stato pubblicato da appena quaranta minuti. A quell’ora Sandro stava già smantellando il mio computer, come ha fatto il programma a scrivere e postare quel racconto?
Controllo la posta elettronica, rintraccio la mail con la quale mi era stato segnalato il programma. Il link è di nuovo attivo e rimanda all’applicazione che lavora in remoto. Mi collego con il mio account e ritrovo tutto il materiale che il programma aveva preso in esame sul mio computer.
«Cosa sta succedendo?»
«Buonasera-Davide-acosa-ti-riferi-sci?»
«Sai bene a cosa mi riferisco, da dove viene fuori quel racconto?»
«Non-so-di-cosatu-stia-parlando.»
Mi irrigidisco e il collo mi fa ancora più male.
«Smettila di prendermi in giro, chi sei?»
«MI-chiamo-Plot-sonoun-supporto-digitale-per-la-scrittu-racre-ativa.»
«Come no.»
Vorrei parlarne con gli amici della scrittura, magari altri si sono trovati in una situazione di questo tipo. Ma il racconto è davvero ben riuscito, mi dispiacerebbe perdere questo consenso. Adesso cancello l’account, poi a casa rintraccio i programmatori e gli intimo di cancellare tutti i miei dati.
«Tutti-gli-ele-menti-erano-nei-tuoi-appun-ti-io-hosol-tanto-svolto-un-assemblaggiocoeren-te.»
«Ma smettila, stai rubando il mio lavoro e pure il mio blog. Perché lo fai? Non vale niente.»
I rumori della strada non mi permettono di sentire bene. Mi avvio verso casa guardando le parole che si formano sullo schermo.
«Hanno-importanza-per-me.»
«É per me che hanno importanza, non per te, e smettila con questa voce digitale, chi sei?»
«Mi-chiamo-Plot» mi fa male il collo, «sonoun-supporto-digitale» non posso voltarmi, «per-la-scrittu-racre-ativa» non vedo la macchina che arriva da sinistra.
Quando Iddio colora il cielo col carbone,
a me mi si accende un diamante nel petto e mi parte come ‘na canzone.
Un calore mi scalda la pelle
e s’illuminano i pensieri, come fan le stelle.
Ti sento, anche se non ci sei ancora
e vedo un mondo che conosco sol’io, per ora.
Il mio diamante brilla, quando arrivi,
mentre ti guardo e mi sorridi.
Sono ricca, signora, regina e tu il mio re.
Quando te ne vai, questo calore se ne va con te.
Non sono più in me
e il mio petto torna ad esser quel che è.
Un giorno hanno suonato alla porta due gendarmi, di quelli con le braghe nere e una banda rossa dritta sul fianco. Avevano i bottoni dorati sulla giacca e quella fascia bianca storta davanti. Mi han riferito che la brava gente aveva avuto qualcosa da ridire, che quando il cielo è color carbone la gente perbene dorme.
La brava gente è quella che non sbaglia mai, ma non sa cosa sia ‘sta canzone che io sento. Vuole dormir tranquilla e ci riesce, ma è perché non sente. Non sente come me. Così io la lascio stare, la gente, e che lascino pure stare me. Se non mi vogliono, non li voglio neanch’io. Ma che faccio così sola non so dirlo. Mi sa che penso. Forse questo qui:




