
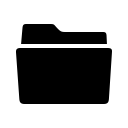
bici (6)
Sicurezza in bici
Scritto da Nicola MuratoreIn questo articolo parlerò della sicurezza sulle strade in relazione ai ciclisti.
La strada ha sempre contato moltissimi morti: che fossero automobilisti, ciclisti o pedoni, la strada risulta essere un luogo pericoloso per tutti. Ultimamente la cosa ha suscitato più scalpore perché sono morti due grandissimi dello sport mondiale: il campione dell’Astana Michele Scarponi[1] e il campione del mondo nel 2006 della MotoGp Nicky Hayden[2].
Entrambi si stavano allenando in bicicletta quando sono stati investiti da un’auto che li ha uccisi. La notizia, come ci si poteva aspettare, ha fatto subito il giro del mondo. Nell’arco di pochissimo tempo i loro volti sono finiti su tutte le copertine, su tutti i telegiornali, su tutti i social, a causa della fama di cui godevano. Per quanto riguarda Scarponi sembra che gli sia stata tagliata la strada da un furgone che, per svoltare a sinistra, ha intercettato la traiettoria del ciclista senza lasciargli il tempo di frenare. Per quanto riguarda Hayden invece, stando a quanto rivelato dalla Polizia dopo aver visionato dei filmati di un impianto di videosorveglianza, il ciclista non si sarebbe fermato ad uno stop e non avrebbe sentito il rumore della macchina che lo ha investito, a causa delle cuffie collegate al suo IPod con il quale ascoltava la musica.
Non voglio scendere nei dettagli dei due incidenti né tantomeno capire chi avesse torto o ragione: quello che mi interessa è portare l’attenzione sulla problematica in generale.
Sono infatti moltissimi i ciclisti che perdono la vita per strada a causa di incidenti e che rimangono nell’anonimato, senza che nessuno ne parli. I dati Istat affermano che, in Italia, sulla strada muore addirittura un ciclista ogni trentacinque ore. E tra questi non solo ciclisti di professione, ma anche amatori, bambini, anziani, mamme e padri di famiglia: insomma, tutti coloro che utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto e non solo chi ne ha fatto il proprio sport preferito.
Il problema è che tutte queste morti passano in sordina e, di conseguenza, il problema non viene mai affrontato. È stato necessario che perdessero la vita grandi atleti come Michele e Nicky affinché le persone prendessero coscienza della pericolosità delle strade.
Partiamo con qualche considerazione generale sul tema. A costo di essere banale ci tengo a sottolineare quelle cose che tutti dovrebbero sapere, ma che fa sempre bene ricordare.
Innanzitutto il casco: fondamentale per qualsiasi spostamento. Dall’uscita lunga al tragitto casa lavoro. Deve essere omologato e ben allacciato. È importante che sia della propria taglia in modo che aderisca perfettamente alla testa. Inoltre è importante che venga sostituito dopo ogni caduta che lo riguardi.
Le luci: devono essere rosse lampeggianti applicate posteriormente e bianche fisse sul manubrio. Permettono sia di vedere meglio, ma soprattutto di essere visti che, come vedremo tra poco, è il problema fondamentale.
Le condizioni della bici: ovviamente le condizioni della bicicletta in sé sono fondamentali per quanto riguarda la sicurezza. Innanzitutto i freni devono essere funzionanti ed efficienti, per cui è consigliabile cambiare periodicamente i pattini. I copertoni non devono essere consumati poiché sono alla base dell’aderenza. Le camere d’aria devono essere ben gonfie per lo stesso motivo.
Sono inoltre obbligatori secondo il Codice della Strada, segnalatori visivi quali catadiottri e acustici come il campanello[3]. Va da sé che chi infrange le suddette regole è perseguibile con diverse sanzioni.
Per quanto riguarda l’uso urbano delle biciclette con il pignone fisso i problemi si moltiplicano: tutti coloro che usano una fissa devono essere ben coscienti che, stando al Codice della Strada, l’uso di bici del genere è perseguibile. Il CDS infatti recita così:
“Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote”.
Da ciò si deduce che non sia lecito usare neppure la classica fissa con il semplice freno anteriore né tantomeno le biciclette con il freno a contropedale[4]: proprio quelle che forniscono i comuni olandesi attraverso il loro sistema di bike sharing. Quindi risulta anche molto importante prestare attenzione a che cosa è tollerato nel paese in cui si utilizza la bicicletta.
A questo punto, dopo questa panoramica sugli obblighi che spettano al ciclista in Italia, vorrei proporre un cambio di prospettiva.
Abbiamo detto che il ciclista mette le luci per farsi vedere dalle macchine. Monta i freni sia davanti che dietro per potersi arrestare quando improvvisamente sbuca una macchina. Inoltre il ciclista deve anche vestirsi con colori fluorescenti per saltare all’occhio degli automobilisti[5]. Deve tenere la destra sulla strada per non intralciare le macchine, ma contemporaneamente deve stare attento alle portiere delle macchine che si aprono sulla sinistra.
Prendendo in considerazione le norme suddette, sembra che il ciclista abbia il dovere di tutelarsi dalle auto e che il vero problema sia che il conducente di un’auto abbia difficoltà a vedere i ciclisti e i pedoni. La visuale di cui dispone un automobilista infatti è limitata dalla carrozzeria che crea punti ciechi e dalla posizione del conducente, molto bassa sul livello della strada. Per questo la frase che sentiamo più spesso dopo un incidente è “non l’ho visto”. Nessuno pensa che gli automobilisti si divertano a schiacciare i ciclisti: la verità è che la visuale di cui dispongono è inguaribilmente limitata. Questa tesi è supportata da uno studio condotto di recente dall’Università degli Studi di Bologna e riassunto splendidamente da Simona Larghetti, Presidente Consulta della bicicletta Bologna, nell’intervento al programma AriaPulita[6]
Mi sento di sottoscrivere pienamente il discorso che fa Simona. Innanzitutto con questo discorso non voglio creare due schieramenti e tantomeno affermare che uno abbia totalmente ragione mentre l’altro totalmente torto. Chi ama andare in bici spesso è costretto ad usare la macchina. E viceversa chi è solito usare la macchina spesso non disdegna un bel giro in bici. Il problema quindi è spostato a monte: si tratta di salvaguardare vite e di evitare di creare fazioni che si fanno la guerra a vicenda.
È vero che alcuni ciclisti sono indisciplinati, non lo si può negare. Ma così come ci sono i ciclisti indisciplinati ci sono gli automobilisti indisciplinati, quindi non è il caso di puntare il dito contro gli uni o gli altri altrimenti si finisce per alimentare quella tendenza già molto diffusa per cui se un ciclista viene travolto è sempre un po’ anche colpa sua (“eh, ma è sbucato all’improvviso”, “ma era in mezzo”, “non teneva la destra” ecc). Dai racconti che ho ascoltato sembra sempre che i ciclisti in un certo qual modo se le cerchino, quando in realtà è chiaro che non abbiano nessun interesse nel farlo. Anche quando sembrano irrispettosi delle norme, spesso è per far fronte alla situazione: se un ciclista sta in mezzo alla carreggiata molto probabilmente è per evitare i tombini o le più pericolose portiere che si aprono all’improvviso. Il ciclista tenta di sopravvivere nella giungla urbana come meglio può.
E qui si apre un altro problema: le città sono sempre più macchina-centriche. Sembra che tutto venga costruito in funzione delle auto[7], senza tenere in considerazione che la carreggiata viene fruita da una pluralità di mezzi. Spesso i viadotti, i sottopassaggi, le strade statali sono vietate alle biciclette. Di conseguenza si è andata affermando la concezione per cui la strada è delle auto, mentre le biciclette sono una sorta di veicolo invasore. Quest’ultime vengono relegate nelle poche piste ciclabili esistenti (quando esistono), o altrimenti considerate un fastidio per la viabilità. In tutto questo la controparte ciclistica è muta. Il ciclista non si lamenta mai degli ingorghi creati dalle auto. Se un’autovettura procede a rilento il ciclista non suona il clacson per intimargli di spostarsi. Ma soprattutto il ciclista subisce l’inquinamento prodotto dalle macchine senza fiatare.
Arrivati a questo punto credo sia chiaro cosa c’è sulla bilancia: da una parte un mezzo a misura d’uomo, a impatto zero, economico ed efficace a livello urbano, che ogni tanto, a causa della distrazione o della poca esperienza del conducente, disturba gli altri utenti della strada; dall’altra parte c’è un mezzo invasivo, inquinante, inefficace a livello urbano, che quando sbaglia non si limita a disturbare, ma uccide. Chi ha più potere di nuocere?
Dico che l’auto è invasiva per diversi motivi. Innanzitutto perché inquina senza preoccuparsi dell’opinione dell’altro. In secondo luogo perché, anche storicamente, l’industria delle automobili ha letteralmente rubato gli spazi dedicati alle biciclette e ai pedoni, monopolizzando poco a poco gli spazi che fino a quel momento erano condivisi[8]. E infine perché è un mezzo con il quale non è facile convivere pacificamente, senza sentirsene minacciati: è un mezzo prepotente. L’onere di rendersi visibile non è del ciclista. Certo, utilizzando le luci, i catarifrangenti e un vestiario adeguato, si facilita il compito agli automobilisti, ma il dovere di fare attenzione è comunque loro, che dispongono di un mezzo pericoloso che va utilizzato con estrema attenzione.
Sembra che le bici e le macchine non possono convivere pacificamente nelle condizioni attuali.
C’è una soluzione a questa situazione? In Italia è stato fatto qualche tentativo maldestro per tutelare i ciclisti, come per esempio rendere obbligatorie le luci, il campanello e quant’altro. Si è addirittura pensato di rendere il casco obbligatorio.
Nei paesi scandinavi, dove la cultura della bicicletta è molto più radicata e l’attenzione per l’ambiente una delle priorità attuali, a tutti è scappato un sorriso per le nostre soluzioni che appaiono più come espedienti per lavarsi la coscienza. Una soluzione come quella di rendere il casco obbligatorio disincentiva terribilmente l’uso della bicicletta oltre al fatto che non previene gli incidenti, ma si limita a diminuire l’entità del danno. E se l’obiettivo è ridurre l’inquinamento e permettere una pacifica convivenza tra i diversi mezzi di trasporto questa è l’ultima cosa da fare. È necessario incentivare l’uso della bici (senza renderne la pratica complessa e difficile attraverso numerosissime norme) e dunque permettere ai ciclisti di spostarsi in sicurezza. Per fare questo le soluzioni sono due: in primo luogo creare spazi dedicati alle biciclette quali parcheggi e piste ciclabili; in secondo luogo disincentivare l’uso degli autoveicoli e contribuire a renderli più innocui attraverso leggi più severe e precise. Questo tuttavia risulterebbe inutile senza una conseguente sensibilizzazione degli automobilisti al tema e un cambio radicale di paradigma per cui al primo posto non c’è più la comodità o la fretta di arrivare a destinazione, ma la sicurezza e la cura di chi è più esposto di noi ai pericoli della strada. Per promuovere una sensibilizzazione di tal genere consiglio il documentario “Bike VS Car”, che amplia e approfondisce il rapporto che è andato instaurandosi tra le biciclette e le auto.
[1] http://www.gazzetta.it/Ciclismo/22-04-2017/morto-michele-scarponi-vittima-tragico-incidente-stradale-filottrano-190903631920.shtml?refresh_ce-cp
[2] http://www.repubblica.it/sport/vari/2017/05/22/news/hayden_morte_incidente-165755786/
[3] http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-iii-dei-veicoli/art-68-caratteristiche-costruttive-e-funzionali-e-dispositivi-di-equipaggiamento-dei-velocipedi.html
[4] Una bici a contropedale ha un freno a tamburo integrato nel mozzo posteriore. La frenata si attiva spingendo i pedali all’indietro di circa un quarto di giro e pigiando di più o di meno in base alle esigenze, come si fa con le leve al manubrio.
[5] Leggendo il CDS è infatti obbligatorio anche il giubbino retroriflettenti ad alta visibilità.
[6] [6] https://www.youtube.com/watch?v=IqKOmzAZF6I
[7] https://www.facebook.com/Curbed/videos/1388062541243671/?pnref=story
L’articolo di questa settimana è un po’ particolare, soprattutto perché non ha la forma descrittiva di un evento o di un componente, bensì è un’intervista. Vi presento una persona che ho avuto il piacere di conoscere anni addietro e che probabilmente alcuni lettori già conosceranno.
Riky, al secolo Riccardo Volpe, è un volto noto della scena ciclistica italiana e non. Classe 1976, è uno di quelli che ne combina di tutti i colori da parecchi anni, uno degli incorreggibili che hanno tenuto duro e che pedalano da quando la mia generazione era ancora in fasce. Non ha un vero e proprio habitat naturale: lo si può trovare in un velodromo come su strada, ma anche nei boschi, su strade sterrate, ghiaiose o acciottolate.
N: Riky, raccontaci i tuoi primi approcci con il mondo del ciclismo. Quando hai iniziato e con che bici?
R: A parte l’infanzia, sono capitato per età nel momento esatto dell’esplosione del fenomeno mountain bike in Italia. Tutti sognavano la Cinelli Rampichino ed io all’epoca mi accontentai di una buona mtb (un milione di lire dell’epoca eran tanti soldi). Pensa che il telaio ce l’ho ancora oggi e l’ho convertito da passeggio! Bici pesantissima ma ottima e con acciaio di qualità. Con questa bici assaporai le prime avventure in montagna; all’epoca abitavo in alta Valsusa. Un giorno mio zio Paolo mi portò con lui a fare un giro con la bici da corsa; mi prestò una sua vecchia bianchi, ovviamente non della mia taglia, 5 rapporti e 42 come corona più piccola! Beh, che tu ci creda o meno, ho ancora perfettamente in mente ogni attimo di quel giro: la scorrevolezza dei tubolari, la facilità con cui prendeva velocità rispetto a quel carrarmato di mtb, la sua leggerezza a confronto della mia bici mi fecero innamorare! Da allora a momenti alterni non ho più smesso di pedalare, ma diciamo che è negli ultimi dieci anni che la passione ha preso il sopravvento su tutto o quasi.
N: Come è cresciuta e come si è sviluppata la vera passione per il ciclismo? Come definiresti la strada che hai intrapreso oggi?
R: È cresciuta proprio in questi ultimi dieci anni, complice un trasferimento per lavoro e un ritrovato tempo libero, qualche amicizia giusta che rinvigorisse la fiamma della passione e la costanza nel pedalare che ha portato a riscontrare i primi progressi. Il bello non è tanto andar forte, ma piuttosto pianificare un giro lungo quanto vuoi e con quanto dislivello vuoi e non aver timore di portarlo a termine e di divertirti nel farlo. Ecco questa è la grande dote che l’allenamento ti dà. Oggi ho ancora tantissima curiosità per le cose che si possono fare in bici, non ho voluto focalizzarmi su nulla in particolare proprio per tenermi aperte tutte le possibilità, sia nei giri in scatto fisso sia nelle avventure su strade ghiaiose e polverose. Ecco, qui sta un po’ la nuova frontiera (abilmente fiutata dal mercato ciclistico infatti) in cui intendo sfidare me stesso. Una piccola avventura di più giorni sulle strade sterrate delle Alpi Occidentali che sento molto “mie”, ma abbiamo tempo per parlarne ancora!
Potreste chiedervi perché ho scelto proprio Riccardo per questa intervista. Ve lo spiego subito. Innanzitutto è una persona squisita. L’ho conosciuto circa tre anni fa, durante un’uscita in bici organizzata da alcuni amici in comune. Io ero ancora alle prime armi e quell’uscita mi rimase impressa per due motivi in particolare: il primo perché feci una fatica che provai poche altre volte nella vita; la seconda per la disponibilità e la gentilezza di Riccardo. Ricordo che gli altri amici mi avevano raccontato alcuni aneddoti su di lui, tra cui la collaborazione con Cinelli e la sua carriera in circuito, per cui io me lo ero figurato come un professionista con la puzza sotto il naso, spocchioso e superbo come molti altri ciclisti con cui avevo avuto a che fare. Niente di più sbagliato. Riccardo è tutto il contrario: è disponibile, paziente, umile e alla mano. Nonostante le sue ottime prestazioni non si è mai montato la testa, è schietto e semplice e diretto, mai megalomane o egocentrico. Credo che mi abbia colpito proprio per queste sue caratteristiche.
Dopo quell’uscita abbiamo fatto passare molto tempo prima di rivederci, anche perché io nel frattempo mi ero trasferito a Bologna. Tuttavia, una volta tornato a Torino, abbiamo riallacciato i rapporti. Prima era solo una fonte d’ispirazione, ora è innanzitutto un amico.
N: Scommetto che non sapevi nemmeno tu di questi retroscena! Ti ci ritrovi? Ti ho descritto bene oppure ho preso un granchio?
R: Beh, hai esagerato! Alla fine, da buon ciclista, ci tengo sempre a far quel pizzico in più degli altri. Però amo condividere quel poco di esperienza che mi sono fatto, veder crescere gli amici in questa passione mi gratifica moltissimo!
Da questa amicizia deriva anche questa collaborazione. Ebbene sì, è ufficiale: Riky sarà l’autore della prefazione del mio libro Mess Life che uscirà per Jona Editore. E questo è il secondo motivo per cui abbiamo deciso di intervistarlo. Iniziamo a farci un po’ di fatti suoi per davvero.
N: Il ciclismo, come lo intendi tu, è sicuramente un modo per divertirti. C’è qualcosa di più? Ti sei prefissato degli obiettivi? Quali sono i motivi per cui lo fai?
R: Assolutamente! Il divertimento deve essere alla base di tutto; lo stare bene nel momento esatto in cui stai facendo quella cosa è fondamentale. Per quello non mi prefiggo obiettivi, nel senso non mi dico ad esempio “voglio arrivare nei primi 5 in quella tal gara” ma bensì cerco di dare sempre il meglio di me e mi alleno proprio per avere di anno in anno più consapevolezza di quel che mente e corpo possono fare insieme. I motivi? Ti rispondere alla Walter Bonatti, il celebre alpinista, quando gli chiesero che gusto c’era nello scalare una montagna, e lui riposte semplicemente “perché è là.” Ecco, credo che si vada in bici perché ci sono al mondo talmente tante strade magnifiche che provare a percorrerne una gran parte credo sia un nostro dovere morale. E la bici è quel magico mezzo di locomozione che ha la giusta velocità per farti apprezzare quanto ci sia di bello in questo piccolo pianeta. N: Non hai mai pensato di volerne fare la tua principale attività? Secondo te si può ancora vivere di ciclismo?
N: Non hai mai pensato di volerne fare la tua principale attività? Secondo te si può ancora vivere di ciclismo?
R: Cavolo, questa è una domanda spinosa, un po’ come chiedere cosa vorrai fare da grande. Sì certo, mi piacerebbe moltissimo far sì che la mia passione diventasse una occupazione a tempo pieno, ma per le ragioni che ti ho detto prima, e per quelle ovviamente anagrafiche, non credo che il ciclista professionista sia mai potuto esser nelle mie corde. Diversamente il raccontare e saper fotografare le bici bene come un certo John Prolly, beh, ecco sì, quello mi piacerebbe tantissimo, chissà.
N: Sicuramente quello del ciclismo non è un mondo semplice. Ci vuole tanta dedizione, sacrificio e determinazione. Che cosa ti spinge a farlo? In che modo vengono ripagati gli sforzi che fai?
R: Iniziamo con il dire che sì è un sacrificio, ma che assolutamente non pesa! O meglio, i primi 20 minuti dopo una gara od un allenamento particolarmente duro dici: “No, mai più”, ma poi subito dopo inizi a pensare a cosa poter altro fare in sella… quindi è più la dedizione che non il sacrificio. Tutto viene semplicemente ripagato dai sorrisi che vedo alla fine delle gare con le facce da ormai tanto tempo amiche oppure, quasi meglio, quando a qualche criterium vengo avvicinato da ragazzi giovani che mi dicono che grazie a quello che scrivo e faccio anche loro hanno iniziato andare in bici, fissa o meno che sia. Ecco questa è davvero una enorme gratifica ma nel contempo mi spinge a voler fare ancora meglio. Altra cosa è avere la possibilità di collaborare con aziende di peso come Garmin, Cinelli/Columbus e Sdam che mi supportano molto nelle semplici cose che faccio e sono il motore per la mia curiosità anche dal punto di vista tecnico e dei materiali. N: Raccontaci come sei giunto a collaborare con dei brand così importanti.
N: Raccontaci come sei giunto a collaborare con dei brand così importanti.
R: Con Cinelli c’è una storia tutta particolare. Venivo dalla splendida esperienza del primo anno del Cykeln Racing Team con cui corsi una splendida stagione di criterium e fummo contattati proprio dall’azienda che, dopo anni a dominar le vendite sullo scatto fisso, voleva approntare anche una buona squadra corse. Da lì ci furono un po’ di peripezie e, per motivi di tempo e gamba (ammettiamolo pure), mi fu proposto di essere non un corridore del team ma un “brand ambassador” come si usa dire oggi, ovvero un portavoce e sostenitore del marchio. Questo ha comportato per me molta più libertà di movimento per unire quelli che erano i miei progetti personali nell’ambito dello scatto fisso e il loro grande supporto. Per gli altri marchi che ti ho citato, invece, tutto nasce dal mio blog personale e dal voler raccontare quello che è la mia visione di ciclismo. Per prima mi contattò l’agenzia di comunicazione della Trek, con cui nel 2015 ebbi una splendida esperienza alle strade bianche a Siena. Poi, tramite la medesima agenzia, entrai in contatto con gli altri marchi del settore.
N: Ti alleni secondo un programma o pedali solo quando ti va?
R: Anche qui la risposta è un po’ difficile; diciamo che raramente se sono in bici da solo riesco a risparmiarmi, proprio per questa continua sfida con me stesso che ogni volta mi spinge a dare tutto. Nella brutta stagione cerco almeno una volta a settimana di fare un’uscita nella nostra classica zona industriale a Torino e fare un po’ di esercizi specifici come rilanci e partenze da fermo. Ma mi limito a quello! Diversamente su di un percorso collinare o montano è già la natura stessa dell’itinerario a farmi fare le variazioni di ritmo classiche che ogni allenamento dovrebbe comportare.
N: Quali sono i percorsi più belli che hai fatto e i paesaggi migliori che hai visto? Consiglia ai lettori qualche itinerario che ti ha colpito maggiormente.
R: Sai, alla fine sono molto legato alla mia terra e alle sue montagne quindi non posso raccontarti qui di grandi viaggi in terre lontane. Trovo quasi tutto quello che mi serve proprio qui a pochi chilometri da casa. Uno dei percorsi più belli è senza dubbio la via dell’Asietta, da fare con una bici da ciclocross/gravel, sono molto legato a quelle salite e quelle montagne ed è comunque un giro accessibile con un minimo di allenamento. Anzi, tieni d’occhio il blog perché anche se in questi giorni ha nevicato, sto organizzando un group ride proprio su quelle strade che saranno, tra l’altro, le prime parti del Torino-Nice rally di settembre. N: Quando sei al limite della sopportazione della fatica a cosa pensi per andare ancora avanti?
N: Quando sei al limite della sopportazione della fatica a cosa pensi per andare ancora avanti?
R: A volte la soluzione è proprio far l’opposto, cercare di non pensare a nulla! Provare a concentrarsi sullo sforzo, sul sentire le gambe che spingono e tirano sui pedali, e pensare che ogni giro di pedale fatto è un giro in meno di pedale da fare. Quando il corpo va in riserva ho trovato che è meglio che anche la mente non sia troppo in agitazione e si concentri su cose molto elementari ma essenziali. Ecco, di solito funziona.
N: Purtroppo sappiamo entrambi quanto sia pericoloso il ciclismo. Come ti relazioni con il pericolo? Che consigli ti senti di dare a chi non utilizza la bici, anche a livello urbano, per paura delle automobili? E agli automobilisti?
R: Be’, ormai le cronache sui giornali non riescono nemmeno a far notizia se l’investito non è un personaggio noto, e invece sai bene che è un vero e proprio eccidio. Ci vuole un mix di fattori nello stare in bici in città. Io comunque cerco di andarci tutti i giorni per non perdere quella coordinazione a tre occhio-mente-corpo che trovo essenziale. In primo luogo dico una cosa che in realtà è la più difficile da attuare: non avere paura! Essere sicuri di quello che si fa ed esser determinati nel fatto che le biciclette così come i motorini e le auto hanno pari dignità nel poter stare in strada: questo è il primo passo. La seconda cosa è farsi vedere: in primis con poca luce sono necessarie sempre luci a led belle luminose e intermittenti. Poi farsi vedere nel senso che nel 90% tenere strettamente la destra (come vuole il codice della strada e come desiderano la totalità degli automobilisti che ci sorpassano) è la mossa meno idonea e si capisce molto semplicemente il perché. Primo perché la prima portiera che si apre son dolori o peggio; la seconda è che negli incroci e nelle immissioni delle auto, se il ciclista è un po’ più verso il centro della sua corsia risulta molto più visibile anche da un automobilista distratto e questo a volte fa la differenza! Se vi suonano per passare fate gli gnorri e intavolate un paio di frasi nella lingua straniera che meglio conoscete, funziona quasi sempre.
N: So che hai un blog molto seguito e che per un periodo hai scritto per Cykeln. La tua è una semplice voglia divulgativa? Come mai hai iniziato a scrivere?
R: Ritengo che l’aprire un blog sia stato semplicemente una delle idee migliori della mia vita. Avevo appena cambiato lavoro e mi ero finalmente ritrasferito a Torino dopo due anni a Milano. Avevo voglia di creare uno spazio web mio semplicemente per fissare nella memoria una serie di ricordi che temevo si cancellassero. Alla fine si è rivelata una valvola di sfogo fantastica e mi sono ritrovato letteralmente affamato di scrivere e raccontare le emozioni che provavo quando ero in sella… ed ecco qui la crescita negli anni (ormai sei) del mio piccolo blog.
N: Immagino che molto spesso ti sia trovato a contatto con i corrieri in bici della tua Torino. Cosa pensi di loro e del loro mestiere che poi è il tema principale del mio libro per cui scriverai la prefazione?
R: In realtà conosco personalmente quasi tutti i corrieri di Milano, che nascevano ed iniziavano a camminare sulle loro gambe proprio nel periodo in cui io ero lì per lavoro. Innanzitutto voglio dire che, a mio avviso, è una delle leve attraverso la quale si possono rendere migliori le nostre città. Poi negli anni ne ho apprezzato la loro evoluzione, ora finalmente sono vere e proprie aziende con una loro struttura e flessibilità a seconda dei modelli di business che si vanno affermando. Questo è una vera svolta e rende chiaro che, anche se si è passati per quella fase, ora le compagnie di corrieri non possono più esser fatte da tre ragazzi con le proprie bici ed un telefono, ma serve porsi sul mercato affinché ai grandi clienti convenga scegliere dei corrieri in bici rispetto a quelli tradizionali. Dal punto di vista dei lavoratori del pedale li stimo moltissimo, è un lavoro duro e ci va molta testa per reggere quei ritmi e per aver la costanza di restare sei ore nel traffico anche quando piove, anche quando le strade sono ghiacciate e fa buio alle 17.
N: Sei contento di contribuire a questo progetto? Pensi possa servire a qualcosa?
R: Questo progetto pensa possa esser utile come porta di accesso ad un mestiere, proprio per la capacità del libro di definire tutti i contorni di una professione vera e propria! Quindi, ok i riflessi di immagine e stile di vita, ma come altri lavori (e forse anche di più) per fare il corriere in bici ci va davvero una passione e dedizione al di sopra della media e penso che l’opportunità di avere un quadro così ben raccontato sia perfetto sia per far capire agli indecisi che non è un’occupazione semplice (magari per chi è in cerca di altro), e sia per chi è titubante a dar la classica ultima spallata e a tuffarsi nel mondo dei corrieri in bici ed entrare dalla porta principale nel ciclismo urbano.
N: Perfetto, grazie mille per l’intervista e adesso mi raccomando: buona presentazione!
1 aprile 2017: la sveglia suona relativamente presto per i miei standard; sono le otto del mattino e oggi è un giorno speciale per il quale molti amanti dello scatto fisso stavano facendo il conto alla rovescia già da tempo; oggi si corre la Respublica superiorem II .Il mio corpo capisce che quello sarà un giorno particolare quando per colazione gli viene servito un piatto di pasta scondita (i consigli del mio buon vecchio coach Carratta non vanno mai trascurati). Devo ancora preparare un sacco di cose in previsione della trasferta.
.Il mio corpo capisce che quello sarà un giorno particolare quando per colazione gli viene servito un piatto di pasta scondita (i consigli del mio buon vecchio coach Carratta non vanno mai trascurati). Devo ancora preparare un sacco di cose in previsione della trasferta.
La Respublica superiorem è infatti una gara per biciclette a scatto fisso rigorosamente senza freni (brakeless) che si tiene a Genova. La prima gara di questo tipo fu organizzata nel 2014 dai ragazzi di Zenadrome[1]. L’evento fu un successo, ma, l’anno successivo, per motivi non molto chiari, non ebbe luogo. Nel 2015 molti membri di Zenadrome si allontanarono dalla crew, molti altri si avvicinarono ad essa. I ragazzi di Rapallo, della crew TBTW[2], che già in precedenza gravitavano intorno alla scena delle bici fisse presero le redini della situazione e, dopo qualche riassestamento all’interno del gruppo, diedero vita a quello che attualmente è la colonna portante dello scatto fisso in Liguria: SCVDO Genova[3]. Nel 2016 si ebbe quindi la prima edizione di Respublica Superiorem, una gara unica nel suo genere: non è una vera e propria alleycat[4] poiché il tracciato ci era già noto in precedenza. Non è una criterium poiché non si corre in un circuito, non è neppure una velocity perché in parte la si corre nel traffico e in salita. Insomma, un mix di caratteristiche proprie solo ed esclusivamente di questa gara (una gara simile può essere la Fat Ass torinese). Per questi motivi la gara ha mobilitato ciclisti da ogni dove, molti dei quali aspettavano di misurarsi nell’impresa dall’anno precedente.
Nel mio caso invece è la prima volta che decido di sfidare il dislivello della mia terra natale. L’impresa sembra essere tutt’altro che semplice: siamo già stati messi in guardia dai ragazzi di SCVDO che dovremo percorrere circa 50 chilometri totali, di cui molti in salita per un dislivello complessivo di circa 1500 metri, altrettanti in discesa e una parte minore nel traffico cittadino. Per questo comincio a ingurgitare carboidrati fin da quando apro gli occhi, in modo da digerirli in tempo per la partenza e avere così energia a rilascio lento durante la gara. Il meteo ci è favorevole: si preannuncia una bellissima giornata. Infilo un paio di pantaloncini e una maglietta e sono pronto a partire. Metto giusto un ricambio nello zaino e gli attrezzi per settare la bici e sono in sella. Devo raggiungere il mio fido compare Marco e andare con lui a Stupinigi, dove ci aspetta Riky che ci traghetterà con la sua spaziosissima auto fino a Genova. Mettiamo la mia bici sul tetto e le altre due smontate nel bagagliaio e ci prepariamo al decollo.
Il viaggio è tranquillo e scorre veloce grazie alle chiacchiere. Nessuno di noi sembra essere teso per l’evento; più che altro felici e impazienti di misurarsi con gli altri biker su un tracciato così particolare.
Cargo, uno stile di vita
Scritto da Nicola MuratoreDopo aver trascorso una settimana di ferie tra Svezia e Danimarca ho deciso di scrivere un articolo sulle cargo bike, una realtà sempre più presente anche in Italia, ma decisamente più sfruttata all’estero.
Figura 1 Una Short John moderna.
Sono biciclette molto particolari, finalizzate al trasporto di oggetti ingombranti.
Ripercorrere la storia delle cargo bike non è semplice. C’è da dire che con il termine “cargo bike” ci si riferisce a svariati modelli di bici creati con questo fine.
Le prime di cui si ha testimonianza risalgono all’inizio del secolo scorso ed erano presenti soprattutto in Olanda, Inghilterra e Danimarca, la loro terra madre. La cosiddetta Short John, può essere considerata a tutti gli effetti l’antenata delle moderne cargo bike. Era una bici di piccole dimensioni, con le geometrie molto simili a quelle di una bicicletta classica. Ciò che la contraddistingueva era però il ruotino anteriore che permetteva di ospitare un carico maggiore sul portapacchi che veniva montato davanti.
Figura 2 Una Long John risalente agli anni '20.
Successivamente, negli anni ’20, iniziarono a circolare in Danimarca le Long John: la ruota anteriore, anche in questo caso più piccola della posteriore, veniva posizionata molto distante dal conducente, in modo da lasciare lo spazio, tra il manubrio e la ruota stessa, per il pianale destinato al trasporto delle merci. Altre volte, ma in numero decisamente più esiguo, il pianale è stato creato allungando il carro posteriore, in modo da mantenere inalterata la reattività dello sterzo.
All’epoca queste cargo bike erano utilizzate soprattutto per il trasporto della posta, del pane o di altri generi alimentari che dovevano essere spostati da un luogo all’altro o distribuiti ai clienti. In Italia vennero usate soprattutto per trasportare ghiaccio, gelati e grattachecche, ma anche per affilare coltelli e aggiustare suole: erano gli antenati dei moderni baracchini itineranti.
Partendo da questi due progetti, è stata costruita la maggior parte delle cargo bike attuali. Dalla Short John deriva la cargo progettata da Omnium, casa produttrice di Copenaghen, mentre dalla Long John deriva la cargo bike per eccellenza: la Bullitt. Grazie alla sua manovrabilità, efficacia, capienza e versatilità è senz’altro la bici cargo più diffusa in assoluto.
La casa produttrice più attiva sulla scena è sicuramente la danese Larry VS Harry. I nostri due scandinavi, di Copenaghen anche loro, ci hanno visto lungo: in un paese dove già era usanza diffusa possedere una cargo bike, sono stati capaci di migliorarla e renderla accessibile a tutti, tanto da diventare la casa produttrice numero uno d’Europa se non del mondo. A seguire posso citare la berlinese Pedalpower, che però non riesce a tenere testa ai colossi danesi, pur producendo il leggendario Long Harry: la cargo più lunga in commercio. In Italia ci pensa PandaBike a produrre le cargo, ma purtroppo, se già Pedalpower fatica a stare dietro a Larry VS Harry, PandaBike (nonostante la qualità dei suoi prodotti) non si avvicina minimamente ai numeri raggiunti dai due danesi.
Figura 3 Una foto che ho scattato da Larry VS Harry a Copenaghen.
Recandosi in uno qualsiasi dei punti vendita sparsi ormai in tutto il mondo o, più comodamente, visitando le pagine web dei costruttori, si può assemblare la propria cargo bike a piacimento. Si può scegliere il modello, il colore del telaio, il tipo di manubrio, la tipologia di sella e dei cerchi, di freni e cambio: insomma, una cargo diversa per ogni tipo di esigenza.
I telai sono praticamente tutti di allumino, materiale che permette di ottenere un buon compromesso di robustezza e leggerezza (il telaio di una Bullitt pesa 11,5 kg circa, comprensivi del del cavalletto). A causa del peso che sono destinate a sopportare, tutte le cargo sono dotate di un doppio freno a disco. Un mezzo del genere, caricato con svariati chili di merce, raggiunge velocità molto elevate e, di conseguenza, un’inerzia notevole. Per una maggiore sicurezza si ricorre quindi ai freni a disco che permettono di accorciare lo spazio di arresto (anche la Omnium, pur essendo molto più piccola e maneggevole di una Bullitt o di un Long Harry, viene assemblata con un freno a disco anteriore).
Detto questo potrebbe sembrare un’impresa impossibile smuovere bici del genere. Ovviamente la difficoltà nella conduzione aumenta in maniera proporzionale alla capienza della bici: una Omnium si guida molto più agevolmente di una Bullitt, è più leggera e scattante, ma non tollera il peso sopportato da quest’ultima e tantomeno da un Long Harry. Tuttavia anche questi ultimi due modelli sono molto più semplici da condurre di quanto si potrebbe pensare. Questo per due motivi principali: il primo è che sono muniti di un cambio molto morbido per partire da fermi, ma abbastanza duro per trasportare i pesanti carichi in piano. In genere si hanno due corone (da circa 36/22 denti) e una decina di pignoni: una trasmissione che potrebbe essere tranquillamente quella di una mountain-bike. Questo fa sì che chiunque possa usare una cargo senza fare troppa fatica;
il secondo motivo per cui risulta facile guidare una cargo è che, nonostante la ruota anteriore sia molto distante dal manubrio e quindi la reattività dello sterzo sia completamente diversa da quella di una qualsiasi bici, la forza centrifuga agisce su chi guida esattamente come ci si aspetterebbe. Al contrario dei tricicli per esempio, che in curva danno una strana sensazione di “sbalzo verso l’esterno”, le cargo permettono di affrontare le curve come con una qualsiasi bici classica, piegandosi leggermente verso l’interno e contrastando in questo modo la forza centrifuga. L’unica cosa per cui può essere necessaria un po’ di forza bruta è per sorreggerla quando si è fermi. L’importante è caricare la merce in modo equo, in modo da distribuire il peso in maniera omogenea così da non compromettere l’equilibrio della bici.
Potrei parlare ancora a lungo delle caratteristiche tecniche della Bullitt, ma qui di seguito preferisco concentrarmi su un fenomeno curioso che ho notato viaggiando. Ho avuto la fortuna di spostarmi molto, sia per lavoro che per piacere, e ho notato una differenza sostanziale tra l’utilizzo che si fa delle cargo bike in Italia e di quello che se ne fa invece all’estero.
In Italia è una realtà ancora molto circoscritta, tuttavia è una modalità di trasporto che lentamente sta prendendo piede. Sempre più società di trasporti ricorrono alle cargo bike come mezzo green ed ecosostenibile per consegnare la propria merce. Chi, come me, vive a Torino non può non averle notate: da GLS a TNT, da Cortilia a UPS, tutti ricorrono a qusto genere di bici. Non inquinano, non consumano benzina, sono rapide nel traffico, non subiscono limitazioni quali ZTL o aree pedonali e non si perde tempo a cercare parcheggio. Sembra davvero la soluzione definitiva per far fronte al traffico e all’inquinamento. Ogni società di bike messenger ne possiede una o più di una e sempre più spesso le grandi imprese di corrieri espressi ricorrono a soluzioni di questo genere per consegnare i loro pacchi, spesso affidando il compito proprio a società di bike messenger.
In Italia tutte le cargo che ho visto, che fossi a Torino, Milano, Bologna, Roma, appartengono a società di corrieri espressi in bicicletta. Spostandomi verso la penisola iberica la situazione era più o meno la stessa. La sorpresa l’ho avuta spostandomi invece nel nord Europa, nella penisola scandinava, in Danimarca, ma anche nei Paesi Bassi e in Germania, lì dove le cargo bike sono nate. Oltre che ad averne notato una quantità nettamente superiore a quelle adocchiate nella mia terra, ho appurato che la maggior parte di queste appartengono a privati. In questi paesi, come si può notare dalla quantità di piste ciclabili, la cultura della bicicletta è molto più radicata. Nonostante il prezzo elevato di una Bullitt (si parte da circa 1.800€ per il modello base), il clima e le condizioni atmosferiche non sempre favorevoli, nei paesi che ho citato sopra ho visto una quantità di cargo bike incredibile. Il fatto è che i privati non le utilizzano solo per trasportare oggetti: la maggior parte di queste viene usata per trasportare i propri figli o i propri animali. Oltre ai cassoni di alluminio per il trasporto di pacchi infatti, si può dotare la propria cargo di piccoli sedili, di selle aggiuntive sul tubo orizzontale del telaio e addirittura di vere e proprie cabine trasparenti a misura d’uomo (di plastica o tela cerata) nelle quali trasportare persone o animali con qualsiasi condizione meteo.
Credo che alla base di scelte simili ci sia una profonda differenza culturale tra il nostro paese e quelli nordici. Con l’avvento del motore nel dopoguerra, si è registrato un declino della bicicletta, in Italia come nel resto del mondo. La grande differenza è andata affermandosi però successivamente: mentre in Italia non c’è stata una vera e propria rinascita, in Danimarca la situazione è andata in tutt’altra direzione. I danesi si sono accorti molto presto di quanto fosse comodo l’uso della bicicletta a livello urbano e hanno lottato duramente, attraverso le critical mass[1], per riaffermare i diritti dei ciclisti, messi in pericolo dagli autoveicoli. In Italia questo processo non è avvenuto, o meglio, non con la stessa intensità. Nella patria della Piaggio e della Fiat i ciclisti sono rimasti relegati ai bordi di una strada dedicata alle auto. Il risultato è che molti di noi non riterrebbero sicuro trasportare i propri figli nel cassone di una cargo. E probabilmente lo penserebbero a ragione, ma non perché le cargo non siano sicure, ma perché non disponiamo di piste ciclabili né corsie preferenziali per le biciclette, nelle quali viaggiare in sicurezza. Senza contare l’esposizione allo smog a cui sottoporremmo i malcapitati che trasportiamo nel cassone: problema decisamente meno incisivo in città come Copenaghen, dove i veicoli a motore sono in numero molto inferiore rispetto a quelli a pedali. Inoltre immagino l’italiano medio che non ha voglia di fare fatica pedalando né tantomeno di investire cifre ragguardevoli per un mezzo ritenuto “scomodo”, ormai abituati ai morbidi sedili della propria automobile. E credo che sia proprio qui la differenza culturale: semplicemente non ci si è ancora accorti, al contrario di ciò che è avvenuto nei paesi nordici, di quanto invece sia più comodo, ecologico e conveniente (a livello di spese e di tempo impiegato) spostarsi a livello urbano con una cargo bike rispetto ad un’automobile. E’ come se non avessimo sviluppato una solida coscienza ambientalista o forse facciamo solo fatica ad abbandonare le vecchie e comode cattive abitudini. Mentre, come si può leggere nella pagina principale del sito di Larry VS Harry, i danesi hanno capito cos’è veramente comodo (e lo hanno capito molto prima di noi):
“As Copenhageners, Larry and Harry have always biked as much as they could. Not just because it was green, cool or cheap, but because it was – is – the fastest, most convenient way to get around town”[2].
Alleycat - Adrenalina e Asfalto
Scritto da Nicola MuratoreIn questo articolo vi introdurrò nel mondo delle alleycat, un fenomeno la cui notorietà è inversamente proporzionale alla proprietà aggregativa: sempre più persone sanno che cos’è, sempre meno vi partecipano. L’organizzazione di queste gare è in continuo calo.
Ma: un passo per volta.
Le alleycat (testualmente “gatto dei vicoli” e quindi gatto randagio) sono gare clandestine in bicicletta. Hanno poche regole e un alto tasso adrenalinico. Ma chi le organizza? Come si fa a sapere quando ce n’è una e parteciparvi? Sono tutti dubbi legittimi su cui si può arrovellare chi si sta avvicinando al mondo della bicicletta.
Le alleycat sono gare che imitano il lavoro dei corrieri espressi in bicicletta. Al corriere, normalmente, durante la giornata lavorativa, vengono assegnate delle corse che consistono nel prelevare in un luogo X un pacco, e trasportarlo nel minor tempo possibile in un luogo Y: più si è veloci e più aumentano le possibilità di ricevere corse ulteriori (e di conseguenza di gonfiare il portafogli). Le alleycat simulano proprio questo. All’inizio della gara ai partecipanti viene consegnato il cosiddetto manifest, ovvero il foglio con su scritti gli indirizzi da raggiungere. L’ordine è casuale ed è compito del concorrente elaborare il percorso più breve per raggiungere gli indirizzi, detti checkpoint. Generalmente, per rendere ancora più verosimile la simulazione, i checkpoint sono divisi tra prese e consegne (pick e drop). Va da sé che le prese debbano essere fatte obbligatoriamente prima delle consegne. A controllare che tutto venga eseguito senza barare ci sono i checkers, ovvero persone che verificano il passaggio dei concorrenti al checkpoint attraverso un timbro apposto sul manifest. Presso questi punti, inoltre, per rendere la competizione più difficile, ai concorrenti possono essere imposte prove di forza e/o abilità: tutto è concesso; tutto dipende dalla cattiveria e dal sadismo di chi ha organizzato la gara. Ho visto concorrenti sudati infilare la testa in sacchi di farina o trasportare uova da un checkpoint all’altro.
A un’alleycat si può partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta. La maggior parte delle volte vengono stilate classifiche separate per le differenti tipologie. Le grandi categorie in cui si è soliti dividere una classifica sono bici da corsa e bici fisse senza freni. Questo perché la prestazione di un ciclista è pesantemente vincolata alla bicicletta che utilizza (dalla presenza o meno del cambio, dalla tipologia di pignone, ecc). Generalmente viene premiato il primo che in assoluto taglia il traguardo; poi il primo che lo taglia con una bicicletta fissa e senza freni; poi chi non corre nella propria città di appartenenza (ed è quindi svantaggiato, detto out of town). Qualche volta si premia la prima donna e il secondo e terzo assoluto.
Come dicevo in precedenza le alleycat sono clandestine. Nessun comune darebbe mai l’autorizzazione per delle gare così pericolose per se stessi e per gli altri. Non si contano infatti le regole della strada infrante durante una gara del genere pur di vincere. Semafori rossi bruciati, precedenze rubate, strade imboccate contromano, zone pedonali violate a velocità folli, sono solo alcune delle innumerevoli infrazioni commesse durante un’alleycat. Senza contare i limiti di velocità a cui nessuno fa caso e ai rischi che comporta liberare un branco di ciclisti in mezzo al traffico, mossi dalla sete di gloria e dalla ricerca di adrenalina.
Perché si corrono gare di questo tipo? In primo luogo perché è l’unico modo per testare la velocità e l’abilità di un corriere. In una situazione protetta, come può essere un circuito, si misurano solo determinate attitudini del corriere e il risultato sarebbe distorto. Il suo vero valore va misurato in mezzo al traffico, dove sono presenti tutte le reali difficoltà del mestiere. Chi è più veloce, chi si orienta meglio, chi sa destreggiarsi meglio nel traffico vince la gara. Dubito che il campione olimpionico in velodromo arriverebbe tra i primi dieci ad un’alleycat (e viceversa ovviamente). In secondo luogo credo che in nessun’altra gara l’adrenalina raggiunga livelli così alti. Le alleycat sono senza ombra di dubbio le gare più rischiose che si corrano in bici, ma, allo stesso tempo più gratificanti per un corriere espresso.
Detto questo è palese perché nessuno si voglia accollare la responsabilità di organizzare un evento del genere. Per questo gli escamotage sono parecchi. Innanzitutto nessuno obbliga i partecipanti ad adottare una guida spericolata né, tantomeno, viene imposta la violazione delle normali leggi del codice della strada: insomma, se ci si vuole fermare ai rossi lo si può fare. La responsabilità è affidata al singolo concorrente. Chi organizza la gara deve essere tutelato e quindi “proporrà un allenamento che ognuno imposterà come meglio crede”. Anche il luogo di ritrovo spesso viene comunicato all’ultimo minuto attraverso passaparola o eventi caricati sul web, con il tentativo di passare inosservati agli occhi di osservatori scomodi.
Come dicevo all’inizio il fenomeno delle alleycat è sempre più sotto gli occhi di tutti, probabilmente per l’interesse sempre crescente nei confronti delle biciclette a scatto fisso[1]. Addirittura, nel 2016, è uscito un film incentrato proprio su questo tema.
Data la delusione di un altro film riguardante i corrieri espressi in bicicletta (Premium Rush, ndr) non mi aspetto nulla da quest’ultimo, rappresentazione inflazionata in perfetto stile hollywoodiano della realtà. Trovo tuttavia interessante che un fenomeno così underground e che tendenzialmente dovrebbe rimanere celato, abbia invece così tanta risonanza, tanto da farne un film. Parecchi anni fa difficilmente si trovavano informazioni come oggi sulle alleycat. Il paradosso tuttavia è che sempre meno persone vi partecipano e sempre meno viaggiano alla ricerca dell’alleycat più vicina. Forse è proprio a causa dello sdoganamento a cui si è giunti?
Alcuni manifest e spoke card di diverse alleycat. Le spoke card (cartoline per i raggi) sono le cartoline che vengono rilasciate al momento dell’iscrizione, con indicato il numero partecipativo. Vengono chiamate così perché tendenzialmente i partecipanti le incastrano tra i raggi della propria bici e spesso le conservano come trofei per mostrare il numero delle alleycat alle quali hanno partecipato.

Convertire una bici
Scritto da Nicola MuratoreUltimamente mi è capitato più di volta che una persona mi chiedesse un parere sulle cosiddette “convertite”. Ho deciso quindi di approfittare della disponibilità che mi ha offerto Jona Editore e sfruttare questo spazio per affrontare la discussione in modo che chiunque abbia la possibilità di farsi un’idea a riguardo.
Innanzitutto con il termine “convertita”, nel mondo delle fisse, si intende definire tutte quelle biciclette che sono nate come bici da corsa/strada, ma che poi sono state appunto convertite in biciclette con il pignone fisso.
La prima domanda che farei a chi vuole convertire la propria bici in una fissa è: che cosa ne vuoi fare? Se la risposta è “correre in pista o in circuito” io lo sconsiglio vivamente. Le geometrie di un telaio da pista sono diverse da un telaio da corsa, hanno tolleranze diverse, nascono per scopi diversi. Sarebbe come dire “devo fare uno sterrato in montagna quindi invece di usare una mountain bike prendo una bici da passeggio e la trasformo in una mountain bike”. Non ha senso: lasciate proprio perdere. Conviene ovviamente usare una bici che nasce per lo scopo che si persegue.
Convertire una bici con la ruota libera in una fissa può avere senso se si ha intenzione di usarla a livello cittadino. Chi possiede una vecchia bici, magari con cambio o freni rotti, potrebbe avere il desiderio di convertirla in una fissa. Anche in questo caso ci sono però delle controindicazioni.
La prima: come dicevo prima le geometrie di un telaio da corsa sono diverse da quelle di un telaio da pista. In una convertita il movimento centrale sarà basso come in un telaio da corsa, ma le pedivelle continueranno a girare anche in curva. Sarà impossibile o quantomeno pericoloso affrontare le curve in piega senza che le pedivelle tocchino il suolo.
Secondo problema: la direzione dei forcellini. In un telaio da corsa i forcellini sono verticali o obliqui mentre in un telaio da pista sono orizzontali. Questo perché in un telaio da corsa non è necessario tendere la catena (ci pensa il sistema di deragliatori), mentre in una fissa sì. Tuttavia in una convertita tendere la catena potrebbe risultare problematico in quanto i forcellini da corsa difficilmente lo permettono.
Terzo problema: i componenti. I componenti da pista sono diversi da quelli da strada. Questo perché gli uni sono sollecitati in maniera completamente diversa rispetto agli altri. Per l’incolumità del ciclista sarebbe bene non usare gli uni al posto degli altri.
Tutti questi temi vengono sviscerati in maniera più precisa nel libro. In questa sede vorrei solo mettere in guardia il lettore, in modo che prenda le dovute precauzioni prima di lanciarsi nella conversione della propria bici.
Alla prossima!










